
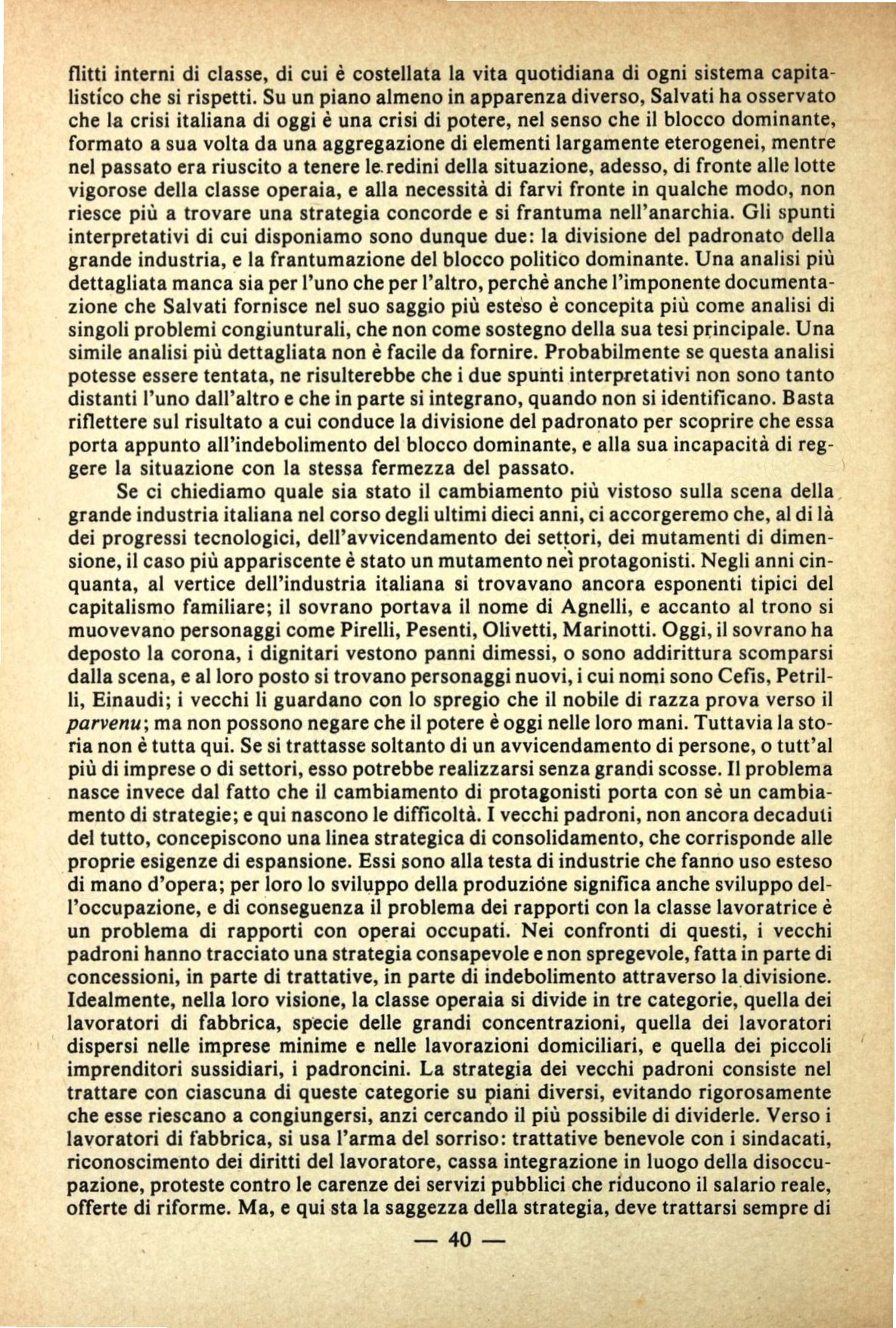
flitti interni di classe, di cui è costellata la vita quotidiana di ogni sistema capita-
listico che si rispetti. Su un piano almeno in apparenza diverso, Salvati ha osservato
che la crisi italiana di oggi è una crisi di potere, nel senso che il blocco dominante,
formato a sua volta da una aggregazione di elementi largamente eterogenei, mentre
nel passato era riuscito a tenere le. redini della situazione, adesso, di fronte alle lotte
vigorose della classe operaia, e alla necessità di farvi fronte in qualche modo, non
riesce più a trovare una strategia concorde e si frantuma nell'anarchia. Gl i spunti
interpretativi di cui disponiamo sono dunque due: la divisione del padronato della
grande industria, e la frantumazione del blocco politico dominante. Una analisi più
dettagliata manca sia per l'uno che per l'altro, perchè anche l'imponente documenta-
zione che Salvati fornisce nel suo saggio più esteso è concepita più come analisi di
singoli problemi congiunturali, che non come sostegno della sua tesi principale. Una
simile analisi più dettagliata non è facile da fornire. Probabilmente se questa analisi
potesse essere tentata, ne risulterebbe che i due spunti interpretativi non sono tanto
distanti l'uno dall'altro e che in parte si integrano, quando non si identificano. Basta
riflettere sul risultato a cui conduce la divisione del padronato per scoprire che essa
porta appunto all'indebolimento del blocco dominante, e alla sua incapacità di reg-
gere la situazione con la stessa fermezza del passato.
Se ci chiediamo quale sia stato i l cambiamento più vistoso sulla scena della
grande industria italiana nel corso degli ultimi dieci anni, ci accorgeremo che, al di là
dei progressi tecnologici, dell'avvicendamento dei settori, dei mutamenti di dimen-
sione, il caso più appariscente è stato un mutamento neí protagonisti. Negli anni cin-
quanta, al vertice dell'industria italiana si trovavano ancora esponenti tipici del
capitalismo familiare; i l sovrano portava il nome di Agnelli, e accanto al trono si
muovevano personaggi come Pirelli, Pesenti, Olivetti, Marinotti. Oggi, il sovrano ha
deposto la corona, i dignitari vestono panni dimessi, o sono addirittura scomparsi
dalla scena, e al loro posto si trovano personaggi nuovi, i cui nomi sono Cefis, Petril-
li, Einaudi; i vecchi li guardano con lo spregio che il nobile di razza prova verso il
parvenu;
ma non possono negare che il potere è oggi nelle loro mani. Tuttavia la sto-
ria non è tutta qui. Se si trattasse soltanto di un avvicendamento di persone, o tutt'al
più di imprese o di settori, esso potrebbe realizzarsi senza grandi scosse. Il problema
nasce invece dal fatto che il cambiamento di protagonisti porta con sè un cambia-
mento di strategie; e qui nascono le difficoltà. I vecchi padroni, non ancora decaduti
del tutto, concepiscono una linea strategica di consolidamento, che corrisponde alle
proprie esigenze di espansione. Essi sono alla testa di industrie che fanno uso esteso
di mano d'opera; per loro lo sviluppo della produzióne significa anche sviluppo del-
l'occupazione, e di conseguenza il problema dei rapporti con la classe lavoratrice è
un problema di rapporti con operai occupati. Nei confronti di questi, i vecchi
padroni hanno tracciato una strategia consapevole e non spregevole, fatta in parte di
concessioni, in parte di trattative, in parte di indebolimento attraverso la divisione.
Idealmente, nella loro visione, la classe operaia si divide in tre categorie, quella dei
lavoratori d i fabbrica, specie delle grandi concentrazioni, quella dei lavoratori
dispersi nelle imprese minime e nelle lavorazioni domiciliari, e quella dei piccoli
imprenditori sussidiari, i padroncini. La strategia dei vecchi padroni consiste nel
trattare con ciascuna di queste categorie su piani diversi, evitando rigorosamente
che esse riescano a congiungersi, anzi cercando il più possibile di dividerle. Verso i
lavoratori di fabbrica, si usa l'arma del sorriso: trattative benevole con i sindacati,
riconoscimento dei diritti del lavoratore, cassa integrazione in luogo della disoccu-
pazione, proteste contro le carenze dei servizi pubblici che riducono il salario reale,
offerte di riforme. Ma, e qui sta la saggezza della strategia, deve trattarsi sempre di
40
















