
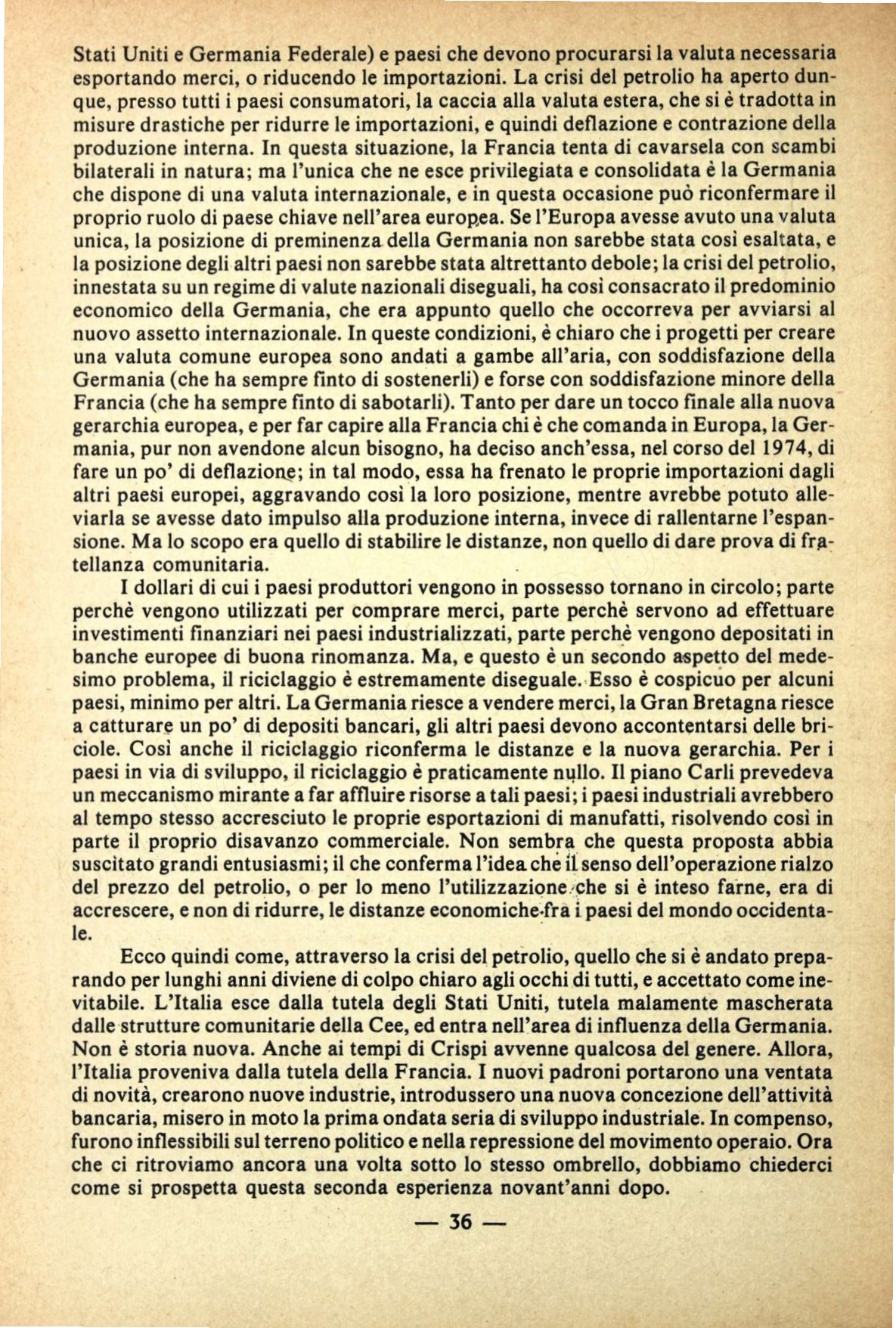
Stati Uniti e Germania Federale) e paesi che devono procurarsi la valuta necessaria
esportando merci, o riducendo le importazioni. La crisi del petrolio ha aperto dun-
que, presso tutti i paesi consumatori, la caccia alla valuta estera, che si è tradotta in
misure drastiche per ridurre le importazioni, e quindi deflazione e contrazione della
produzione interna. In questa situazione, la Francia tenta di cavarsela con scambi
bilaterali in natura; ma l'unica che ne esce privilegiata e consolidata è la Germania
che dispone di una valuta internazionale, e in questa occasione può riconfermare il
proprio ruolo di paese chiave nell'area europea. Se l'Europa avesse avuto una valuta
unica, la posizione di preminenza della Germania non sarebbe stata così esaltata, e
la posizione degli altri paesi non sarebbe stata altrettanto debole; la crisi del petrolio,
innestata su un regime di valute nazionali diseguali, ha così consacrato il predominio
economico della Germania, che era appunto quello che occorreva per avviarsi al
nuovo assetto internazionale. In queste condizioni, è chiaro che i progetti per creare
una valuta comune europea sono andati a gambe all'aria, con soddisfazione della
Germania (che ha sempre finto di sostenerli) e forse con soddisfazione minore della
Francia (che ha sempre finto di sabotarli). Tanto per dare un tocco finale alla nuova
gerarchia europea, e per far capire alla Francia chi è che comanda in Europa, la Ger-
mania, pur non avendone alcun bisogno, ha deciso anch'essa, nel corso del 1974, di
fare un po di deflazione; in tal modo, essa ha frenato le proprie importazioni dagli
altri paesi europei, aggravando così la loro posizione, mentre avrebbe potuto alle-
viarla se avesse dato impulso alla produzione interna, invece di rallentarne l'espan-
sione. Ma lo scopo era quello di stabilire le distanze, non quello di dare prova di fra-
tellanza comunitaria.
I dollari di cui i paesi produttori vengono in possesso tornano in circolo; parte
perchè vengono utilizzati per comprare merci, parte perché servono ad effettuare
investimenti finanziari nei paesi industrializzati, parte perché vengono depositati in
banche europee di buona rinomanza. Ma, e questo è un secondo aspetto del mede-
simo problema, il riciclaggio è estremamente diseguale. Esso è cospicuo per alcuni
paesi, minimo per altri. La Germania riesce a vendere merci, la Gran Bretagna riesce
a catturare un po' di depositi bancari, gli altri paesi devono accontentarsi delle bri-
ciole. Così anche i l riciclaggio riconferma le distanze e la nuova gerarchia. Per i
paesi in via di sviluppo, il riciclaggio è praticamente ntillo. I l piano Carli prevedeva
un meccanismo mirante a far affluire risorse a tali paesi; i paesi industriali avrebbero
al tempo stesso accresciuto le proprie esportazioni di manufatti, risolvendo così in
parte i l proprio disavanzo commerciale. Non sembra che questa proposta abbia
suscitato grandi entusiasmi; il che conferma l'idea ché il senso dell'operazione rialzo
del prezzo del petrolio, o per lo meno l'utilizzazione .che si è inteso farne, era di
accrescere, e non di ridurre, le distanze economiche•fra i paesi del mondo occidenta-
le.
Ecco quindi come, attraverso la crisi del petrolio, quello che si è andato prepa-
rando per lunghi anni diviene di colpo chiaro agli occhi di tutti, e accettato come ine-
vitabile. L' I tal ia esce dalla tutela degli Stati Uniti, tutela malamente mascherata
dalle strutture comunitarie della Cee, ed entra nell'area di influenza della Germania.
Non è storia nuova. Anche ai tempi di Crispi avvenne qualcosa del genere. Allora,
l'Italia proveniva dalla tutela della Francia. I nuovi padroni portarono una ventata
di novità, crearono nuove industrie, introdussero una nuova concezione dell'attività
bancaria, misero in moto la prima ondata seria di sviluppo industriale. In compenso,
furono inflessibili sul terreno politico e nella repressione del movimento operaio.
Ora
che ci ritroviamo ancora una volta sotto lo stesso ombrello, dobbiamo chiederci
come si prospetta questa seconda esperienza novant'anni dopo.
36
















