
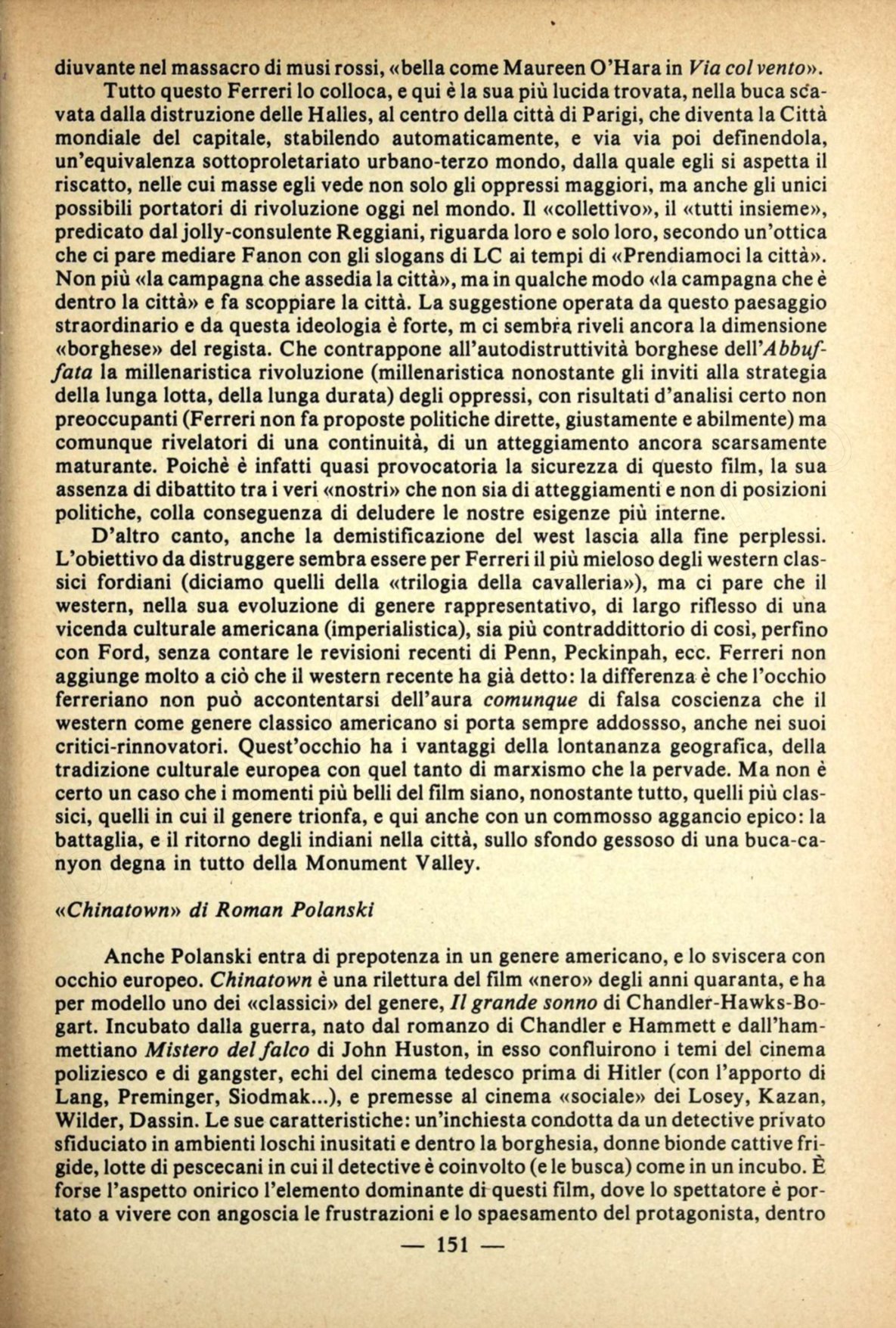
diuvante nelmassacro di musi rossi, «bella comeMaureen O'Hara in
Via col vento».
Tutto questo Ferreri lo colloca, equi è la sua più lucida trovata, nella bucasCa-
vata dalla distruzione delle Halles, al centro della città di Parigi, che diventa la Città
mondiale del capitale, stabilendo automaticamente, e via via poi definendola,
un'equivalenza sottoproletariato urbano-terzo mondo, dalla quale egli si aspetta il
riscatto, nelle cui masse egli vede non solo gli oppressi maggiori, ma anche gli unici
possibili portatori di rivoluzione oggi nel mondo. Il «collettivo», il «tutti insieme»,
predicato dal jolly-consulente Reggiani, riguarda loro esolo loro, secondo un'ottica
checi pare mediare Fanon con gli slogans di LC ai tempi di «Prendiamoci la città».
Non più «la campagnacheassedia la città», ma inqualchemodo «la campagnacheè
dentro la città» e fa scoppiare la città. La suggestione operata da questopaesaggio
straordinario e da questa ideologia è forte, m ci sembra riveli ancora la dimensione
«borghese» del regista. Che contrappone all'autodistruttività borghese
dell'Abbuf-
fata
la millenaristica rivoluzione (millenaristica nonostante gli inviti alla strategia
della lunga lotta, della lunga durata) degli oppressi, con risultati d'analisi certo non
preoccupanti (Ferreri non fa proposte politiche dirette, giustamente e abilmente) ma
comunque rivelatori di una continuità, di un atteggiamento ancora scarsamente
maturante. Poiché è infatti quasi provocatoria la sicurezza di questo film, la sua
assenza di dibattito tra i veri «nostri» chenon sia di atteggiamenti enon di posizioni
politiche, colla conseguenza di deludere le nostre esigenze più interne.
D'altro canto, anche la demistificazione del west lascia alla fine perplessi.
L'obiettivo da distruggere sembraessereper Ferreri il piùmielosodegli western clas-
sici fordiani (diciamo quelli della «trilogia della cavalleria»), ma ci pare che il
western, nella sua evoluzione di genere rappresentativo, di largo riflesso di una
vicenda culturale americana (imperialistica), sia più contraddittorio di così, perfino
con Ford, senza contare le revisioni recenti di Penn, Peckinpah, ecc. Ferreri non
aggiungemolto a ciò che il western recente ha già detto: la differenza è che l'occhio
ferreriano non può accontentarsi dell'aura
comunque
di falsa coscienza che il
western come genere classico americano si porta sempre addossso, anche nei suoi
critici-rinnovatori. Quest'occhio ha i vantaggi della lontananza geografica, della
tradizione culturale europea con quel tanto di marxismo che la pervade. Ma non è
certo un casoche i momenti più belli del film siano, nonostante tutto, quelli più clas-
sici, quelli in cui il genere trionfa, e qui anche con un commossoaggancio epico: la
battaglia, e il ritorno degli indiani nella città, sullo sfondogessoso di una buca-ca-
nyon degna in tutto della Monument Valley.
«Chinatown» di Roman Polanski
Anche Polanski entra di prepotenza in un genere americano, e lo sviscera con
occhio europeo.
Chinatown
è una rilettura del film «nero» degli anni quaranta, e ha
permodello uno dei «classici» del genere,
I l grande sonno
di Chandler-Hawk s-Bo-
gart. Incubato dalla guerra, nato dal romanzo di Chandler e Hammen e dall'ham-
mettiano
Mistero del falco
di John Huston, in esso confluirono i temi del cinema
poliziesco e di gangster, echi del cinema tedesco prima di Hitler (con l'apporto di
Lang, Preminger, Siodmak...), e premesse al cinema «sociale» dei Losey, Kazan,
Wilder, Dassin. Le sue caratteristiche: un'inchiesta condotta daundetective privato
sfiduciato in ambienti loschi inusitati edentro la borghesia, donnebionde cattive fri-
gide, lotte di pescecani in cui il detectiveècoinvolto (e lebusca) come inun incubo. È
forse l'aspetto onirico l'elemento dominante di questi film, dove lo spettatore è por-
tato a vivere con angoscia le frustrazioni e lo spaesamentodel protagonista, dentro
151
















