
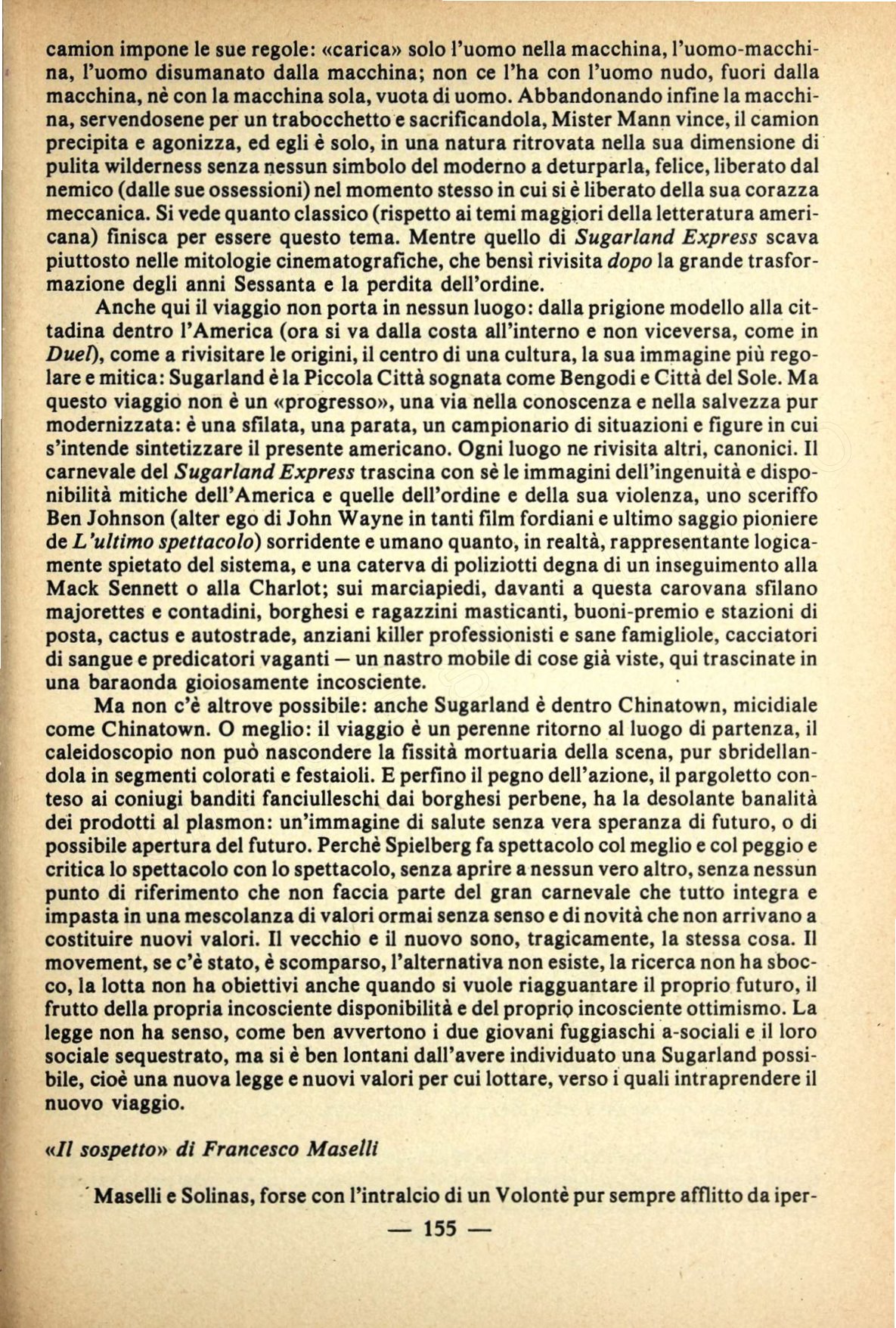
camion impone le sue regole: «carica» solo l'uomo nella macchina, l'uomo-macchi-
na, l'uomo disumanato dalla macchina; non ce l'ha con l'uomo nudo, fuori dalla
macchina, necon la macchina sola, vuota di uomo. Abbandonando infine lamacchi-
na, servendoseneper un trabocchettoe sacrificandola, Mister Mann vince, il camion
precipita e agonizza, ed egli è solo, in una natura ritrovata nella sua dimensione di
pulita wilderness senzanessunsimbolo del moderno a deturparla, felice, liberato dal
nemico (dalle sueossessioni) nelmomentostesso in cui siè liberato della sua corazza
meccanica. Si vede quanto classico (rispetto ai temi maggiori della letteratura ameri-
cana) finisca per essere questo tema. Mentre quello di
Sugarland Express
scava
piuttosto nelle mitologie cinematografiche, chebensì rivisita
dopo
la grande trasfor-
mazione degli anni Sessanta e la perdita dell'ordine.
Anche qui il viaggio non porta in nessun luogo: dalla prigionemodello alla cit-
tadina dentro l'America (ora si va dalla costa all'interno e non viceversa, come in
Due!),
come a rivisitare le origini, il centro di una cultura, la sua immagine più rego-
lareemitica: Sugarlandè la Piccola Città sognatacomeBengodi e Città del Sole. Ma
questo viaggio non è un «progresso», una via nella conoscenzae nella salvezza pur
modernizzata: è una sfilata, una parata, un campionario di situazioni e figure in cui
s'intende sintetizzare il presente americano. Ogni luogo ne rivisita altri, canonici. Il
carnevale del
Sugarland Express
trascina consè le immagini dell'ingenuità edispo-
nibilità mitiche dell'America e quelle dell'ordine e della sua violenza, uno sceriffo
BenJohnson (alter ego di JohnWayne in tanti film fordiani e ultimo saggio pioniere
de
L'ultimo spettacolo)
sorridente eumano quanto, in realtà, rappresentante logica-
mente spietato del sistema, e una caterva di poliziotti degna di un inseguimento alla
Mack Sennett o alla Charlot; sui marciapiedi, davanti a questa carovana sfilano
majorettes e contadini, borghesi e ragazzini masticanti, buoni-premio e stazioni di
posta, cactus e autostrade, anziani killer professionisti e sane famigliole, cacciatori
di sanguee predicatori vaganti—un nastromobile di cosegià viste, qui trascinate in
una baraonda gioiosamente incosciente.
Ma non c'è altrove possibile: anche Sugarland è dentro C hinatown, micidiale
comeChinatown. O meglio: il viaggio è un perenne ritorno al luogo di partenza, il
caleidoscopio non può nascondere la fissità mortuaria della scena, pur sbridellan-
dola in segmenti colorati e festaioli. E perfino il pegno dell'azione, il pargoletto con-
teso ai coniugi banditi fanciulleschi dai borghesi perbene, ha la desolante banalità
dei prodotti al plasmon: un'immagine di salute senza vera speranza di futuro, o di
possibile apertura del futuro. Perchè Spielberg fa spettacolo col meglioecol peggioe
critica lo spettacolo con lo spettacolo, senza aprire anessunvero altro, senzanessun
punto di riferimento che non faccia parte del gran carnevale che tutto integra e
impasta in unamescolanza di valori ormai senzasensoedi novità chenon arrivano a
costituire nuovi valori. Il vecchio e il nuovo sono, tragicamente, la stessa cosa. Il
movement, sec'è stato, èscomparso, l'alternativa nonesiste, la ricerca nonha sboc-
co, la lotta non ha obiettivi anche quando si vuole riagguantare il proprio futuro, il
frutto della propria incosciente disponibilità edel proprio incosciente ottimismo. La
leggenon ha senso, come ben avvertono i due giovani fuggiaschi a-sociali e il loro
sociale sequestrato, ma si èben lontani dall'avere individuato una Sugarland possi-
bile, cioè una nuova leggee nuovi valori per cui lottare, verso i quali intraprendere il
nuovo viaggio.
«Il sospetto» di Francesco Maselli
Maselli eSolinas, forse con l'intralcio di un Volontè pur sempre afflitto da iper-
155
















