
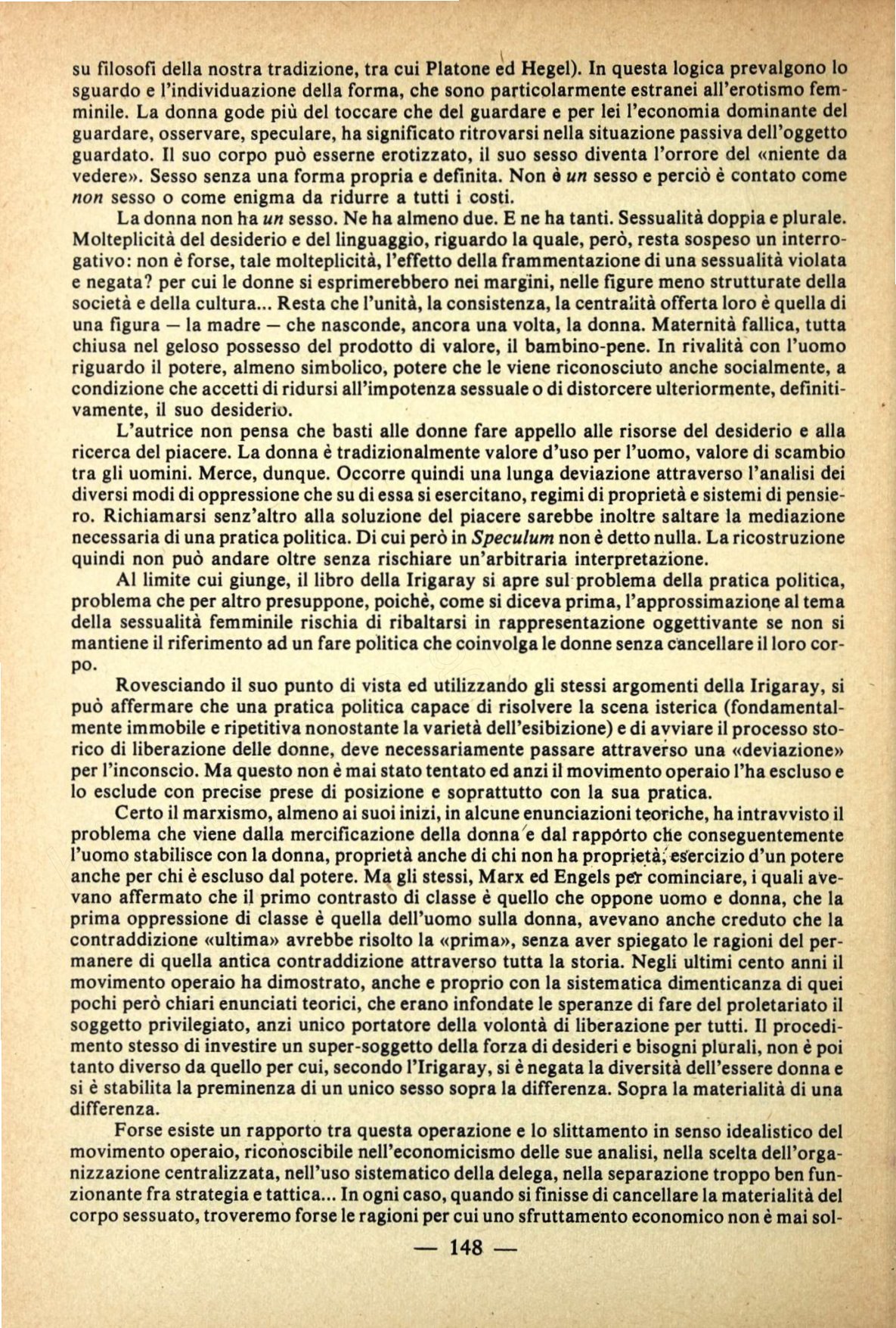
su filosofi della nostra tradizione, tra cui Platone ed Hegel). In questa logica prevalgono lo
sguardo e l'individuazione della forma, che sono particolarmente estranei all'erotismo fem-
minile. La donna gode più del toccare che del guardare e per lei l'economia dominante del
guardare, osservare, speculare, ha significato ritrovarsi nella situazione passiva dell'oggetto
guardato. I l suo corpo può esserne erotizzato, il suo sesso diventa l'orrore del «niente da
vedere». Sesso senza una forma propria e definita. Non è
un
sesso e perciò è contato come
non
sesso o come enigma da ridurre a tutti i costi.
La donna non ha
un
sesso. Ne ha almeno due. E ne ha tanti. Sessualità doppia e plurale.
Molteplicità del desiderio e del linguaggio, riguardo la quale, però, resta sospeso un interro-
gativo: non è forse, tale molteplicità, l'effetto della frammentazione di una sessualità violata
enegata? per cui le donne si esprimerebbero nei margini, nelle figure meno strutturate della
società e della cultura... Resta che l'unità, la consistenza, la centralità offerta loro è quella di
una figura— la madre—che nasconde, ancora una volta, la donna. Maternità fallica, tutta
chiusa nel geloso possesso del prodotto di valore, il bambino-pene. In rivalità con l'uomo
riguardo il potere, almeno simbolico, potere che le viene riconosciuto anche socialmente, a
condizione che accetti di ridursi all'impotenza sessuale o di distorcere ulteriormente, definiti-
vamente, il suo desiderio.
L'autrice non pensa che basti alle donne fare appello alle risorse del desiderio e alla
ricerca del piacere. La donna è tradizionalmente valore d'uso per l'uomo, valore di scambio
tra gli uomini. Merce, dunque. Occorre quindi una lunga deviazione attraverso l'analisi dei
diversi modi di oppressione che su di essa si esercitano, regimi di proprietà e sistemi di pensie-
ro. Richiamarsi senz'altro alla soluzione del piacere sarebbe inoltre saltare la mediazione
necessaria di una pratica politica. Di cui però in
Speculum
non è detto nulla. La ricostruzione
quindi non può andare oltre senza rischiare un'arbitraria interpretazione.
Al limite cui giunge, il libro della Irigaray si apre sul problema della pratica politica,
problema che per altro presuppone, poichè, come si diceva prima, l'approssimazione al tema
della sessualità femminile rischia di ribaltarsi in rappresentazione oggettivante se non si
mantiene il riferimento ad un fare politica che coinvolga le donne senza cancellare il loro cor-
po.
Rovesciando il suo punto di vista ed utilizzando gli stessi argomenti della Irigaray, si
può affermare che una pratica politica capace di risolvere la scena isterica (fondamental-
mente immobile e ripetitiva nonostante la varietà dell'esibizione) e di avviare il processo sto-
rico di liberazione delle donne, deve necessariamente passare attraverso una «deviazione»
per l'inconscio. Ma questo non èmai stato tentato ed anzi il movimento operaio l'ha esclusoe
lo esclude con precise prese di posizione e soprattutto con la sua pratica.
Certo il marxismo, almeno ai suoi inizi, in alcune enunciazioni teoriche, ha intravvisto il
problema che viene dalla mercificazione della donna e dal rapporto che conseguentemente
l'uomo stabilisce con la donna, proprietà anche di chi non ha proprietà,' essercizio d'un potere
anche per chi è escluso dal potere. Ma gli stessi, Marx ed Engels per cominciare, i quali ave-
vano affermato che il primo contrasto di classe è quello che oppone uomo e donna, che la
prima oppressione di classe è quella dell'uomo sulla donna, avevano anche creduto che la
contraddizione «ultima» avrebbe risolto la «prima», senza aver spiegato le ragioni del per-
manere di quella antica contraddizione attraverso tutta la storia. Negli ultimi cento anni il
movimento operaio ha dimostrato, anche e proprio con la sistematica dimenticanza di quei
pochi però chiari enunciati teorici, che erano infondate le speranze di fare del proletariato il
soggetto privilegiato, anzi unico portatore della volontà di liberazione per tutti. Il procedi-
mento stesso di investire un super-soggetto della forza di desideri e bisogni plurali, non è poi
tanto diverso da quello per cui, secondo l'Irigaray, si è negata la diversità dell'essere donna e
si è stabilita la preminenza di un unico sesso sopra la differenza. Sopra la materialità di una
differenza.
Forse esiste un rapporto tra questa operazione e lo slittamento in senso idealistico del
movimento operaio, riconoscibile nell'economicismo delle sue analisi, nella scelta dell'orga-
nizzazione centralizzata, nell'uso sistematico della delega, nella separazione troppo ben fun-
zionante fra strategia e tattica... In ogni caso, quando si finisse di cancellare la materialità del
corpo sessuato, troveremo forse le ragioni per cui uno sfruttamento economico nonèmai sol-
148
















