
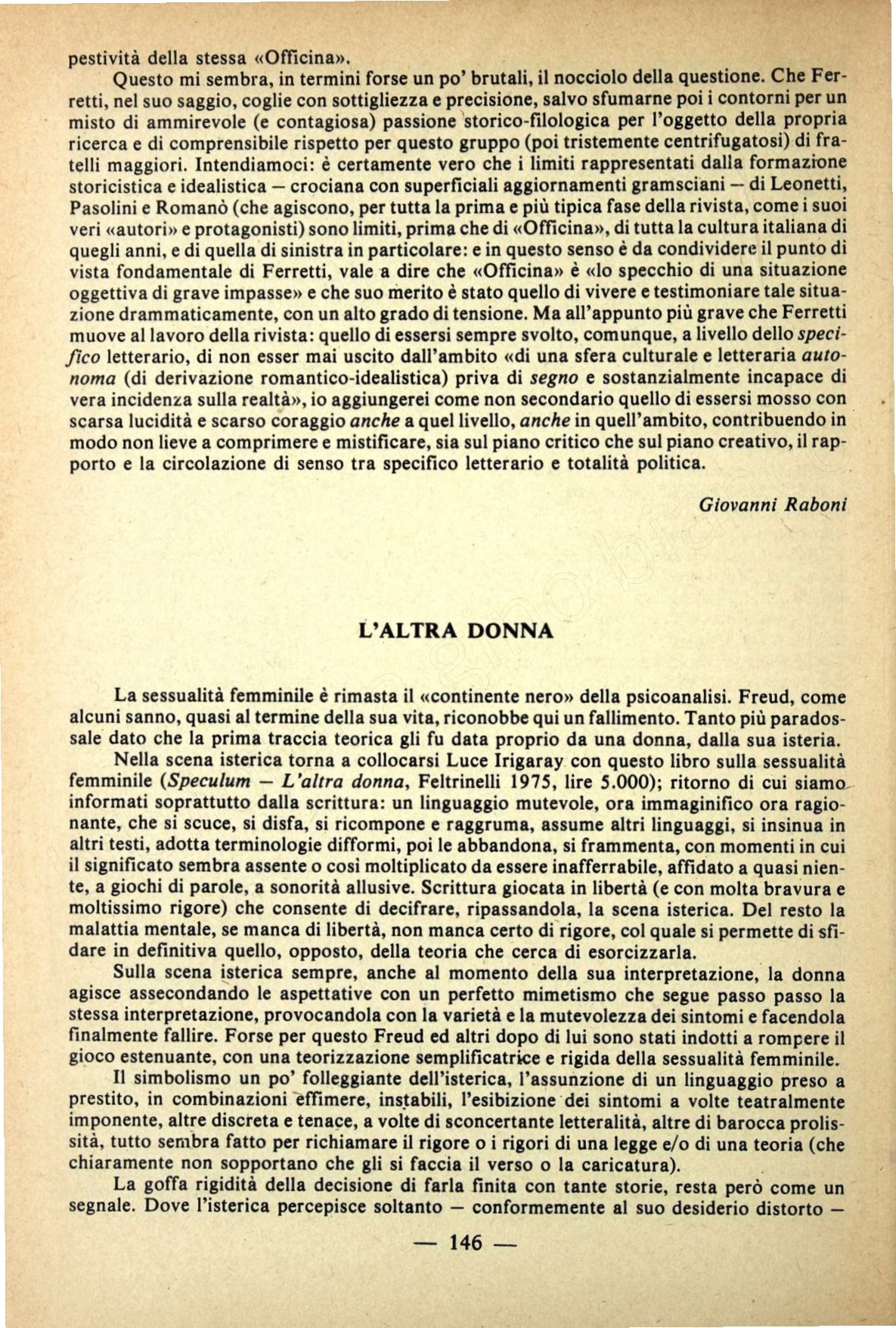
pestività della stessa «Officina».
Questo mi sembra, in termini forse un po' brutali, il nocciolo della questione. Che Fer-
retti, nel suo saggio, coglie con sottigliezza e precisione, salvo sfumarne poi i contorni per un
misto di ammirevole (e contagiosa) passione storico-filologica per l'oggetto della propria
ricerca e di comprensibile rispetto per questo gruppo (poi tristemente centrifugatosi) di fra-
telli maggiori. Intendiamoci: è certamente vero che i limiti rappresentati dalla formazione
storicistica e idealistica—crociana con superficiali aggiornamenti gramsciani -- di Leonetti,
Pasolini e Romanò (che agiscono, per tutta la prima e più tipica fase della rivista, come i suoi
veri «autori» e protagonisti) sono limiti, prima che di «Officina», di tutta la cultura italiana di
quegli anni, e di quella di sinistra in particolare: e in questo senso è da condividere il punto di
vista fondamentale di Ferretti, vale a dire che «Officina» è «lo specchio di una situazione
oggettiva di grave impasse» e che suo merito è stato quello di vivere e testimoniare tale situa-
zione drammaticamente, con un alto grado di tensione. Ma all'appunto più grave che Ferretti
muove al lavoro della rivista: quello di essersi sempre svolto, comunque, a livello dello
speci-
fico
letterario, di non esser mai uscito dall'ambito «di una sfera culturale e letteraria
auto-
noma
(di derivazione romantico-idealistica) priva di
segno
e sostanzialmente incapace di
vera incidenza sulla realtà», io aggiungerei come non secondario quello di essersi mosso con
scarsa lucidità e scarso coraggio
anche
a quel livello,
anche
in quell'ambito, contribuendo in
modo non lieve a comprimere e mistificare, sia sul piano critico che sul piano creativo, il rap-
porto e la circolazione di senso tra specifico letterario e totalità politica.
Giovanni Raboni
L 'ALTRA DONNA
La sessualità femminile è rimasta il «continente nero» della psicoanalisi. Freud, come
alcuni sanno, quasi al termine della sua vita, riconobbe qui un fallimento. Tanto più parados-
sale dato che la prima traccia teorica gli fu data proprio da una donna, dalla sua isteria.
Nella scena isterica torna a collocarsi Luce Irigaray con questo libro sulla sessualità
femminile
(Speculum
—
L'al tra donna,
Feltrinelli 1975, lire 5.000); ritorno di cui siamo
informati soprattutto dalla scrittura: un linguaggio mutevole, ora immaginifico ora ragio-
nante, che si scuce, si disfa, si ricompone e raggruma, assume altri linguaggi, si insinua in
altri testi, adotta terminologie difformi, poi le abbandona, si frammenta, con momenti in cui
il significato sembra assente o così moltiplicato da essere inafferrabile, affidato a quasi nien-
te, a giochi di parole, a sonorità allusive. Scrittura giocata in libertà (e con molta bravura e
moltissimo rigore) che consente di decifrare, ripassandola, la scena isterica. Del resto la
malattia mentale, se manca di libertà, non manca certo di rigore, col quale si permette di sfi-
dare in definitiva quello, opposto, della teoria che cerca di esorcizzarla.
Sulla scena isterica sempre, anche al momento della sua interpretazione, la donna
agisce assecondando le aspettative con un perfetto mimetismo che segue passo passo la
stessa interpretazione, provocandola con la varietà e la mutevolezza dei sintomi e facendola
finalmente fallire. Forse per questo Freud ed altri dopo di lui sono stati indotti a rompere il
gioco estenuante, con una teorizzazione semplificatrice e rigida della sessualità femminile.
Il simbolismo un po' folleggiante dell'isterica, l'assunzione di un linguaggio preso a
prestito, in combinazioni effimere, instabili, l'esibizione dei sintomi a volte teatralmente
imponente, altre discreta e tenace, a volte di sconcertante letteralità, altre di barocca prolis-
sità, tutto sembra fatto per richiamare il rigore o i rigori di una legge e/o di una teoria (che
chiaramente non sopportano che gli si faccia il verso o la caricatura).
La goffa rigidità della decisione di farla finita con tante storie, resta però come un
segnale. Dove l'isterica percepisce soltanto —conformemente al suo desiderio distorto—
146
















