
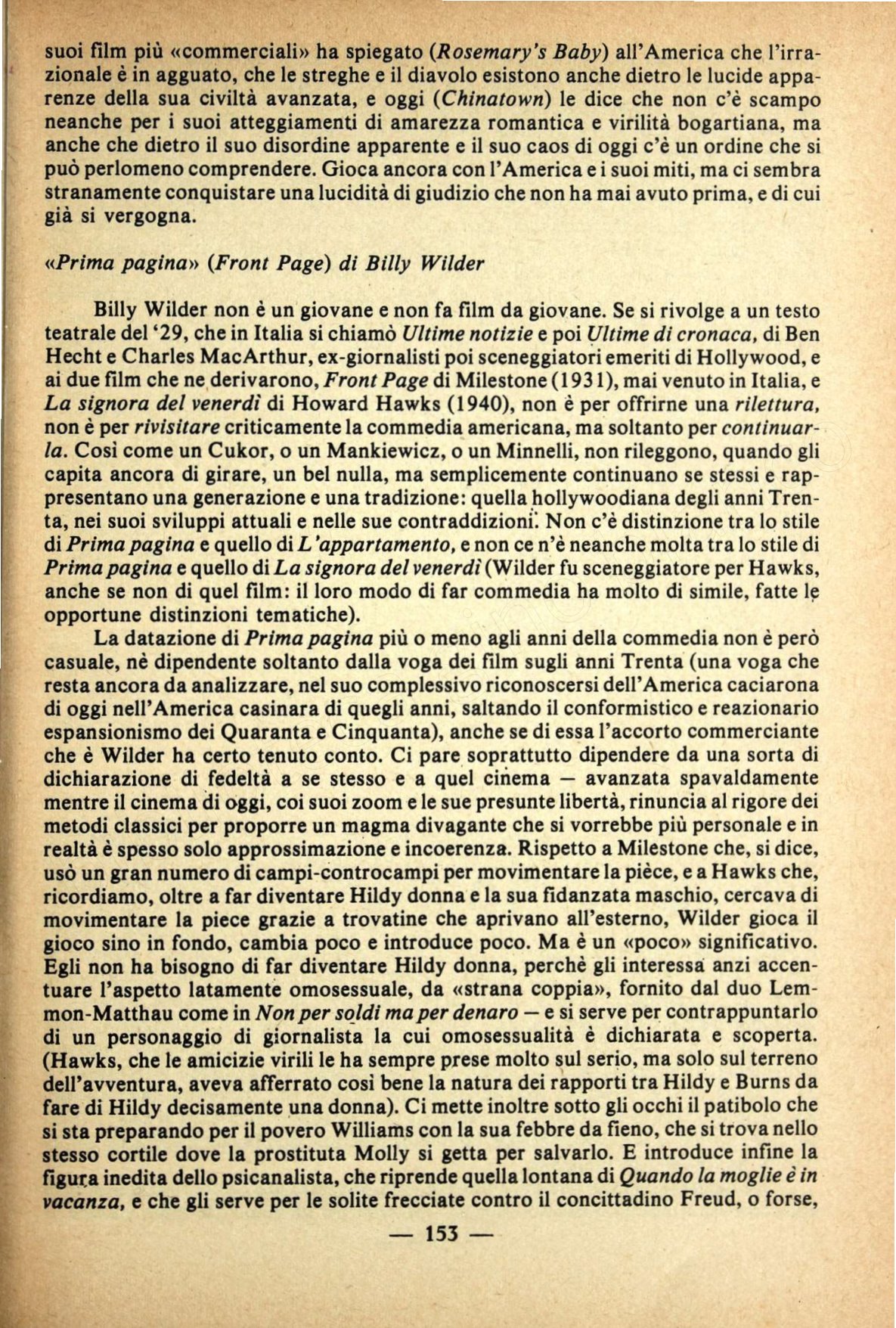
I.
suoi film più «commerciali» ha spiegato
(Rosemary's Baby)
all'America che l'irra-
zionale è in agguato, che le streghe e il diavolo esistono anche dietro le lucide appa-
renze della sua civiltà avanzata, e oggi
(Chinatown)
le dice che non c'è scampo
neanche per i suoi atteggiamenti di amarezza romantica e virilità bogartiana, ma
ancheche dietro il suo disordine apparente e il suocaos di oggi c'è un ordine che si
puòperlomeno comprendere. Gioca ancora con l'America e i suoi miti, ma ci sembra
stranamente conquistare una lucidità di giudizio chenonhamai avuto prima, edi cui
già si vergogna.
«Prima pagina» (Front Page) di Billy Wilder
Billy Wilder non è un giovane e non fa film da giovane. Se si rivolge a un testo
teatrale del '29, che in Italia si chiamò
Ultime notizie
epoi
Ultime di cronaca,
di Ben
Hecht eCharles MacArthur, ex-giornalisti poi sceneggiatori emeriti di Hollywood, e
ai due filmchene derivarono,
Front Page
di Milestone (1931), mai venuto in Italia, e
La signora del venerdì
di Howard Hawks (1940), non è per offrirne una
rilettura,
nonè per
rivisitare
criticamente la commedia americana, ma soltanto per
continuar-
la.
Così come un Cukor, o un Mankiewicz, o un Minnelli, non rileggono, quando gli
capita ancora di girare, un bel nulla, ma semplicemente continuano sestessi e rap-
presentano una generazione euna tradizione: quella hollywoodiana degli anni Tren-
ta, nei suoi sviluppi attuali e nelle sue contraddizioni. Non c'è distinzione tra lo stile
di
Prima pagina
e quello di
L'appartamento,
enoncen'è neanchemolta tra lo stile di
Prima pagina
equello di
La signora del venerdì
(Wilder fu sceneggiatore per Hawks,
anchese non di quel film: il loro modo di far commedia ha molto di simile, fatte le
opportune distinzioni tematiche).
La datazione di
Prima pagina
più omeno agli anni della commedia nonè però
casuale, nè dipendente soltanto dalla voga dei film sugli anni Trenta (una voga che
resta ancora da analizzare, nel suocomplessivo riconoscersi dell'America caciarona
di oggi nell'America casinara di quegli anni, saltando il conformisticoe reazionario
espansionismodei Quaranta e Cinquanta), anchesedi essa l'accorto commerciante
che è Wilder ha certo tenuto conto. Ci pare soprattutto dipendere da una sorta di
dichiarazione di fedeltà a se stesso e a quel cinema — avanzata spavaldamente
mentre il cinema di oggi, coi suoi zoome lesuepresunte libertà, rinuncia al rigore dei
metodi classici per proporre unmagma divagante che si vorrebbe più personale e in
realtà èspessosolo approssimazione e incoerenza. Rispetto a Milestone che, si dice,
usòun gran numero di campi-controcampi per movimentare la pièce, ea Hawks che,
ricordiamo, oltre a far diventare Hildy donnae la sua fidanzata maschio, cercava di
movimentare la piece grazie a trovatine che aprivano all'esterno, Wilder gioca il
gioco sino in fondo, cambia poco e introduce poco. Ma è un «poco» significativo.
Egli non ha bisogno di far diventare Hildy donna, perchè gli interessa anzi accen-
tuare l'aspetto latamente omosessuale, da «strana coppia», fornito dal duo Lem-
mon-Matthau come in
Non per soldi ma per denaro
—esi serve per contrappuntarlo
di un personaggio di giornalista la cui omosessualità è dichiarata e scoperta.
(Hawks, che le amicizie virili le ha semprepresemolto sul serio, ma solosul terreno
dell'avventura, aveva afferrato così bene la natura dei rapporti tra Hildy eBurns da
fare di Hildy decisamente una donna). Ci mette inoltre sotto gli occhi il patibolo che
si sta preparando per il povero Williams con la sua febbre da fieno, chesi trova nello
stesso cortile dove la prostituta Molly si getta per salvarlo. E introduce infine la
figura inedita dello psicanalista, che riprende quella lontana di
Quando la moglie
è
in
vacanza,
e che gli serve per le solite frecciate contro il concittadino Freud, o forse,
153
















