
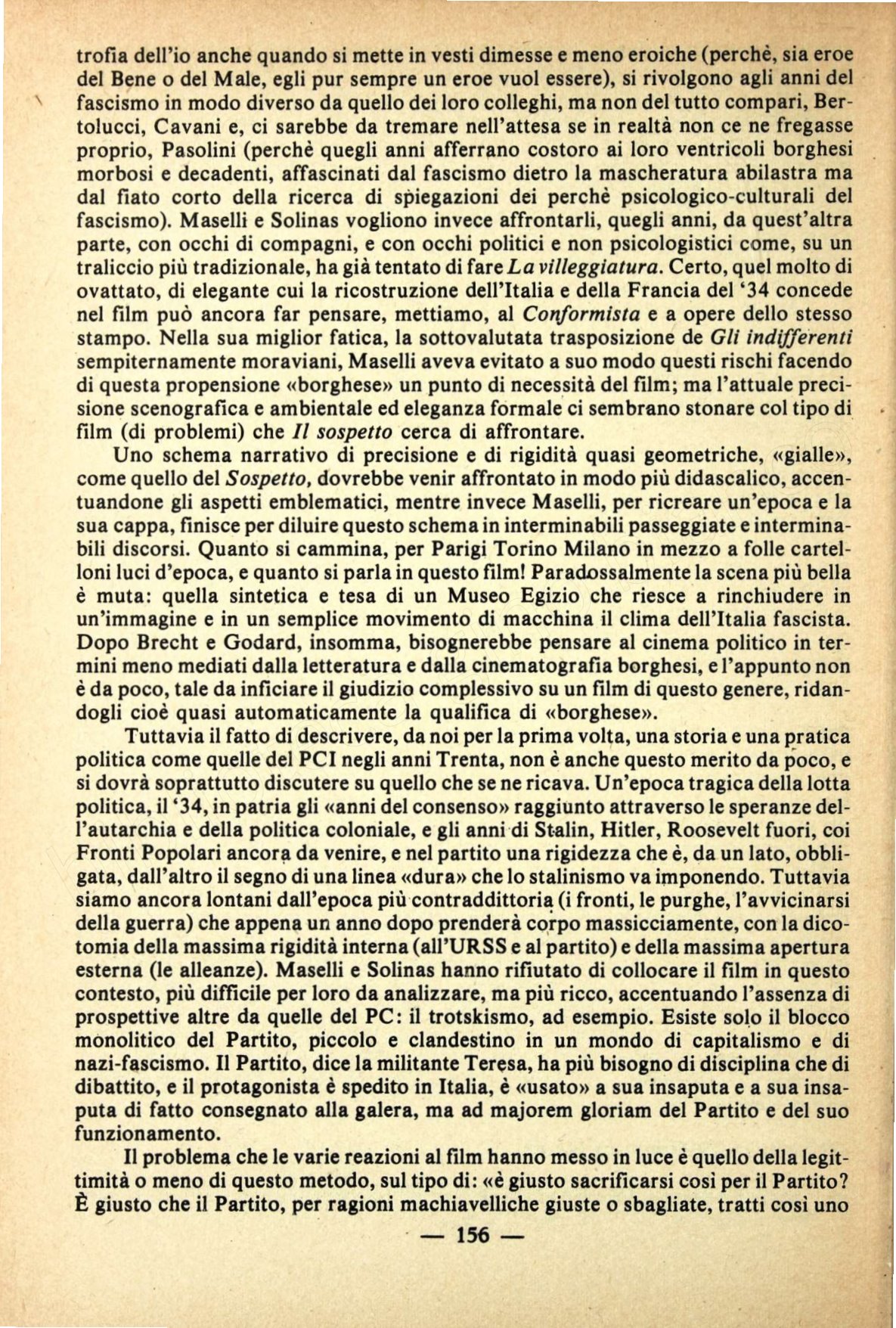
trofia dell'io anche quando si mette in vesti dimesse emeno eroiche (perchè, sia eroe
del Bene o del Male, egli pur sempre un eroe vuol essere), si rivolgono agli anni del
fascismo in modo diverso da quello dei loro colleghi, ma non del tutto compari, Ber-
tolucci, Cavani e, ci sarebbe da tremare nell'attesa se in realtà non ce ne fregasse
proprio, Pasolini (perchè quegli anni afferrano costoro ai loro ventricoli borghesi
morbosi e decadenti, affascinati dal fascismo dietro la mascheratura abilastra ma
dal fiato corto della ricerca di spiegazioni dei perchè psicologico-culturali del
fascismo). Maselli e Solinas vogliono invece affrontarli, quegli anni, da quest'altra
parte, con occhi di compagni, e con occhi politici e non psicologistici come, su un
traliccio più tradizionale, ha già tentato di fare
La villeggiatura.
Certo, quel molto di
ovattato, di elegante cui la ricostruzione dell'Italia e della Francia del '34 concede
nel film può ancora far pensare, mettiamo, al
Conformista
e a opere dello stesso
stampo. Nella sua miglior fatica, la sottovalutata trasposizione de
Gli indifferenti
sempiternamente moraviani, Maselli aveva evitato a suo modo questi rischi facendo
di questa propensione «borghese» un punto di necessità del film; ma l'attuale preci-
sione scenografica e ambientale ed eleganza formale ci sembrano stonare col tipo di
film (di problemi) che
I I sospetto
cerca di affrontare.
Uno schema narrativo di precisione e di rigidità quasi geometriche, «gialle»,
come quello del
Sospetto,
dovrebbe venir affrontato in modo più didascalico, accen-
tuandone gli aspetti emblematici, mentre invece Maselli, per ricreare un'epoca e la
sua cappa, finisce per diluire questo schema in interminabili passeggiate e intermina-
bili discorsi. Quanto si cammina, per Parigi Torino Milano in mezzo a folle cartel-
loni luci d'epoca, e quanto si parla in questo film! Paradossalmente la scena più bella
èmuta: quella sintetica e tesa di un Museo Egizio che riesce a rinchiudere in
un'immagine e in un semplice movimento di macchina il clima dell'Italia fascista.
Dopo Brecht e Godard, insomma, bisognerebbe pensare al cinema politico in ter-
mini meno mediati dalla letteratura e dalla cinematografia borghesi, e l'appunto non
èda poco, tale da inficiare il giudizio complessivo su un film di questo genere, ridan-
dogli cioè quasi automaticamente la qualifica di «borghese».
Tuttavia il fatto di descrivere, da noi per la prima volta, una storia e una pratica
politica come quelle del PCI negli anni Trenta, non è anche questo merito da poco, e
si dovrà soprattutto discutere su quello che sene ricava. Un'epoca tragica della lotta
politica, il '34, in patria gli «anni del consenso» raggiunto attraverso le speranze del-
l'autarchia e della politica coloniale, e gli anni di Stalin, Hitler, Roosevelt fuori, coi
Fronti Popolari ancora da venire, e nel partito una rigidezza che è, da un lato, obbli-
gata, dall'altro il segno di una linea «dura» che lo stalinismo va imponendo. Tuttavia
siamo ancora lontani dall'epoca più contraddittoria (i fronti, le purghe, l'avvicinarsi
della guerra) che appena un anno dopo prenderà corpo massicciamente, con la dico-
tomia della massima rigidità interna (all'URSS e al partito) e della massima apertura
esterna (le alleanze). Maselli e Solinas hanno rifiutato di collocare il film in questo
contesto, più difficile per loro da analizzare, ma più ricco, accentuando l'assenza di
prospettive altre da quelle del PC: i l trotskismo, ad esempio. Esiste solo il blocco
monolitico del Partito, piccolo e clandestino in un mondo di capitalismo e di
nazi-fascismo. Il Partito, dice la militante Teresa, ha più bisogno di disciplina che di
dibattito, e il protagonista è spedito in Italia, è «usato» a sua insaputa e a sua insa-
puta di fatto consegnato alla galera, ma ad majorem gloriam del Partito e del suo
funzionamento.
Il problema che le varie reazioni al film hanno messo in luce è quello della legit-
timità o meno di questo metodo, sul tipo di: «è giusto sacrificarsi così per il Partito?
È giusto che il Partito, per ragioni machiavelliche giuste o sbagliate, tratti così uno
156
















