
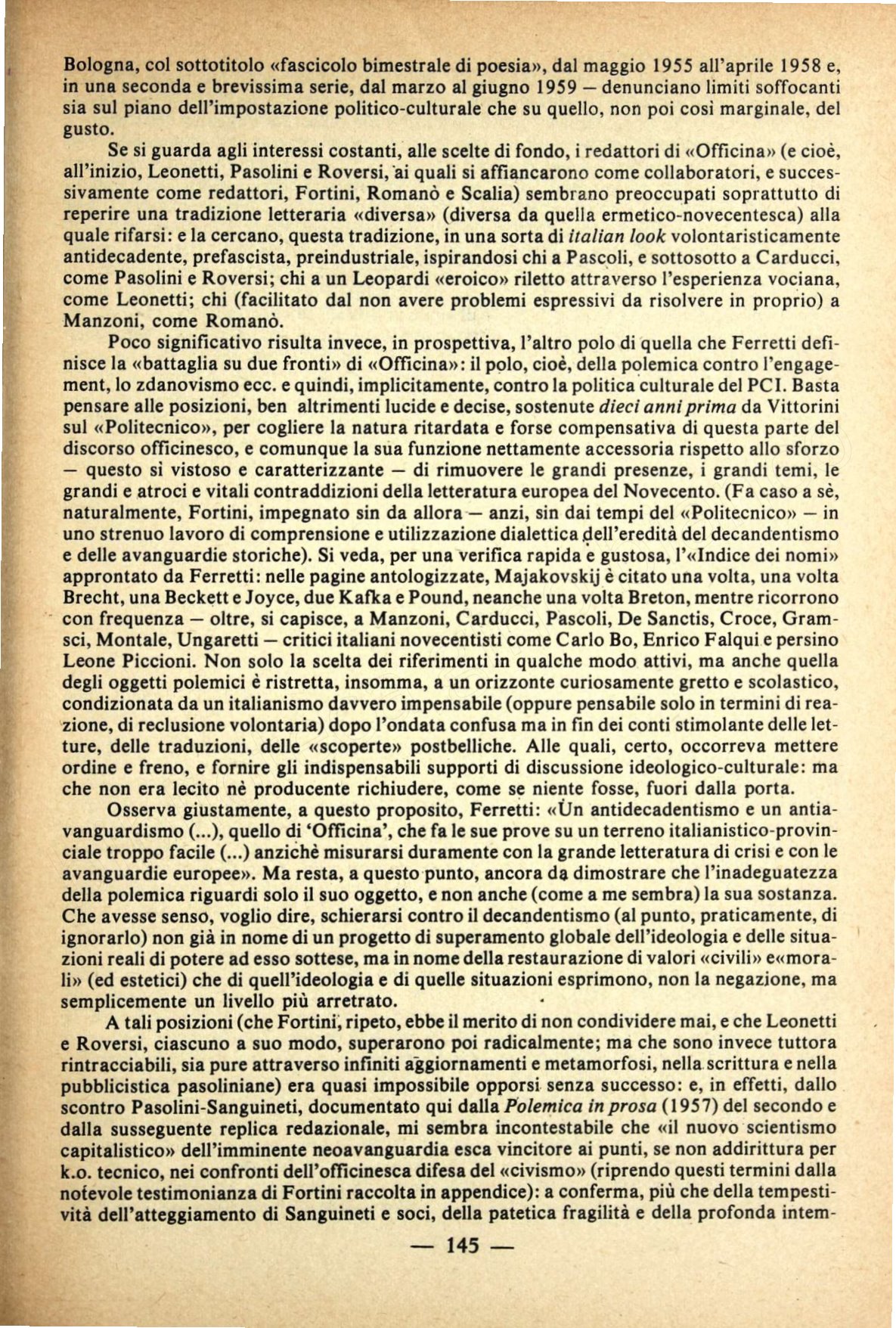
Bologna, col sottotitolo «fascicolo bimestrale di poesia», dal maggio 1955 all'aprile 1958 e,
in una seconda e brevissima serie, dal marzo al giugno 1959—denunciano limiti soffocanti
sia sul piano dell'impostazione politico-culturale che su quello, non poi così marginale, del
gusto.
Se si guarda agli interessi costanti, alle scelte di fondo, i redattori di «Officina» (e cioè,
all'inizio, Leonetti, Pasolini e Roversi, .ai quali si affiancarono come collaboratori, e succes-
sivamente come redattori, Fortini, Romanò e Scalia) sembrano preoccupati soprattutto di
reperire una tradizione letteraria «diversa» (diversa da quella ermetico-novecentesca) alla
quale rifarsi: e la cercano, questa tradizione, in una sorta di
italian look
volontaristicamente
antidecadente, prefascista, preindustriale, ispirandosi chi a Pascoli, e sottosotto a Carducci,
come Pasolini e Roversi; chi a un Leopardi «eroico» riletto attraverso l'esperienza vociana,
come Leonetti; chi (facilitato dal non avere problemi espressivi da risolvere in proprio) a
Manzoni, come Romanò.
Poco significativo risulta invece, in prospettiva, l'altro polo di quella che Ferretti defi-
nisce la «battaglia su due fronti» di «Officina»: il polo, cioè, della polemica contro l'engage-
ment, lo zdanovismo ecc. e quindi, implicitamente, contro la politica culturale del PCI. Basta
pensare alle posizioni, ben altrimenti lucide e decise, sostenute
dieci anni prima
da Vittorini
sul «Politecnico», per cogliere la natura ritardata e forse compensativa di questa parte del
discorso offìcinesco, e comunque la sua funzione nettamente accessoria rispetto allo sforzo
—questo sì vistoso e caratterizzante — di rimuovere le grandi presenze, i grandi temi, le
grandi e atroci e vitali contraddizioni della letteratura europea del Novecento. (Fa caso a sè,
naturalmente, Fortini, impegnato sin da allora —anzi, sin dai tempi del «Politecnico» — in
uno strenuo lavoro di comprensione e utilizzazione dialettica dell'eredità del decandentismo
edelle avanguardie storiche). Si veda, per una verifica rapida e gustosa, l'«Indice dei nomi»
approntato da Ferretti: nelle pagine antologizzate, M ajakovskij è citato una volta, una volta
Brecht, una Beckett e Joyce, due Kafka e Pound, neanche una volta Breton, mentre ricorrono
con frequenza—oltre, si capisce, a Manzoni, Carducci, Pascoli, De Sanctis, Croce, Gram -
sci, Montale, Ungaretti — critici italiani novecentisti come Carlo Bo, Enrico Falqui e persino
Leone Piccioni. Non solo la scelta dei riferimenti in qualche modo attivi, ma anche quella
degli oggetti polemici è ristretta, insomma, a un orizzonte curiosamente gretto e scolastico,
condizionata da un italianismo davvero impensabile (oppure pensabile solo in termini di rea-
zione, di reclusione volontaria) dopo l'ondata confusa ma in fin dei conti stimolante delle let-
ture, delle traduzioni, delle «scoperte» postbelliche. Al le quali, certo, occorreva mettere
ordine e freno, e fornire gli indispensabili supporti di discussione ideologico-culturale: ma
che non era lecito nè producente richiudere, come se niente fosse, fuori dalla porta.
Osserva giustamente, a questo proposito, Ferretti: «Un antidecadentismo e un antia-
vanguardismo (...), quello di 'Officina', che fa le sue prove su un terreno italianistico-provin-
ciale troppo facile (...) anziché misurarsi duramente con la grande letteratura di crisi e con le
avanguardie europee». Ma resta, a questo punto, ancora da dimostrare che l'inadeguatezza
della polemica riguardi solo il suo oggetto, e non anche (come a me sembra) la sua sostanza.
Che avesse senso, voglio dire, schierarsi contro il decandentisrno (al punto, praticamente, di
ignorarlo) non già in nome di un progetto di superamento globale dell'ideologia e delle situa-
zioni reali di potere ad esso sottese, ma in nome della restaurazione di valori «civili» e«mora-
li» (ed estetici) che di quell'ideologia e di quelle situazioni esprimono, non la negazione, ma
semplicemente un livello più arretrato.
A tali posizioni (che Fortini, ripeto, ebbe il merito di non condividere mai, e che Leonetti
eRoversi, ciascuno a suo modo, superarono poi radicalmente; ma che sono invece tuttora
rintracciabili, sia pure attraverso infiniti aggiornamenti e metamorfosi, nella scrittura e nella
pubblicistica pasoliniane) era quasi impossibile opporsi senza successo: e, in effetti, dallo
scontro Pasolini-Sanguineti, documentato qui dalla
Polemica in prosa (1957)
del secondo e
dalla susseguente replica redazionale, mi sembra incontestabile che «il nuovo scientismo
capitalistico» dell'imminente neoavanguardia esca vincitore ai punti, se non addirittura per
k.o. tecnico, nei confronti dell'officinesca difesa del «civismo» (riprendo questi termini dalla
notevole testimonianza di Fortini raccolta in appendice): a conferma, più che della tempesti-
vità dell'atteggiamento di Sanguineti e soci, della patetica fragilità e della profonda intem-
145
















