
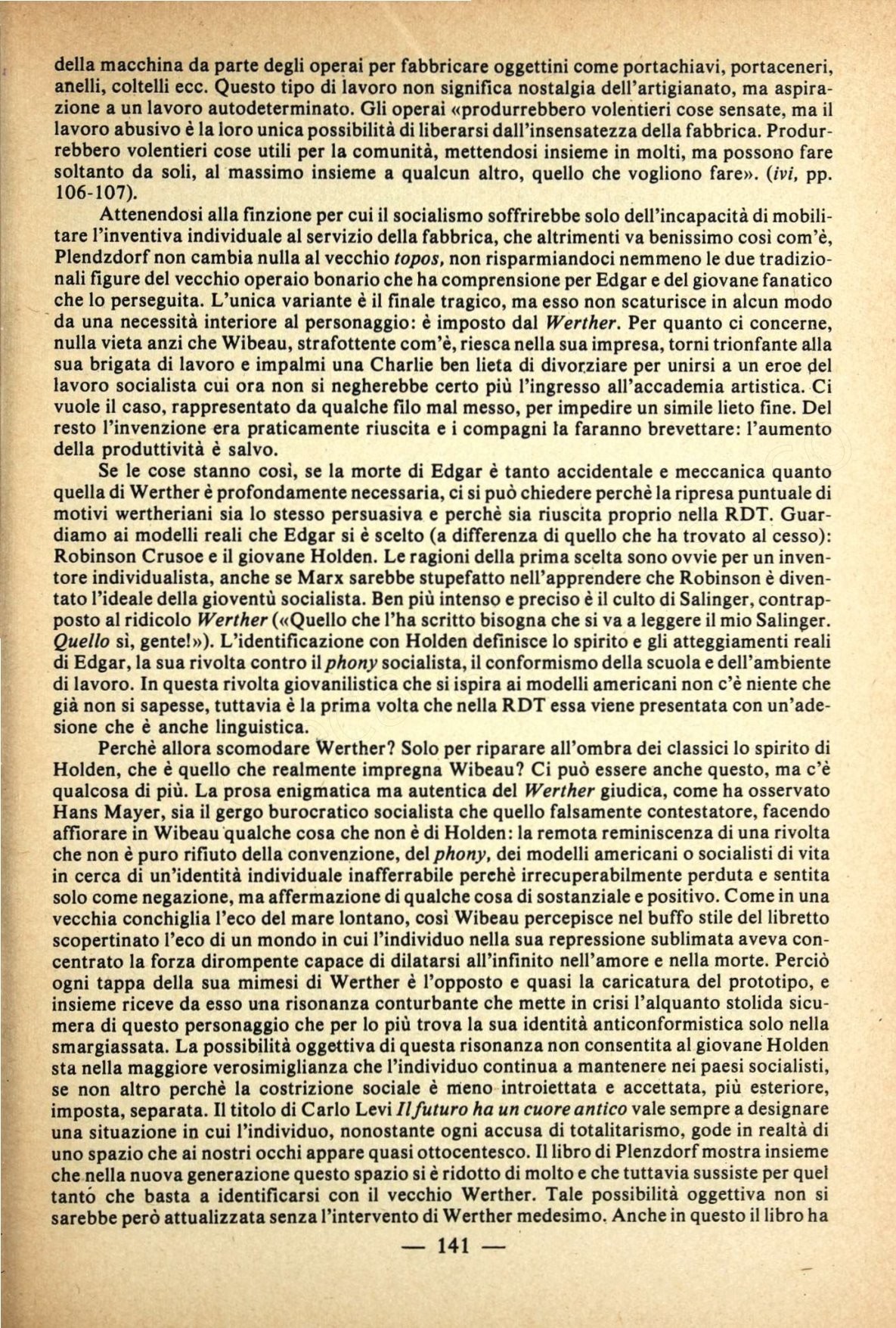
della macchina da parte degli operai per fabbricare oggettini come portachiavi, portaceneri,
anelli, coltelli ecc. Questo tipo di lavoro non significa nostalgia dell'artigianato, ma aspira-
zione a un lavoro autodeterminato. Gli operai «produrrebbero volentieri cose sensate, ma il
lavoro abusivo è la loro unica possibilità di liberarsi dall'insensatezza della fabbrica. Produr-
rebbero volentieri cose utili per la comunità, mettendosi insieme in molti, ma possono fare
soltanto da soli, al massimo insieme a qualcun altro, quello che vogliono fare».
(ivi,
pp.
106-107).
Attenendosi alla finzione per cui il socialismo soffrirebbe solo dell'incapacità di mobili-
tare l'inventiva individuale al servizio della fabbrica, che altrimenti va benissimo così com'è,
Plendzdorf non cambia nulla al vecchio
topos,
non risparmiandoci nemmeno le due tradizio-
nali figure del vecchio operaio bonario che ha comprensione per Edgar edel giovane fanatico
che lo perseguita. L'unica variante è il finale tragico, ma esso non scaturisce in alcun modo
da una necessità interiore al personaggio: è imposto dal
Werther.
Per quanto ci concerne,
nulla vieta anzi che Wibeau, strafottente com'è, riesca nella sua impresa, torni trionfante alla
sua brigata di lavoro e impalmi una Charlie ben lieta di divorziare per unirsi a un eroe del
lavoro socialista cui ora non si negherebbe certo più l'ingresso all'accademia artistica. Ci
vuole il caso, rappresentato da qualche filo mal messo, per impedire un simile lieto fine. Del
resto l'invenzione era praticamente riuscita e i compagni la faranno brevettare: l'aumento
della produttività è salvo.
Se le cose stanno così, se la morte di Edgar è tanto accidentale e meccanica quanto
quella di Werther è profondamente necessaria, ci si può chiedere perchè la ripresa puntuale di
motivi wertheriani sia lo stesso persuasiva e perchè sia riuscita proprio nella RDT. Guar-
diamo ai modelli reali che Edgar si è scelto (a differenza di quello che ha trovato al cesso):
Robinson Crusoe e il giovane Holden. Le ragioni della prima scelta sono ovvie per un inven-
tore individualista, anche se Marx sarebbe stupefatto nell'apprendere che Robinson è diven-
tato l'ideale della gioventù socialista. Ben più intenso e preciso è il culto di Salinger, contrap-
posto al ridicolo
Werther
(«Quello che l'ha scritto bisogna che si va a leggere il mio Salinger.
Quello
sì, gente!»). L'identificazione con Holden definisce lo spirito e gli atteggiamenti reali
di Edgar, la sua rivolta contro il
phony
socialista, il conformismo della scuola e dell'ambiente
di lavoro. In questa rivolta giovanilistica che si ispira ai modelli americani non c'è niente che
già non si sapesse, tuttavia è la prima volta che nella RDT essa viene presentata con un'ade-
sione che è anche linguistica.
Perché allora scomodare Werther? Solo per riparare all'ombra dei classici lo spirito di
Holden, che è quello che realmente impregna Wibeau? Ci può essere anche questo, ma c'è
qualcosa di più. La prosa enigmatica ma autentica del
Werther
giudica, come ha osservato
Hans Mayer, sia il gergo burocratico socialista che quello falsamente contestatore, facendo
affiorare in Wibeau qualche cosa che non è di Holden: la remota reminiscenza di una rivolta
che non è puro rifiuto della convenzione, del
phony,
dei modelli americani o socialisti di vita
in cerca di un'identità individuale inafferrabile perchè irrecuperabilmente perduta e sentita
solo come negazione, ma affermazione di qualche cosa di sostanziale e positivo. Come in una
vecchia conchiglia l'eco del mare lontano, così Wibeau percepisce nel buffo stile del libretto
scopertinato l'eco di un mondo in cui l'individuo nella sua repressione sublimata aveva con-
centrato la forza dirompente capace di dilatarsi all'infinito nell'amore e nella morte. Perciò
ogni tappa della sua mimesi di Werther è l'opposto e quasi la caricatura del prototipo, e
insieme riceve da esso una risonanza conturbante che mette in crisi l'alquanto stolida sicu-
mera di questo personaggio che per lo più trova la sua identità anticonformistica solo nella
smargiassata. La possibilità oggettiva di questa risonanza non consentita al giovane Holden
sta nella maggiore verosimiglianza che l'individuo continua a mantenere nei paesi socialisti,
se non altro perchè la costrizione sociale è meno introiettata e accettata, più esteriore,
imposta, separata. Il titolo di Carlo Levi
II futuro ha un cuore antico
vale sempre a designare
una situazione in cui l'individuo, nonostante ogni accusa di totalitarismo, gode in realtà di
uno spazio che ai nostri occhi appare quasi ottocentesco. Il libro di Plenzdorf mostra insieme
che nella nuova generazione questo spazio si è ridotto di molto eche tuttavia sussiste per quel
tanto- che basta a identificarsi con i l vecchio Werther. Tale possibilità oggettiva non si
sarebbe però attualizzata senza l'intervento di Werther medesimo. Anche in questo il libro ha
141
















