
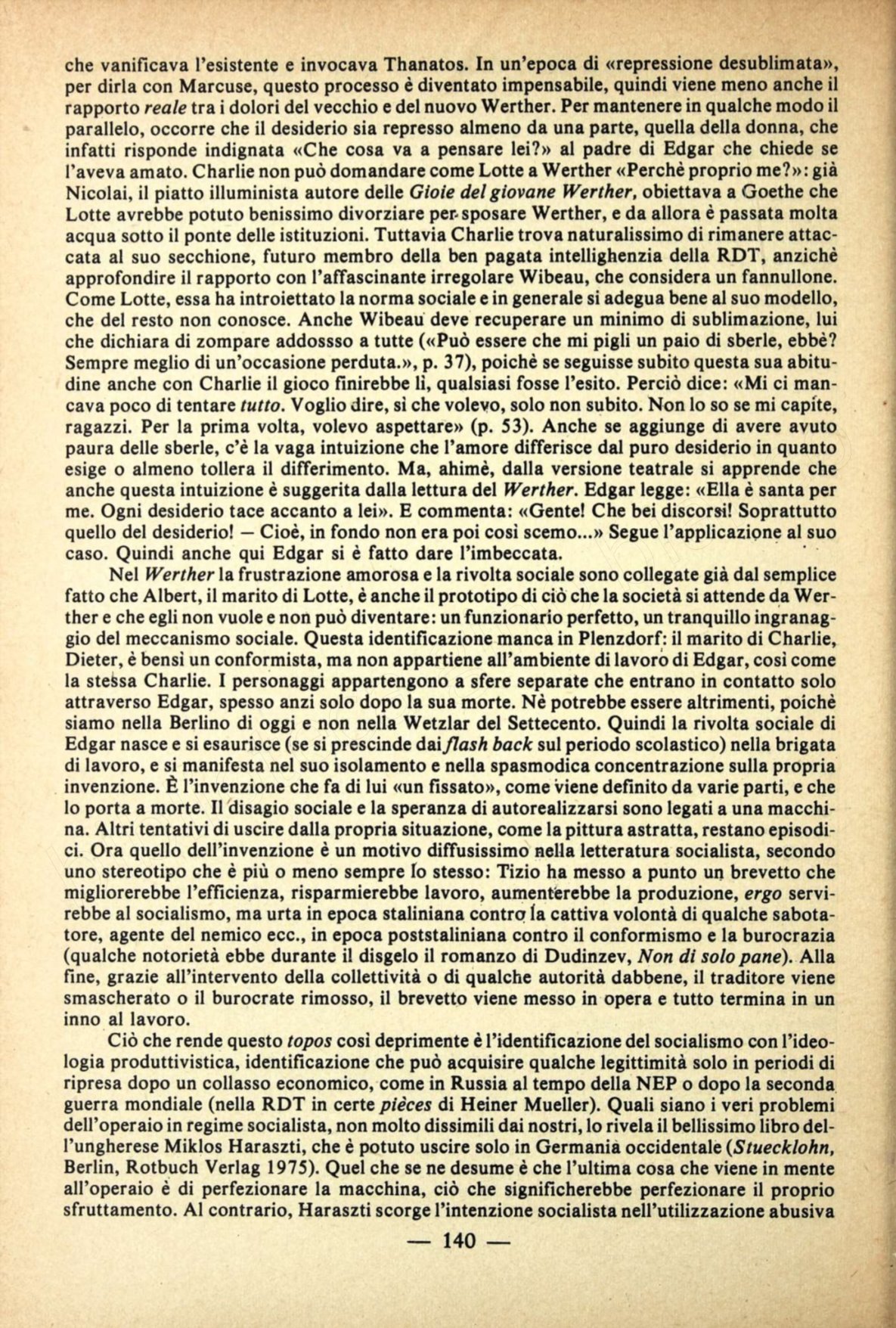
chevanificava l'esistente e invocava Thanatos. In un'epoca di «repressione desublimata»,
per dirla con Marcuse, questoprocessoè diventato impensabile, quindi vienemeno anche il
rapporto
reale
tra i dolori del vecchioedel nuovoWerther. Per mantenere inqualchemodo il
parallelo, occorre che il desiderio sia represso almeno da una parte, quella della donna, che
infatti risponde indignata «Che cosa va a pensare lei?» al padre di Edgar che chiede se
l'aveva amato. Charlie nonpuòdomandarecome Lotte aWerther «Perchè propriome?»: già
Nicolai, il piatto illuminista autore delle
Gioie del giovane Werther,
obiettava a Goethe che
Lotte avrebbe potuto benissimo divorziareperasposareWerther, e da allora èpassata molta
acqua sotto il ponte delle istituzioni. Tuttavia Charlie trova naturalissimo di rimanere attac-
cata al suo secchione, futuro membro della ben pagata intellighenzia della RDT, anziché
approfondire il rapporto con l'affascinante irregolare Wibeau, che considera un fannullone.
Come Lotte, essaha introiettato la norma socialee ingeneralesi adeguabeneal suomodello,
chedel resto non conosce. Anche Wibeau deve recuperare un minimo di sublimazione, lui
chedichiara di zompare addossso a tutte («Può essereche mi pigli un paio di sberle, ebbè?
Sempremeglio di un'occasione perduta.», p. 37), poichéseseguissesubitoquestasua abitu-
dineanche con Charlie il gioco finirebbe li, qualsiasi fosse l'esito. Perciò dice: «Mi ci man-
cavapoco di tentare
tutto.
Voglio dire, sì che volevo, solonon subito. Non lososemi capite,
ragazzi. Per la prima volta, volevo aspettare» (p. 53). Anche se aggiunge di avere avuto
paura delle sberle, c'è la vaga intuizione che l'amore differisce dal puro desiderio in quanto
esige o almeno tollera il differimento. Ma, ahimè, dalla versione teatrale si apprende che
anchequesta intuizione è suggerita dalla lettura del
Werther.
Edgar legge: «Ella è santa per
me. Ogni desiderio tace accanto a lei». E commenta: «Gente! Che bei discorsi! Soprattutto
quello del desiderio!—Cioè, in fondo non era poi così scemo...»Segue l'applicazione al suo
caso. Quindi anche qui Edgar si è fatto dare l'imbeccata.
Nel
Werther
la frustrazione amorosae la rivolta socialesonocollegate già dal semplice
fatto cheAlbert, il marito di Lotte, èanche il prototipo di ciòche la societàsi attende daWer-
therecheegli nonvuoleenonpuòdiventare: un funzionario perfetto, un tranquillo ingranag-
giodelmeccanismo sociale. Questa identificazionemanca in Plenzdorf: il marito di Charlie,
Dieter, èbensì un conformista, manon appartiene all'ambiente di lavoro di Edgar, così come
lastessa Charlie. I personaggi appartengono a sfere separate che entrano in contatto solo
attraverso Edgar, spesso anzi solodopo la suamorte. Nè potrebbeessere altrimenti, poiché
siamo nella Berlino di oggi e non nella Wetzlar del Settecento. Quindi la rivolta sociale di
Edgar nasceesi esaurisce (sesi prescinde
daiflash back
sul periodo scolastico) nella brigata
di lavoro, esi manifesta nel suo isolamento e nella spasmodica concentrazione sulla propria
invenzione. È l'invenzione che fa di lui «un fissato», comeViene definito da varie parti, eche
lo porta a morte. Il disagio sociale e la speranza di autorealizzarsi sono legati a unamacchi-
na. Altri tentativi di uscire dalla propria situazione, come la pittura astratta, restano episodi-
ci. Ora quello dell'invenzione è un motivo diffusissimo nella letteratura socialista, secondo
unostereotipo che è più o meno sempre Io stesso: Tizio hamesso a punto un brevetto che
migliorerebbe l'efficienza, risparmierebbe lavoro, aumenterebbe la produzione,
ergo
servi-
rebbe al socialismo, ma urta in epoca staliniana contro la cattiva volontà di qualche sabota-
tore, agente del nemico ecc., in epoca poststaliniana contro il conformismo e la burocrazia
(qualche notorietà ebbe durante il disgelo il romanzo di Dudinzev,
Non di solo pane).
Alla
fine, grazie all'intervento della collettività o di qualche autorità dabbene, il traditore viene
smascherato o il burocrate rimosso, il brevetto vienemesso in opera e tutto termina in un
inno al lavoro.
Ciò che rendequesto
topos
così deprimenteè l'identificazione del socialismocon l'ideo-
logia produttivistica, identificazione che può acquisire qualche legittimità solo in periodi di
ripresa dopo un collasso economico, come in Russia al tempo della NEP o dopo la seconda
guerramondiale (nella RDT in certe
pièces
di Heiner Mueller). Quali siano i veri problemi
dell'operaio in regime socialista, nonmolto dissimili dai nostri, lo rivela il bellissimo libro del-
l'ungherese Miklos Haraszti, cheè potuto uscire solo in Germania occidentale
(Stuecklohn,
Berlin, Rotbuch Verlag 1975). Quel chesenedesumeèche l'ultima cosache viene inmente
all'operaio è di perfezionare la macchina, ciò che significherebbe perfezionare il proprio
sfruttamento. Al contrario, Haraszti scorge l'intenzione socialista nell'utilizzazione abusiva
140
















