
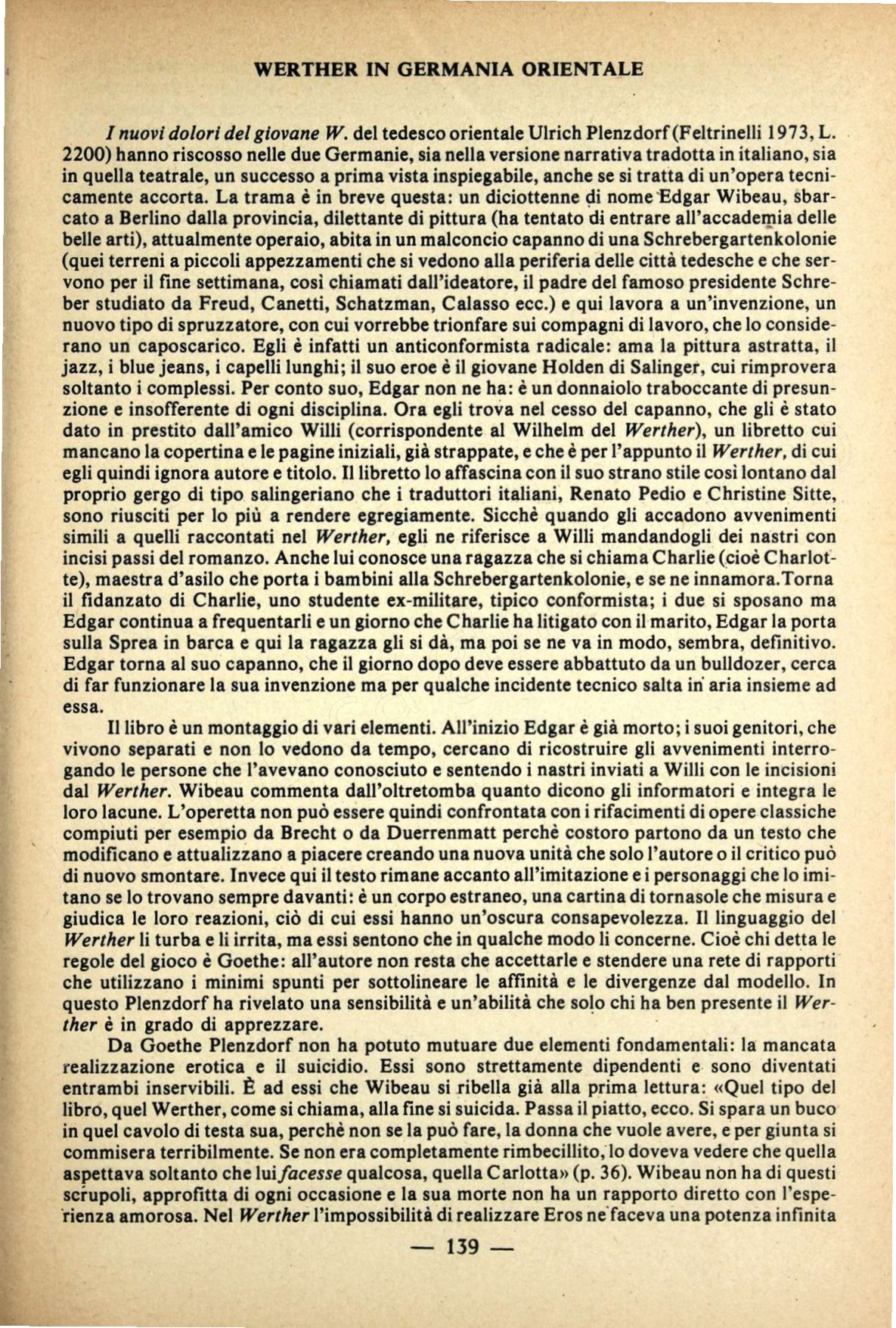
WERTHER IN GERMANIA ORIENTALE
muovi dolori del giovane W.
del tedesco orientale Ulrich Plenzdorf (Feltrinelli 1973, L.
2200) hanno riscossonelledueGermanie, sia nella versione narrativa tradotta in italiano, sia
inquella teatrale, unsuccesso a prima vista inspiegabile, anchesesi tratta di un'opera tecni-
camente accorta. La trama è in breve questa: un diciottenne di nome Edgar Wibeau, sbar-
cato a Berlino dalla provincia, dilettante di pittura (ha tentato di entrare all'accademia delle
belle arti), attualmente operaio, abita inunmalconcio capannodi una Schrebergartenkolonie
(quei terreni a piccoli appezzamenti chesi vedono alla periferia delle città tedescheeche ser-
vonoper il fine settimana, così chiamati dall'ideatore, il padre del famoso presidente Schre-
ber studiato da Freud, Canetti, Schatzman, Calasso ecc.) e qui lavora a un'invenzione, un
nuovo tipo di spruzzatore, con cui vorrebbe trionfare sui compagni di lavoro, che loconside-
rano un caposcarico. Egli è infatti un anticonformista radicale: ama la pittura astratta, il
jazz, i blue jeans, i capelli lunghi; il suoeroe è il giovane Holden di Salinger, cui rimprovera
soltanto i complessi. Per conto suo, Edgar nonne ha: è un donnaiolo traboccante di presun-
zione e insofferente di ogni disciplina. Ora egli trova nel cesso del capanno, che gli è stato
dato in prestito dall'amico Willi (corrispondente al Wilhelm del
Werther),
un libretto cui
mancano la copertinae lepagine iniziali, già strappate, echeèper l'appunto il
Werther,
di cui
egli quindi ignora autore e titolo. Il libretto lo affascina con il suostrano stile così lontano dal
proprio gergo di tipo salingeriano che i traduttori italiani, Renato Pedio e C hristine Sitte,
sono riusciti per lo più a rendere egregiamente. Sicché quando gli accadono avvenimenti
simili a quelli raccontati nel
Werther,
egli ne riferisce a Willi mandandogli dei nastri con
incisi passi del romanzo. Anche lui conosceuna ragazza chesi chiama Charlie (cioè Charlot-
te), maestra d'asilo che porta i bambini alla Schrebergartenkolonie, esene innamora.Torna
il fidanzato di Charlie, uno studente ex-militare, tipico conformista; i due si sposano ma
Edgar continua a frequentarli eungiornocheCharlie ha litigato con il marito, Edgar la porta
sulla Sprea in barca e qui la ragazza gli si dà, ma poi sene va in modo, sembra, definitivo.
Edgar torna al suo capanno, che il giorno dopodeveessere abbattuto daun bulldozer, cerca
di far funzionare la sua invenzionema per qualche incidente tecnico salta in aria insieme ad
essa.
Il libro èunmontaggio di vari elementi. All'inizio Edgar ègià morto; i suoi genitori, che
vivono separati e non lo vedono da tempo, cercano di ricostruire gli avvenimenti interro-
gando le persone che l'avevano conosciuto e sentendo i nastri inviati a Willi con le incisioni
dal
Werther.
Wibeau commenta dall'oltretomba quanto dicono gli informatori e integra le
loro lacune. L'operetta nonpuòesserequindi confrontata con i rifacimenti di opereclassiche
compiuti per esempio da Brecht o da Duerrenmatt perchè costoro partono da un testo che
modificanoeattualizzano a piacere creandounanuova unità chesolo l'autoreo il critico può
di nuovo smontare. Invece qui il testo rimane accanto all'imitazione e i personaggi che lo imi-
tanose lo trovano sempre davanti: èun corpo estraneo, una cartina di tornasolechemisurae
giudica le loro reazioni, ciò di cui essi hanno un'oscura consapevolezza. Il linguaggio del
Werther
li turba e li irrita, maessi sentonoche in qualchemodo li concerne. Cioè chi detta le
regole del gioco è Goethe: all'autore non resta che accettarle e stendere una rete di rapporti
che utilizzano i minimi spunti per sottolineare le affinità e le divergenze dal modello. In
questo Plenzdorf ha rivelato una sensibilità e un'abilità chesolo chi ha benpresente il
Wer-
ther
è in grado di apprezzare.
Da Goethe Plenzdorf non ha potuto mutuare due elementi fondamentali: la mancata
realizzazione erotica e i l suicidio. Essi sono strettamente dipendenti e sono diventati
entrambi inservibili. È ad essi che Wibeau si ribella già alla prima lettura: «Quel tipo del
libro, quel Werther, comesi chiama, alla finesi suicida. Passa il piatto, ecco. Si sparaunbuco
inquel cavolo di testa sua, perchènonse la può fare, la donnachevuole avere, eper giunta si
commisera terribilmente. Senon era completamente rimbecillito, lo doveva vederechequella
aspettava soltanto che
lui facesse
qualcosa, quella Carlotta» (p. 36). Wibeau nonha di questi
sckupoli, approfitta di ogni occasione e la suamorte non ha un rapporto diretto con l'espe-
rienza amorosa. Nel
Werther
l'impossibilità di realizzare Eros nefaceva una potenza infinita
139
















