
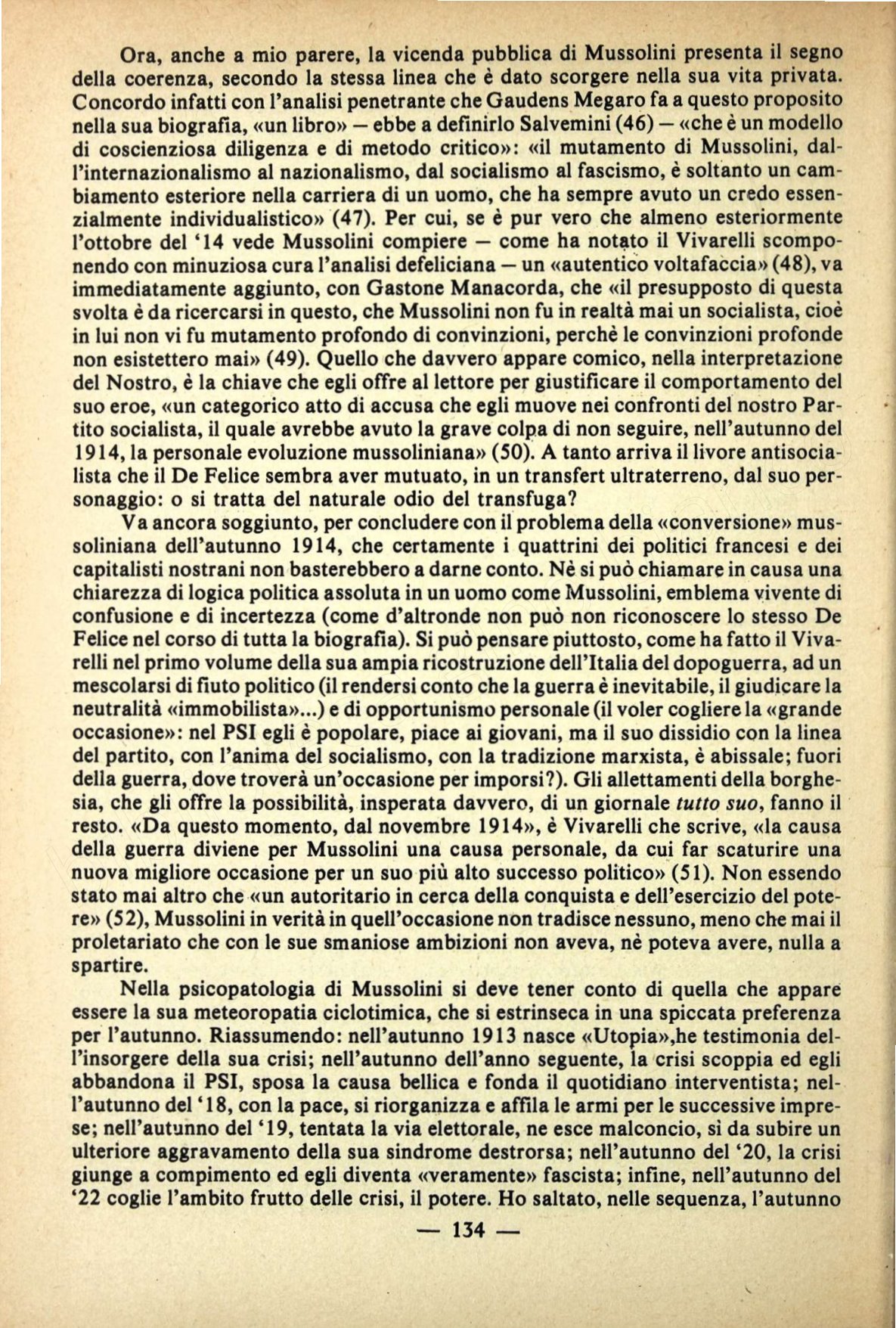
Ora, anche a mio parere, la vicenda pubblica di Mussolini presenta il segno
della coerenza, secondo la stessa linea che è dato scorgere nella sua vita privata.
Concordo infatti con l'analisi penetrante cheGaudensMegaro fa aquestoproposito
nella sua biografia, «un libro»—ebbe a definirlo Salvemini (46)—«cheèunmodello
di coscienziosa diligenza e di metodo critico»: «il mutamento di Mussolini, dal-
l'internazionalismo al nazionalismo, dal socialismo al fascismo, è soltanto un cam-
biamento esteriore nella carriera di un uomo, che ha sempre avuto un credo essen-
zialmente individualistico» (47). Per cui, se è pur vero che almeno esteriormente
l'ottobre del '14 vede Mussolini compiere—come ha notato il Vivarelli scompo-
nendoconminuziosa cura l'analisi defeliciana—un «autentico voltafaccia» (48), va
immediatamente aggiunto, con Gastone M anacorda, che «il presupposto di questa
svolta è da ricercarsi in questo, cheMussolini non fu in realtà mai un socialista, cioè
in lui non vi fu mutamento profondo di convinzioni, perché le convinzioni profonde
nonesistettero mai» (49). Quello che davvero appare comico, nella interpretazione
del Nostro, è la chiave che egli offre al lettore per giustificare il comportamento del
suoeroe, «un categorico atto di accusa che egli muove nei confronti del nostro Par-
tito socialista, il quale avrebbe avuto la grave colpa di non seguire, nell'autunno del
1914, la personale evoluzionemussoliniana» (50). A tanto arriva il livore antisocia-
lista che il De Felice sembra aver mutuato, in un transfert ultraterreno, dal suo per-
sonaggio: o si tratta del naturale odio del transfuga?
Va ancora soggiunto, per concluderecon il problema della «conversione»mus-
soliniana dell'autunno 1914, che certamente i quattrini dei politici francesi e dei
capitalisti nostrani nonbasterebbero a darne conto. Nè si può chiamare in causauna
chiarezza di logica politica assoluta in unuomocomeMussolini, emblema vivente di
confusione e di incertezza (come d'altronde non può non riconoscere lo stesso De
Felice nel corso di tutta la biografia). Si puòpensare piuttosto, comeha fatto il Viva-
relli nel primo volume della suaampia ricostruzione dell'Italia del dopoguerra, adun
mescolarsi di fiuto politico (il rendersi contoche la guerraè inevitabile, il giudicare la
neutralità «immobilista»...) edi opportunismo personale (il voler cogliere la «grande
occasione»: nel PSI egli è popolare, piace ai giovani, ma il suo dissidio con la linea
del partito, con l'anima del socialismo, con la tradizione marxista, è abissale; fuori
della guerra, dove troverà un'occasione per imporsi?). Gli allettamenti della borghe-
sia, che gli offre la possibilità, insperata davvero, di un giornale
tutto suo,
fanno il
resto. «Da questomomento, dal novembre 1914», è Vivarelli che scrive, «la causa
della guerra diviene per Mussolini una causa personale, da cui far scaturire una
nuovamigliore occasione per un suo più alto successo politico» (51). Non essendo
statomai altro che «un autoritario in cerca della conquistae dell'esercizio del pote-
re» (52), Mussolini in verità in quell'occasionenon tradiscenessuno,menochemai il
proletariato che con le suesmaniose ambizioni non aveva, ne poteva avere, nulla a
spartire.
Nella psicopatologia di Mussolini si deve tener conto di quella che appare
essere la suameteoropatia ciclotimica, che si estrinseca in una spiccata preferenza
per l'autunno. Riassumendo: nell'autunno 1913 nasce «Utopia»,he testimonia del-
l'insorgere della sua crisi; nell'autunno dell'anno seguente, la crisi scoppia ed egli
abbandona il PSI, sposa la causa bellica e fonda il quotidiano interventista; nel-
l'autunno del '18, con la pace, si riorganizza e affila le armi per lesuccessive impre-
se; nell'autunno del '19, tentata la via elettorale, neescemalconcio, si da subire un
ulteriore aggravamento della sua sindrome destrorsa; nell'autunno del '20, la crisi
giunge a compimento ed egli diventa «veramente» fascista; infine, nell'autunno del
'22 coglie l'ambito frutto delle crisi, il potere. Ho saltato, nelle sequenza, l'autunno
134
















