
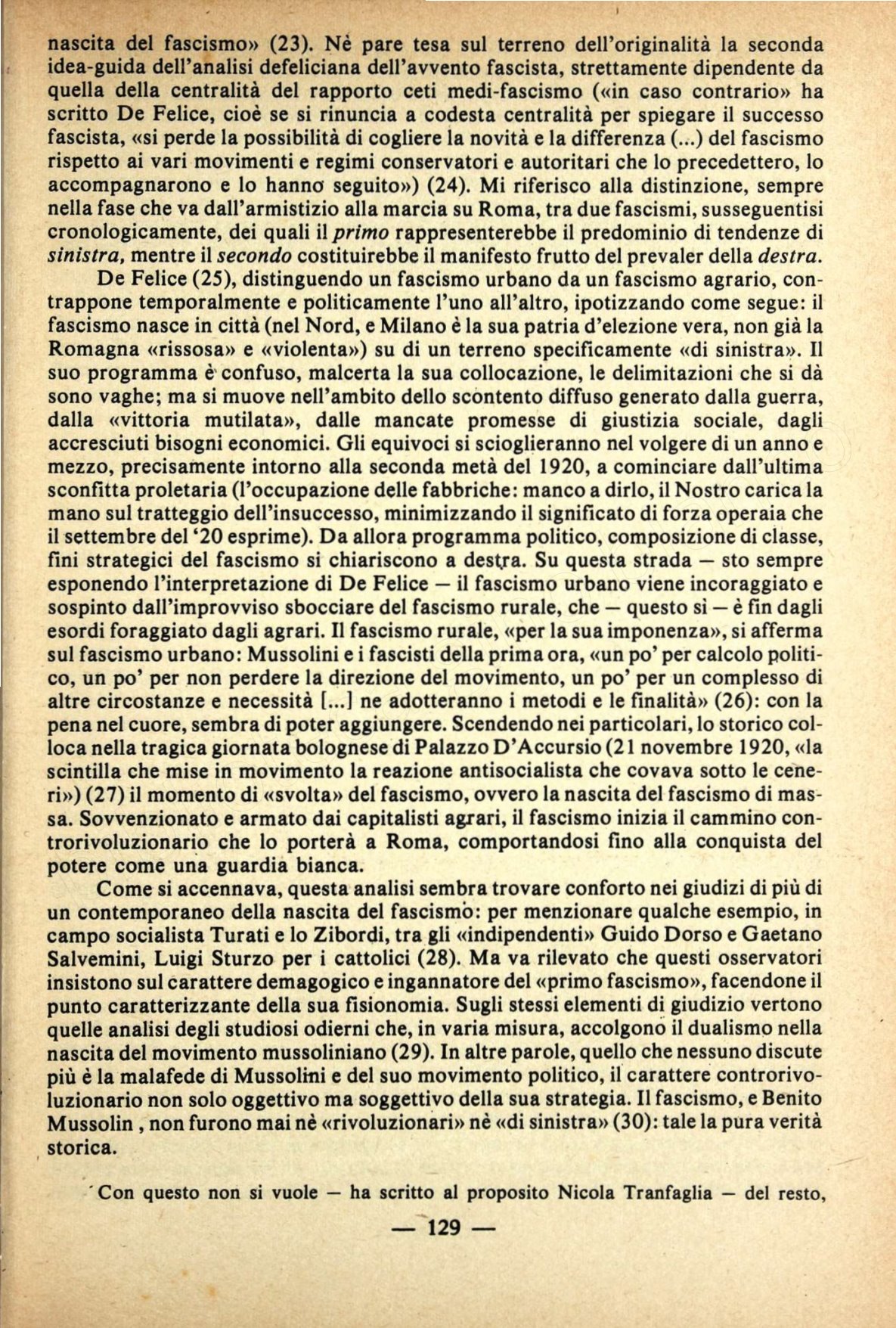
nascita del fascismo» (23). Nè pare tesa sul terreno dell'originalità la seconda
idea-guida dell'analisi defeliciana dell'avvento fascista, strettamente dipendente da
quella della centralità del rapporto ceti medi-fascismo («in caso contrario» ha
scritto De Felice, cioè se si rinuncia a codesta centralità per spiegare il successo
fascista, «si perde la possibilità di cogliere la novità e la differenza (...) del fascismo
rispetto ai vari movimenti e regimi conservatori e autoritari che lo precedettero, Io
accompagnarono e lo hanno seguito») (24). Mi riferisco alla distinzione, sempre
nella fase che va dall'armistizio alla marcia su Roma, tra due fascismi, susseguentisi
cronologicamente, dei quali il
primo
rappresenterebbe il predominio di tendenze di
sinistra,
mentre il
secondo
costituirebbe il manifesto frutto del prevaler della
destra.
De Felice (25), distinguendo un fascismo urbano da un fascismo agrario, con-
trappone temporalmente e politicamente l'uno all'altro, ipotizzando come segue: il
fascismo nasce in città (nel Nord, e Milano è la sua patria d'elezione vera, non già la
Romagna «rissosa» e «violenta») su di un terreno specificamente «di sinistra». I l
suo programma è confuso, malcerta la sua collocazione, le delimitazioni che si dà
sono vaghe; ma si muove nell'ambito dello scontento diffuso generato dalla guerra,
dalla «vi ttoria mutilata», dal le mancate promesse d i giustizia sociale, dagl i
accresciuti bisogni economici. Gli equivoci si scioglieranno nel volgere di un anno e
mezzo, precisamente intorno alla seconda metà del 1920, a cominciare dall'ultima
sconfitta proletaria (l'occupazione delle fabbriche: manco a dirlo, il Nostro carica la
mano sul tratteggio dell'insuccesso, minimizzando il significato di forza operaia che
il settembre del '20 esprime). Da allora programma politico, composizione di classe,
fini strategici del fascismo si chiariscono a destra. Su questa strada—sto sempre
esponendo l'interpretazione di De Felice —il fascismo urbano viene incoraggiato e
sospinto dall'improvviso sbocciare del fascismo rurale, che—questo si—è fin dagli
esordi foraggiato dagli agrari. Il fascismo rurale, «per la sua imponenza», si afferma
sul fascismo urbano: Mussolini e i fascisti della prima ora, «un po' per calcolo politi-
co, un po' per non perdere la direzione del movimento, un po' per un complesso di
altre circostanze e necessità [...] ne adotteranno i metodi e le finalità» (26): con la
pena nel cuore, sembra di poter aggiungere. Scendendo nei particolari, lo storico col-
loca nella tragica giornata bolognese di Palazzo D'Accursio (21 novembre 1920, «la
scintilla che mise in movimento la reazione antisocialista che covava sotto le cene-
ri») (27) il momento di «svolta» del fascismo, ovvero la nascita del fascismo di mas-
sa. Sovvenzionato e armato dai capitalisti agrari, il fascismo inizia il cammino con-
trorivoluzionario che lo porterà a Roma, comportandosi fino alla conquista del
potere come una guardia bianca.
Come si accennava, questa analisi sembra trovare conforto nei giudizi di più di
un contemporaneo della nascita del fascismO: per menzionare qualche esempio, in
campo socialista Turati e lo Zibordi, tra gli «indipendenti» Guido Dorso eGaetano
Salvemini, Luigi Sturzo per i cattolici (28). Ma va rilevato che questi osservatori
insistono sul carattere demagogico e ingannatore del «primo fascismo», facendone il
punto caratterizzante della sua fisionomia. Sugli stessi elementi di giudizio vertono
quelle analisi degli studiosi odierni che, in varia misura, accolgono il dualismo nella
nascita del movimento mussoliniano (29). In altre parole, quello che nessuno discute
più è la malafede di Mussolini e del suo movimento politico, il carattere controrivo-
luzionario non solo oggettivo ma soggettivo della sua strategia. Il fascismo, e Benito
Mussolin , non furono mai né «rivoluzionari» né «di sinistra» (30): tale la pura verità
storica.
Con questo non si vuole — ha scritto al proposito Nicola Tranfaglia — del resto,
— 129 —
















