
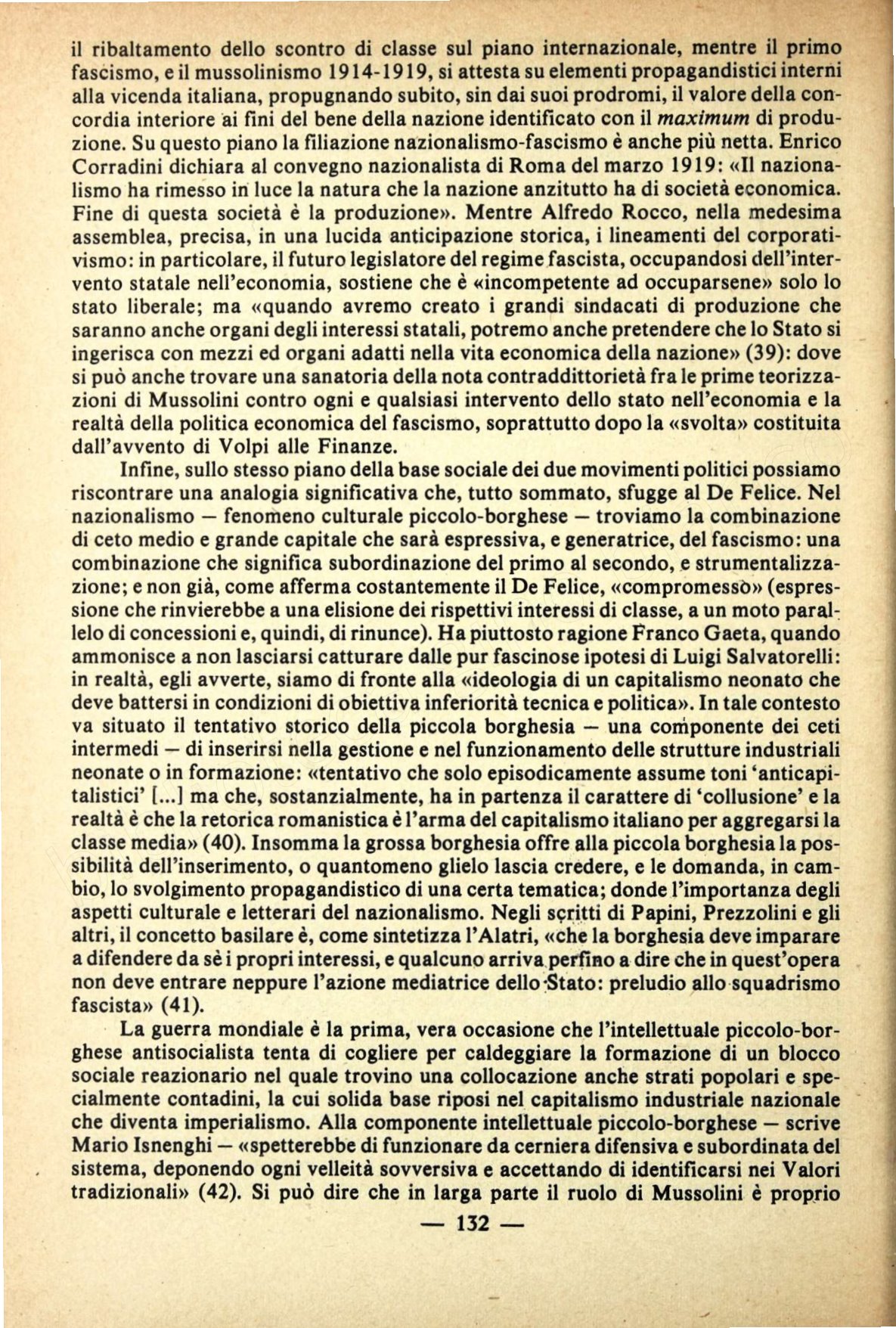
il ribaltamento dello scontro di classe sul piano internazionale, mentre i l primo
fascismo, e il mussolinismo 1914-1919, si attesta su elementi propagandistici interni
alla vicenda italiana, propugnando subito, sin dai suoi prodromi, il valore della con-
cordia interiore ai fini del bene della nazione identificato con il
maximum
di produ-
zione. Su questo piano la filiazione nazionalismo-fascismo è anche più netta. Enrico
Corradini dichiara al convegno nazionalista di Roma del marzo 1919:
«Il
naziona-
lismo ha rimesso in luce la natura che la nazione anzitutto ha di società economica.
Fine di questa società è la produzione». Mentre Alfredo Rocco, nella medesima
assemblea, precisa, in una lucida anticipazione storica, i lineamenti del corporati-
vismo: in particolare, il futuro legislatore del regime fascista, occupandosi dell'inter-
vento statale nell'economia, sostiene che è «incompetente ad occuparsene» solo lo
stato liberale; ma «quando avremo creato i grandi sindacati di produzione che
saranno anche organi degli interessi statali, potremo anche pretendere che lo Stato si
ingerisca con mezzi ed organi adatti nella vita economica della nazione» (39): dove
si può anche trovare una sanatoria della nota contraddittorietà fra le prime teorizza-
zioni di Mussolini contro ogni e qualsiasi intervento dello stato nell'economia e la
realtà della politica economica del fascismo, soprattutto dopo la «svolta» costituita
dall'avvento di Volpi alle Finanze.
Infine, sullo stesso piano della base sociale dei due movimenti politici possiamo
riscontrare una analogia significativa che, tutto sommato, sfugge al De Felice. Nel
nazionalismo—fenomeno culturale piccolo-borghese— troviamo la combinazione
di ceto medio e grande capitale che sarà espressiva, e generatrice, del fascismo: una
combinazione che significa subordinazione del primo al secondo, e strumentalizza-
zione; e non già, come afferma costantemente il De Felice, «compromesso» (espres-
sione che rinvierebbe a una elisione dei rispettivi interessi di classe, a un moto parai-.
lelo di concessioni e, quindi, di rinunce). Ha piuttosto ragione Franco Gaeta, quando
ammonisce a non lasciarsi catturare dalle pur fascinose ipotesi di Luigi Salvatorelli:
in realtà, egli avverte, siamo di fronte alla «ideologia di un capitalismo neonato che
deve battersi in condizioni di obiettiva inferiorità tecnica e politica». In tale contesto
va situato i l tentativo storico della piccola borghesia— una componente dei ceti
intermedi—di inserirsi nella gestione e nel funzionamento delle strutture industriali
neonate o in formazione: «tentativo che solo episodicamente assume toni 'anticapi-
talistici' L. ] ma che, sostanzialmente, ha in partenza il carattere di 'collusione' e la
realtà è che la retorica romanistica è l'arma del capitalismo italiano per aggregarsi la
classe media» (40). Insomma la grossa borghesia offre alla piccola borghesia la pos-
sibilità dell'inserimento, o quantomeno glielo lascia credere, e le domanda, in cam-
bio, lo svolgimento propagandistico di una certa tematica; donde l'importanza degli
aspetti culturale e letterari del nazionalismo. Negli scritti di Papini, Prezzolini e gli
altri, il concetto basilare è, come sintetizza l'Alatri, «che la borghesia deve imparare
adifendere da sè i propri interessi, e qualcuno arriva perfino a dire che in quest'opera
non deve entrare neppure l'azione mediatrice dello Stato: preludio allo squadrismo
fascista»
(41).
La guerra mondiale è la prima, vera occasione che l'intellettuale piccolo-bor-
ghese antisocialista tenta di cogliere per caldeggiare la formazione di un blocco
sociale reazionario nel quale trovino una collocazione anche strati popolari e spe-
cialmente contadini, la cui solida base riposi nel capitalismo industriale nazionale
che diventa imperialismo. Al la componente intellettuale piccolo-borghese—scrive
Mario Isnenghi—«spetterebbe di funzionare da cerniera difensiva e subordinata del
sistema, deponendo ogni velleità sovversiva e accettando di identificarsi nei Valori
tradizionali» (42). Si può dire che in larga parte i l ruolo di Mussolini è proprio
132
















