
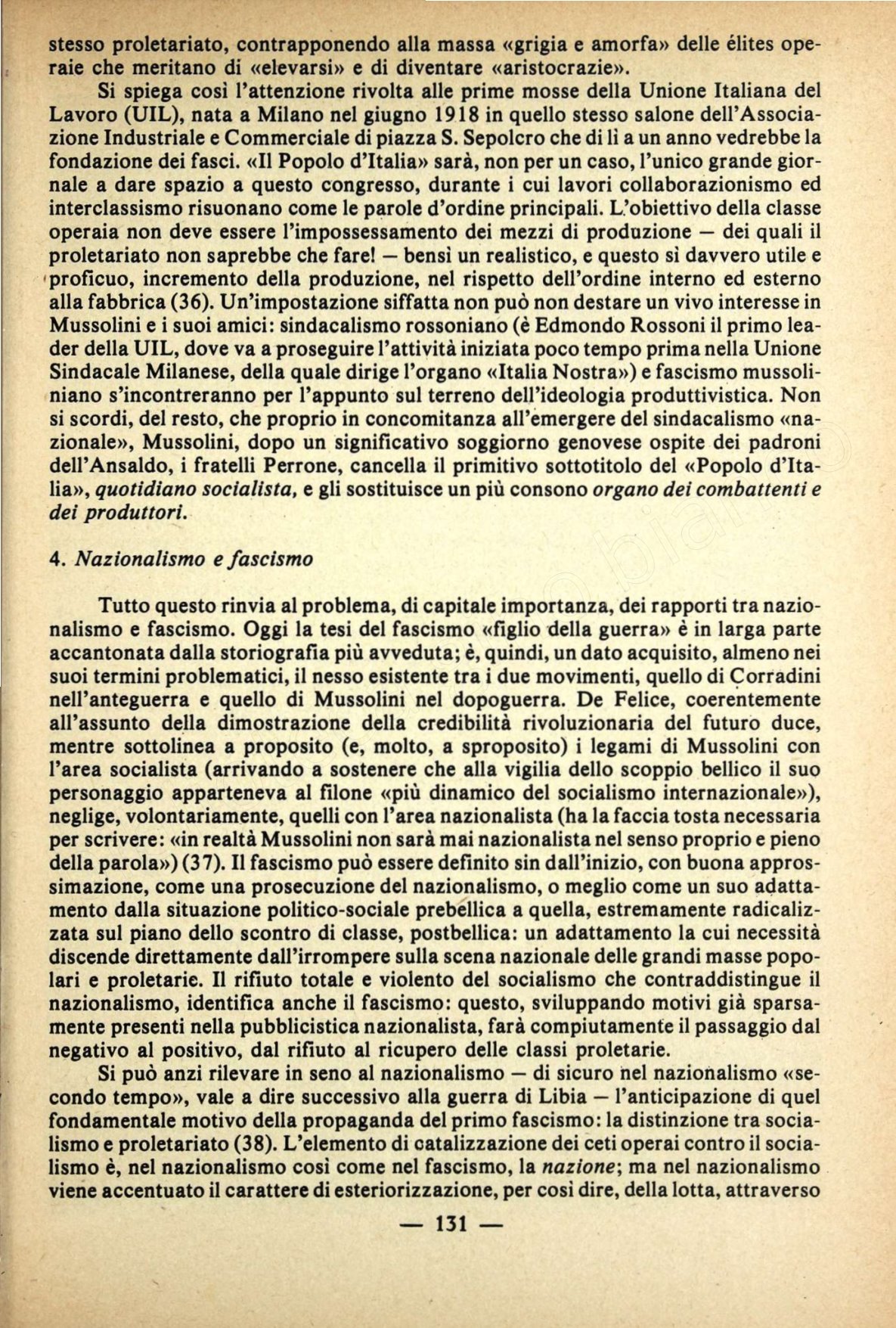
stessoproletariato, contrapponendo alla massa «grigia e amorfa» delle élites ope-
raie che meritano di «elevarsi» e di diventare «aristocrazie».
Si spiega così l'attenzione rivolta alle primemosse della Unione Italiana del
Lavoro (UIL), nata a Milano nel giugno 1918 in quello stessosalone dell'Associa-
zione Industriale eCommerciale di piazza S. Sepolcrochedi li aunanno vedrebbe la
fondazione dei fasci. «Il Popolo d'Italia» sarà, non per un caso, l'unico grande gior-
nale a dare spazio a questo congresso, durante i cui lavori collaborazionismo ed
interclassismo risuonano come le parole d'ordine principali. L'obiettivo della classe
operaia non deve essere l'impossessamento dei mezzi di produzione—dei quali il
proletariato non saprebbe che fare!—bensì un realistico, equesto sì davvero utile e
proficuo, incremento della produzione, nel rispetto dell'ordine interno ed esterno
alla fabbrica (36). Un'impostazione siffatta nonpuònondestare un vivo interesse in
Mussolini e i suoi amici: sindacalismo rossoniano (è EdmondoRossoni il primo lea-
der della UIL, dove va a proseguire l'attività iniziata poco tempo prima nella Unione
Sindacale Milanese, della quale dirige l'organo «Italia Nostra») e fascismomussoli-
niano s'incontreranno per l'appunto sul terreno dell'ideologia produttivistica. Non
si scordi, del resto, che proprio in concomitanza all'emergere del sindacalismo «na-
zionale», Mussolini, dopo un significativo soggiorno genovese ospite dei padroni
dell'Ansaldo, i fratelli Perrone, cancella il primitivo sottotitolo del «Popolo d'Ita-
lia», quotidiano socialista, e gli sostituisce un più consonoorgano dei combattenti e
dei produttori.
4. Nazionalismo e fascismo
Tutto questo rinvia al problema, di capitale importanza, dei rapporti tra nazio-
nalismo e fascismo. Oggi la tesi del fascismo «figlio della guerra» è in larga parte
accantonata dalla storiografia più avveduta; è, quindi, undato acquisito, almenonei
suoi termini problematici, il nessoesistente tra i duemovimenti, quello di C orradini
nell'anteguerra e quello di Mussolini nel dopoguerra. De Felice, coerentemente
all'assunto della dimostrazione della credibilità rivoluzionaria del futuro duce,
mentre sottolinea a proposito (e, molto, a sproposito) i legami di Mussolini con
l'area socialista (arrivando a sostenere che alla vigilia dello scoppio bellico il suo
personaggio apparteneva al filone «più dinamico del socialismo internazionale»),
neglige, volontariamente, quelli con l'area nazionalista (ha la faccia tosta necessaria
per scrivere: «in realtà Mussolini nonsaràmai nazionalista nel sensoproprioepieno
della parola») (37). Il fascismo puòesseredefinito sin dall'inizio, conbuona appros-
simazione, come una prosecuzione del nazionalismo, omeglio come un suo adatta-
mento dalla situazione politico-sociale prebellica a quella, estremamente radicaliz-
zata sul piano dello scontro di classe, postbellica: un adattamento la cui necessità
discende direttamente dall'irrompere sulla scena nazionale delle grandimassepopo-
lari e proletarie. I l rifiuto totale e violento del socialismo che contraddistingue il
nazionalismo, identifica anche il fascismo: questo, sviluppando motivi già sparsa-
mentepresenti nella pubblicistica nazionalista, farà compiutamente il passaggio dal
negativo al positivo, dal rifiuto al ricupero delle classi proletarie.
Si può anzi rilevare in seno al nazionalismo—di sicuro nel nazionalismo «se-
condo tempo», vale a dire successivo alla guerra di Libia—l'anticipazione di quel
fondamentalemotivo della propaganda del primo fascismo: la distinzione tra socia-
lismoe proletariato (38). L'elemento di catalizzazione dei ceti operai contro il socia-
lismo è, nel nazionalismo così come nel fascismo, la
nazione;
ma nel nazionalismo
viene accentuato il carattere di esteriorizzazione, per così dire, della lotta, attraverso
— 131 —
















