
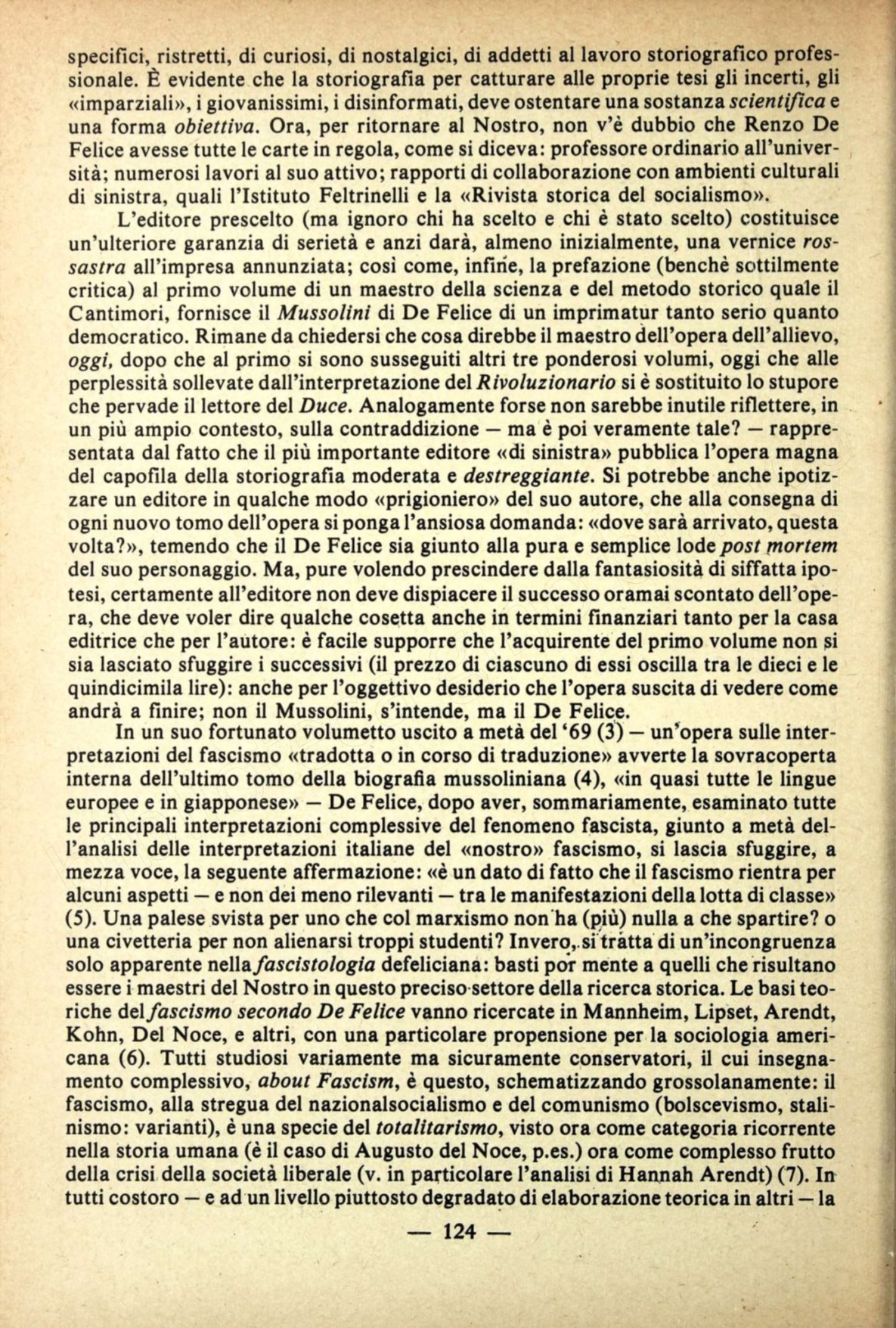
specifici, ristretti, di curiosi, di nostalgici, di addetti al lavoro storiografico profes-
sionale. É evidente che la storiografia per catturare alle proprie tesi gli incerti, gli
«imparziali», i giovanissimi, i disinformati, deve ostentare una sostanza
scientifica
e
una forma
obiettiva.
Ora, per ritornare al Nostro, non v'è dubbio che Renzo De
Felice avesse tutte le carte in regola, come si diceva: professore ordinario all'univer-
sità; numerosi lavori al suo attivo; rapporti di collaborazione con ambienti culturali
di sinistra, quali l'Istituto Feltrinelli e la «Rivista storica del socialismo».
L'editore prescelto (ma ignoro chi ha scelto e chi è stato scelto) costituisce
un'ulteriore garanzia di serietà e anzi darà, almeno inizialmente, una vernice
ros-
sastra
all'impresa annunziata; così come, infine, la prefazione (benchè sottilmente
critica) al primo volume di un maestro della scienza e del metodo storico quale il
Cantimori, fornisce il
Mussolini
di De Felice di un imprimatur tanto serio quanto
democratico. Rimane da chiedersi che cosa direbbe il maestro dell'opera dell'allievo,
oggi,
dopo che al primo si sono susseguiti altri tre ponderosi volumi, oggi che alle
perplessità sollevate dall'interpretazione del
Rivoluzionario
si
è sostituito lo stupore
che pervade il lettore del
Duce.
Analogamente forse non sarebbe inutile riflettere, in
un più ampio contesto, sulla contraddizione—ma è poi veramente tale?— rappre-
sentata dal fatto che il più importante editore «di sinistra» pubblica l'opera magna
del capofila della storiografia moderata e
destreggiante.
Si potrebbe anche ipotiz-
zare un editore in qualche modo «prigioniero» del suo autore, che alla consegna di
ogni nuovo tomo dell'opera si ponga l'ansiosa domanda: «dove sarà arrivato, questa
volta?», temendo che il De Felice sia giunto alla pura e semplice lode
post mortem
del suo personaggio. Ma, pure volendo prescindere dalla fantasiosità di siffatta ipo-
tesi, certamente all'editore non deve dispiacere il successo oramai scontato dell'ope-
ra, che deve voler dire qualche cosetta anche in termini finanziari tanto per la casa
editrice che per l'autore: è facile supporre che l'acquirente del primo volume non si
sia lasciato sfuggire i successivi (il prezzo di ciascuno di essi oscilla tra le dieci e le
quindicimila lire): anche per l'oggettivo desiderio che l'opera suscita di vedere come
andrà a finire; non i l Mussolini, s'intende, ma il De Felice.
In un suo fortunato volumetto uscito a metà del '69 (3)—un'opera sulle inter-
pretazioni del fascismo «tradotta o in corso di traduzione» avverte la sovracoperta
interna dell'ultimo tomo della biografia mussoliniana (4), «in quasi tutte le lingue
europee e in giapponese»—De Felice, dopo aver, sommariamente, esaminato tutte
le principali interpretazioni complessive del fenomeno fascista, giunto a metà del-
l'analisi delle interpretazioni italiane del «nostro» fascismo, si lascia sfuggire, a
mezza voce, la seguente affermazione: «è un dato di fatto che il fascismo rientra per
alcuni aspetti—e non dei meno rilevanti—tra le manifestazioni della lotta di classe»
(5). Una palese svista per uno che col marxismo non ha (più) nulla a che spartire? o
una civetteria per non alienarsi troppi studenti? Invero,, si trittta di un'incongruenza
solo apparente
nella fascistologia
defeliciana: basti po.r mente a quelli che risultano
essere i maestri del Nostro in questo precisasettore della ricerca storica. Le basi teo-
riche del
fascismo secondo De Felice
vanno ricercate in Mannheim, Lipset, Arendt,
Kohn, Del Noce, e altri, con una particolare propensione per la sociologia ameri-
cana (6). Tut t i studiosi variamente ma sicuramente conservatori, i l cui insegna-
mento complessivo,
about Fascism,
è questo, schematizzando grossolanamente: il
fascismo, alla stregua del nazionalsocialismo e del comunismo (bolscevismo, stali-
nismo: varianti), è una specie del
totalitarismo,
visto ora come categoria ricorrente
nella storia umana (è il caso di Augusto del Noce,
p.es.) ora come complesso frutto
della crisi della società liberale (v. in particolare l'analisi di Hannah Arendt) (7). In
tutti costoro e ad un livello piuttosto degradato di elaborazione teorica in altri—la
124
















