
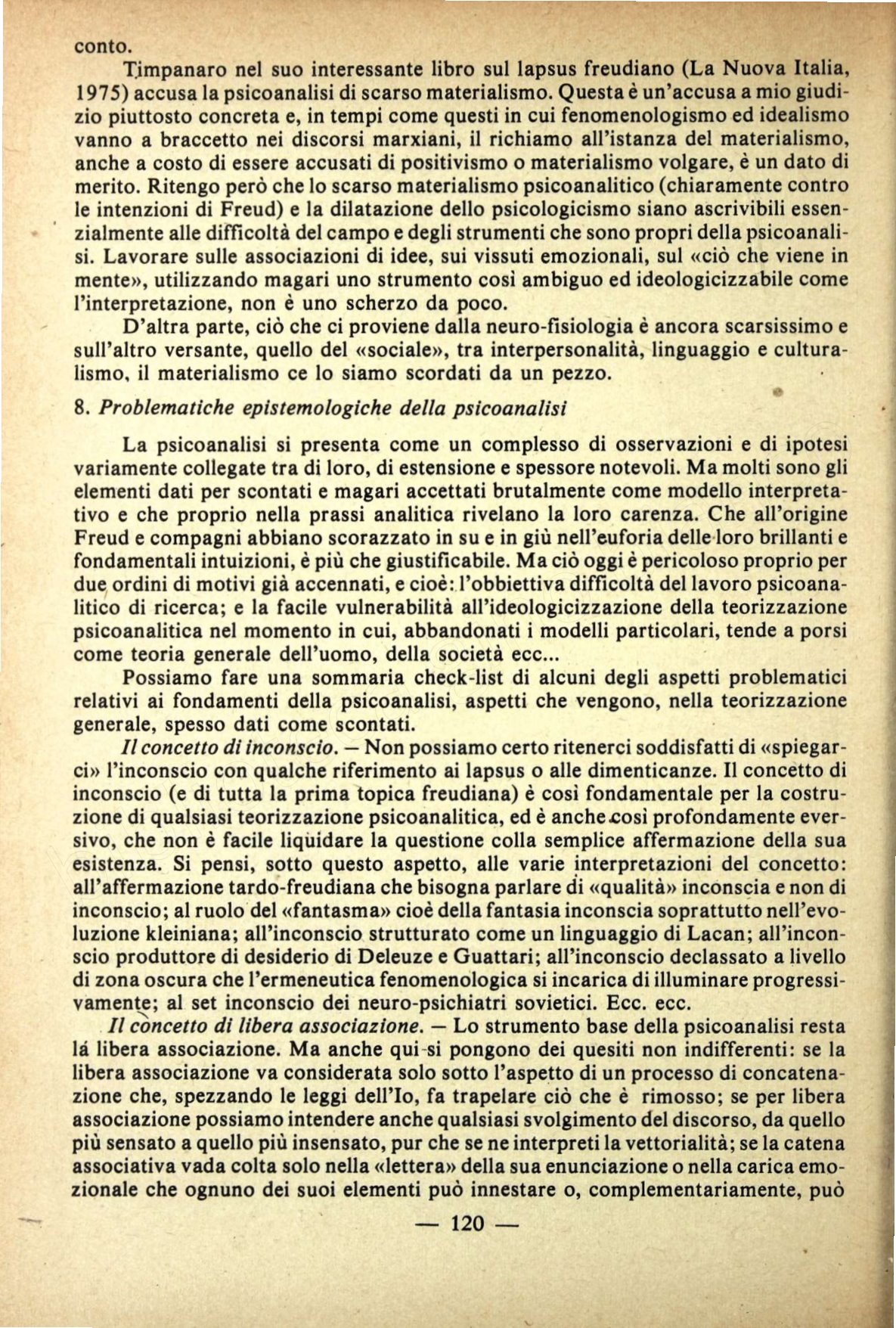
conto.
Timpanaro nel suo interessante l ibro sul lapsus freudiano (La Nuova Italia,
1975) accusa la psicoanalisi di scarso materialismo. Questa è un'accusa a mio giudi-
zio piuttosto concreta e, in tempi come questi in cui fenomenologismo ed idealismo
vanno a braccetto nei discorsi marxiani, i l richiamo all'istanza del materialismo,
anche a costo di essere accusati di positivismo o materialismo volgare, è un dato di
merito. Ritengo però che lo scarso materialismo psicoanalitico (chiaramente contro
le intenzioni di Freud) e la dilatazione dello psicologicismo siano ascrivibili essen-
zialmente alle difficoltà del campo e degli strumenti che sono propri della psicoanali-
si. Lavorare sulle associazioni di idee, sui vissuti emozionali, sul «ciò che viene in
mente», utilizzando magari uno strumento così ambiguo ed ideologicizzabile come
l'interpretazione, non è uno scherzo da poco.
D'altra parte, ciò che ci proviene dalla neuro-fisiologia è ancora scarsissimo e
sull'altro versante, quello del «sociale», tra interpersonalità, linguaggio e cultura-
lismo, i l materialismo ce lo siamo scordati da un pezzo.
8. Problematiche epistemologiche della psicoanalisi
La psicoanalisi si presenta come un complesso di osservazioni e di ipotesi
variamente collegate tra di loro, di estensione e spessore notevoli. Ma molti sono gli
elementi dati per scontati e magari accettati brutalmente come modello interpreta-
tivo e che proprio nella prassi analitica rivelano la loro carenza. Che all'origine
Freud e compagni abbiano scorazzato in su e in giù nell'euforia delle loro brillanti e
fondamentali intuizioni, è più che giustificabile. Ma ciò oggi è pericoloso proprio per
due ordini di motivi già accennati, e cioè: l'obbiettiva difficoltà del lavoro psicoana-
litico di ricerca; e la facile vulnerabilità all'ideologicizzazione della teorizzazione
psicoanalitica nel momento in cui, abbandonati i modelli particolari, tende a porsi
come teoria generale dell'uomo, della società ecc...
Possiamo fare una sommaria check-list di alcuni degli aspetti problematici
relativi ai fondamenti della psicoanalisi, aspetti che vengono, nella teorizzazione
generale, spesso dati come scontati.
11concetto di inconscio.
- Non possiamo certo ritenerci soddisfatti di «spiegar-
ci» l'inconscio con qualche riferimento ai lapsus o alle dimenticanze. I l concetto di
inconscio (e di tutta la prima topica freudiana) è così fondamentale per la costru-
zione di qualsiasi teorizzazione psicoanalitica, ed è anche così profondamente ever-
sivo, che non è facile liquidare la questione colla semplice affermazione della sua
esistenza. Si pensi, sotto questo aspetto, alle varie interpretazioni del concetto:
all'affermazione tardo-freudiana che bisogna parlare di «qualità» inconscia e non di
inconscio; al ruolo del «fantasma» cioè della fantasia inconscia soprattutto nell'evo-
luzione kleiniana; all'inconscio strutturato come un linguaggio di Lacan; all'incon-
scio produttore di desiderio di Deleuze e Guattari; all'inconscio declassato a livello
di zona oscura che l'ermeneutica fenomenologica si incarica di illuminare progressi-
vamente; al set inconscio dei neuro-psichiatri sovietici. Ecc. ecc.
I l concetto di libera associazione.
- Lo strumento base della psicoanalisi resta
là libera associazione. Ma anche qui si pongono dei quesiti non indifferenti: se la
libera associazione va considerata solo sotto l'aspetto di un processo di concatena-
zione che, spezzando le leggi dell'Io, fa trapelare ciò che è rimosso; se per libera
associazione possiamo intendere anche qualsiasi svolgimento del discorso, da quello
più sensato a quello più insensato, pur che se ne interpreti la vettorialità; se la catena
associativa vada colta solo nella «lettera» della sua enunciazione o nella carica emo-
zionale che ognuno dei suoi elementi può innestare o, complementariamente, può
120
















