
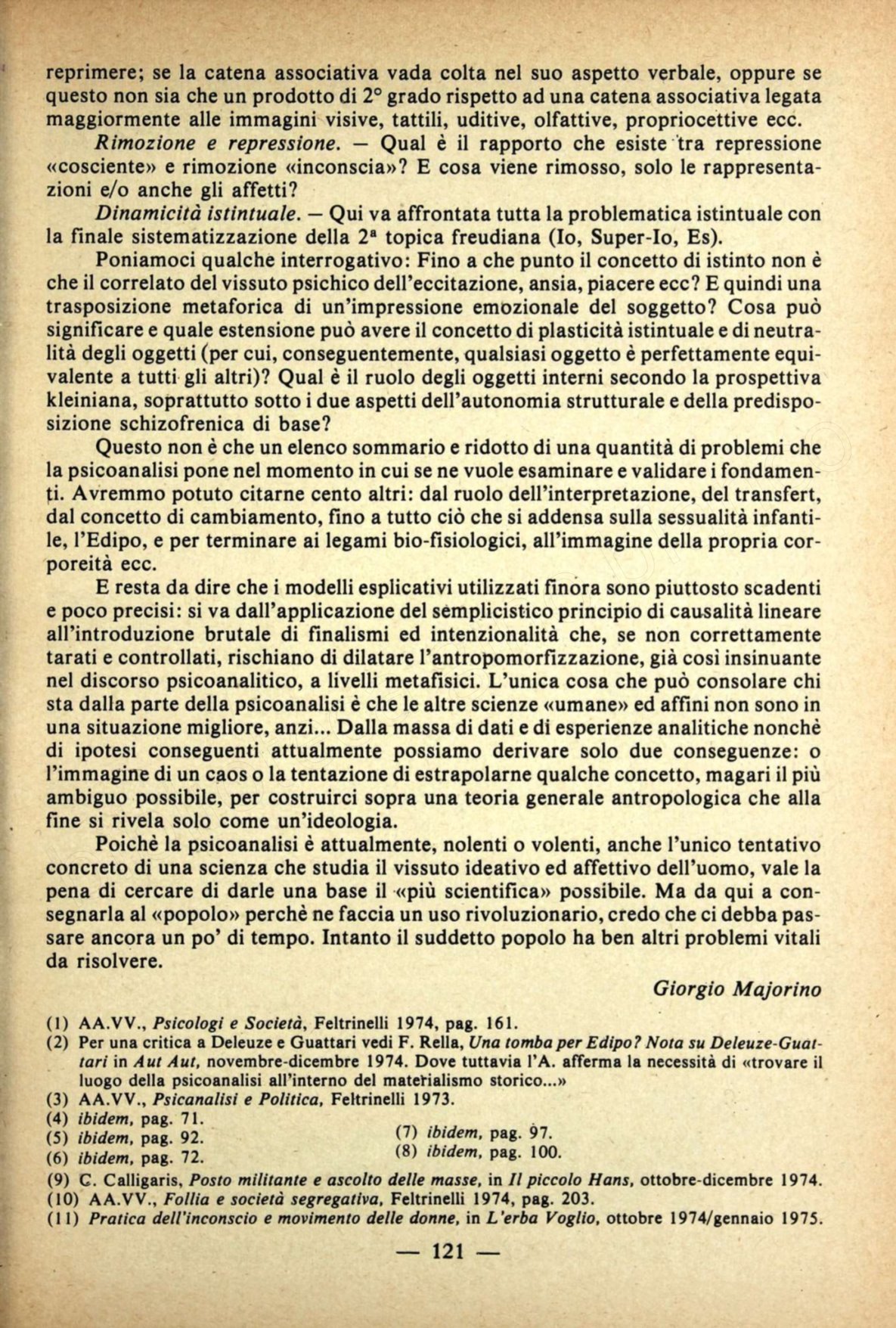
reprimere; se la catena associativa vada colta nel suo aspetto verbale, oppure se
questo non sia che un prodotto di 2° grado rispetto ad una catena associativa legata
maggiormente alle immagini visive, tattili, uditive, olfattive, propriocettive ecc.
Rimozione
e
repressione.
— Qual è i l rapporto che esiste 'tra repressione
«cosciente» e rimozione «inconscia»? E cosa viene rimosso, solo le rappresenta-
zioni e/o anche gl i affetti?
Dinamicità istintuale.
—Qui va affrontata tutta la problematica istintuale con
la finale sistematizzazione della
211
topica freudiana (Io, Super-Io, Es).
Poniamoci qualche interrogativo: Fino a che punto il concetto di istinto non è
che il correlato del vissuto psichico dell'eccitazione, ansia, piacere ecc? E quindi una
trasposizione metaforica di un'impressione emozionale del soggetto? Cosa può
significare e quale estensione può avere il concetto di plasticità istintuale e di neutra-
lità degli oggetti (per cui, conseguentemente, qualsiasi oggetto è perfettamente equi-
valente a tutti gli altri)? Qual è il ruolo degli oggetti interni secondo la prospettiva
kleiniana, soprattutto sotto i due aspetti dell'autonomia strutturale e della predispo-
sizione schizofrenica di base?
Questo non è che un elenco sommario e ridotto di una quantità di problemi che
la psicoanalisi pone nel momento in cui se ne vuole esaminare e validare i fondamen-
ti. Avremmo potuto citarne cento altri: dal ruolo dell'interpretazione, del transfert,
dal concetto di cambiamento, fino a tutto ciò che si addensa sulla sessualità infanti-
le, l'Edipo, e per terminare ai legami bio-fisiologici, all'immagine della propria cor-
poreità ecc.
E resta da dire che i modelli esplicativi utilizzati finora sono piuttosto scadenti
epoco precisi: si va dall'applicazione del semplicistico principio di causalità lineare
all'introduzione brutale di finalismi ed intenzionalità che, se non correttamente
tarati e controllati, rischiano di dilatare l'antropomorfizzazione, già così insinuante
nel discorso psicoanalitico, a livelli metafisici. L'unica cosa che può consolare chi
sta dalla parte della psicoanalisi è che le altre scienze «umane» ed affini non sono in
una situazione migliore, anzi... Dalla massa di dati e di esperienze analitiche nonché
di ipotesi conseguenti attualmente possiamo derivare solo due conseguenze: o
l'immagine di un caos o la tentazione di estrapolarne qualche concetto, magari il più
ambiguo possibile, per costruirci sopra una teoria generale antropologica che alla
fine si rivela solo come un'ideologia.
Poiché la psicoanalisi è attualmente, nolenti o volenti, anche l'unico tentativo
concreto di una scienza che studia il vissuto ideativo ed affettivo dell'uomo, vale la
pena di cercare di darle una base i l «più scientifica» possibile. Ma da qui a con-
segnarla al «popolo» perchè ne faccia un uso rivoluzionario, credo che ci debba pas-
sare ancora un po' di tempo. Intanto il suddetto popolo ha ben altri problemi vitali
da risolvere.
Giorgio Majorino
( I )
AA.VV.,
Psicologi
e
Società,
Feltrinelli 1974, pag. 161.
(2) Per una critica a Deleuze e Guattari vedi F. Rella,
Una tomba per Edipo? Nota su Deleuze-Guat-
tari in Aut Aut,
novembre-dicembre 1974. Dove tuttavia l 'A. afferma la necessità di «trovare il
luogo della psicoanalisi all'interno del materialismo storico...»
(3)
AA.VV.,
Psicanalisi
e
Politica,
Feltrinelli 1973.
(4)
ibidem,
pag. 71.
(5)
ibidem,
pag. 92.
(
7 )
ibidem,
pag. 97.
(6)
ibidem,
pag. 72.
(
8 )
ibidem,
pag. 100.
(9) C. Calligaris, Posto militante e ascolto delle masse, in I l piccolo Hans, ottobre-dicembre 1974.
(10)
AA.VV. ,
Fol l ia
e
società segregativa,
Feltrinelli 1974, pag. 203.
( l i ) Prat ica dell'inconscio e movimento delle donne, in L'erba Voglio, ottobre 1974/gennaio 1975.
121 —
















