
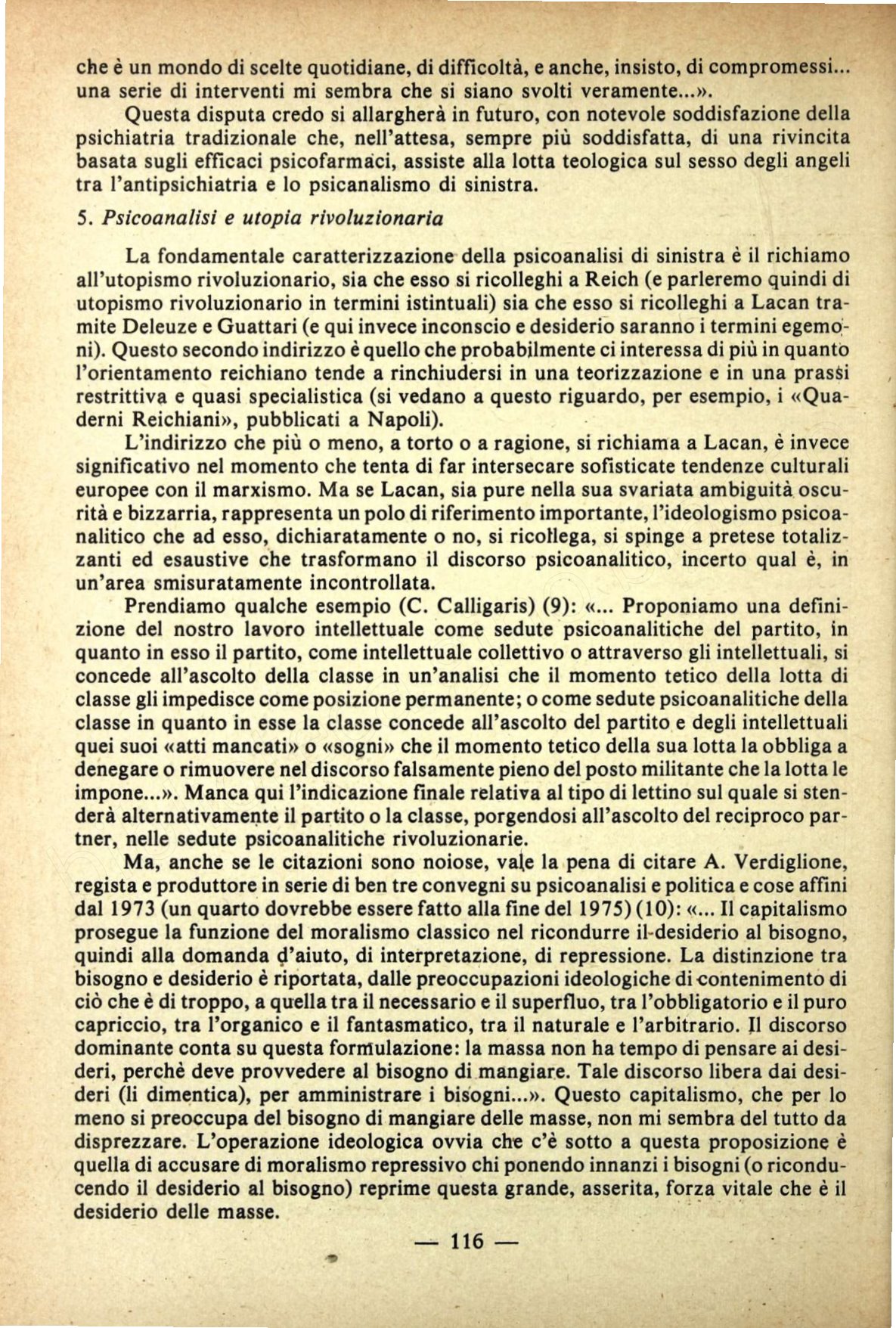
che è un mondo di scelte quotidiane, di difficoltà, e anche, insisto, di compromessi...
una serie di interventi mi sembra che si siano svolti veramente...».
Questa disputa credo si allargherà in futuro, con notevole soddisfazione della
psichiatria tradizionale che, nell'attesa, sempre più soddisfatta, di una rivincita
basata sugli efficaci psicofarmaci, assiste alla lotta teologica sul sesso degli angeli
tra l'antipsichiatria e lo psicanalismo di sinistra.
5. Psicoanalisi e utopia rivoluzionaria
La fondamentale caratterizzazione della psicoanalisi di sinistra è il richiamo
all'utopismo rivoluzionario, sia che esso si ricolleghi a Reich (e parleremo quindi di
utopismo rivoluzionario in termini istintuali) sia che esso si ricolleghi a Lacan tra-
mite Deleuze e Guattari (e qui invece inconscio e desiderio saranno i termini egemo-
ni). Questo secondo indirizzo è quello che probabilmente ci interessa di più in quanto
l'orientamento reichiano tende a rinchiudersi in una teorizzazione e in una prassi
restrittiva e quasi specialistica (si vedano a questo riguardo, per esempio, i «Qua-
derni Reichiani», pubblicati a Napoli).
L'indirizzo che più o meno, a torto o a ragione, si richiama a Lacan, è invece
significativo nel momento che tenta di far intersecare sofisticate tendenze culturali
europee con il marxismo. Ma se Lacan, sia pure nella sua svariata ambiguità oscu-
rità e bizzarria, rappresenta un polo di riferimento importante, l'ideologismo psicoa-
nalitico che ad esso, dichiaratamente o no, si ricollega, si spinge a pretese totaliz-
zanti ed esaustive che trasformano i l discorso psicoanalitico, incerto qual è, in
un'area smisuratamente incontrollata.
Prendiamo qualche esempio (C. C alligaris) (9): «... Proponiamo una defini-
zione del nostro lavoro intellettuale come sedute psicoanalitiche del partito, in
quanto in esso il partito, come intellettuale collettivo o attraverso gli intellettuali, si
concede all'ascolto della classe in un'analisi che i l momento tetico della lotta di
classe gli impedisce come posizione permanente; o come sedute psicoanalitiche della
classe in quanto in esse la classe concede all'ascolto del partito e degli intellettuali
quei suoi «atti mancati» o «sogni» che il momento tetico della sua lotta la obbliga a
denegare o rimuovere nel discorso falsamente pieno del posto militante che la lotta le
impone...». Manca qui l'indicazione finale relativa al tipo di lettino sul quale si sten-
derà alternativamente il partito o la classe, porgendosi all'ascolto del reciproco par-
tner, nelle sedute psicoanalitiche rivoluzionarie.
Ma, anche se le citazioni sono noiose, vate la pena di citare A. Verdiglione,
regista e produttore in serie di ben tre convegni su psicoanalisi e politica e cose affini
dal 1973 (un quarto dovrebbe essere fatto alla fine del 1975) (10): «... Il capitalismo
prosegue la funzione del moralismo classico nel ricondurre il-desiderio al bisogno,
quindi alla domanda d'aiuto, di interpretazione, di repressione. La distinzione tra
bisogno e desiderio è riportata, dalle preoccupazioni ideologiche di contenimento di
ciò che è di troppo, a quella tra il necessario e il superfluo, tra l'obbligatorio e il puro
capriccio, tra l'organico e i l fantasmatico, tra il naturale e l'arbitrario. I l discorso
dominante conta su questa formulazione: la massa non ha tempo di pensare ai desi-
deri, perchè deve provvedere al bisogno di mangiare. Tale discorso libera dai desi-
deri (l i dimentica), per amministrare i bisogni...». Questo capitalismo, che per lo
meno si preoccupa del bisogno di mangiare delle masse, non mi sembra del tutto da
disprezzare. L'operazione ideologica ovvia che c'è sotto a questa proposizione è
quella di accusare di moralismo repressivo chi ponendo innanzi i bisogni (o ricondu-
cendo il desiderio al bisogno) reprime questa grande, asserita, forza vitale che è il
desiderio delle masse.
116
















