
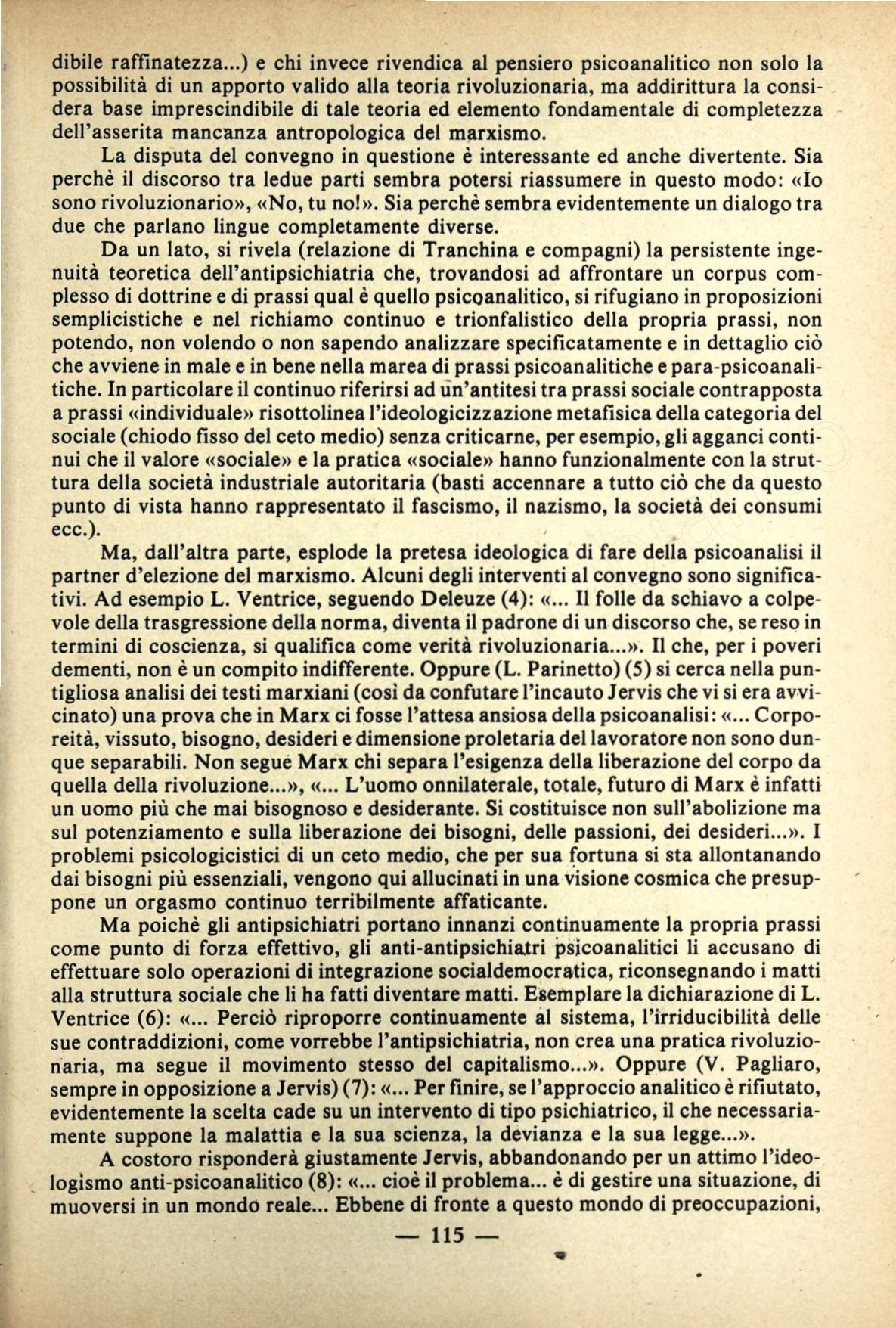
dibile raffinatezza...) e chi invece rivendica al pensiero psicoanalitico non solo la
possibilità di un apporto valido alla teoria rivoluzionaria, ma addirittura la consi-
dera base imprescindibile di tale teoria ed elemento fondamentale di completezza
dell'asserita mancanza antropologica del marxismo.
La disputa del convegno in questione è interessante ed anche divertente. Sia
perché i l discorso tra ledue parti sembra potersi riassumere in questo modo: «Io
sono rivoluzionario», «No, tu no!». Sia perché sembra evidentemente un dialogo tra
due che parlano lingue completamente diverse.
Da un lato, si rivela (relazione di Tranchina e compagni) la persistente inge-
nuità teoretica dell'antipsichiatria che, trovandosi ad affrontare un corpus com-
plesso di dottrine e di prassi qual è quello psicoanalitico, si rifugiano in proposizioni
semplicistiche e nel richiamo continuo e trionfalistico della propria prassi, non
potendo, non volendo o non sapendo analizzare specificatamente e in dettaglio ciò
che avviene in male e in bene nella marea di prassi psicoanalitiche e para-psicoan ali-
tiche. In particolare il continuo riferirsi ad un'antitesi tra prassi sociale contrapposta
aprassi «individuale» risottolinea l'ideologicizzazione metafisica della categoria del
sociale (chiodo fisso del ceto medio) senza criticarne, per esempio, gli agganci conti-
nui che il valore «sociale» e la pratica «sociale» hanno funzionalmente con la strut-
tura della società industriale autoritaria (basti accennare a tutto ciò che da questo
punto di vista hanno rappresentato il fascismo, il nazismo, la società dei consumi
ecc.).
Ma, dall'altra parte, esplode la pretesa ideologica di fare della psicoanalisi il
partner d'elezione del marxismo. Alcuni degli interventi al convegno sono significa-
tivi. Ad esempio L. Ventrice, seguendo Deleuze (4): «... Il folle da schiavo a colpe-
vole della trasgressione della norma, diventa il padrone di un discorso che, se reso in
termini di coscienza, si qualifica come verità rivoluzionaria...». I l che, per i poveri
dementi, non è un compito indifferente Oppure (L. Parinetto) (5) si cerca nella pun-
tigliosa analisi dei testi marxiani (così da confutare l'incauto Jervis che vi si era avvi-
cinato) una prova che in Marx ci fosse l'attesa ansiosa della psicoanalisi: «... Corpo-
reità, vissuto, bisogno, desideri e dimensione proletaria del lavoratore non sono dun-
que separabili. Non segue Marx chi separa l'esigenza della liberazione del corpo da
quella della rivoluzione...», «... L'uomo onnilaterale, totale, futuro di Marx è infatti
un uomo più che mai bisognoso e desiderante. Si costituisce non sull'abolizione ma
sul potenziamento e sulla liberazione dei bisogni, delle passioni, dei desideri...». I
problemi psicologicistici di un ceto medio, che per sua fortuna si sta allontanando
dai bisogni più essenziali, vengono qui allucinati in una visione cosmica che presup-
pone un orgasmo continuo terribilmente affaticante.
Ma poiché gli antipsichiatri portano innanzi continuamente la propria prassi
come punto di forza effettivo, gli anti-antipsichiatri Psicoanalitici l i accusano di
effettuare solo operazioni di integrazione socialdemocratica, riconsegnando i matti
alla struttura sociale che li ha fatti diventare matti. Esemplare la dichiarazione di L.
Ventrice (6): «... Perciò riproporre continuamente al sistema, l'irriducibilità delle
sue contraddizioni, come vorrebbe l'antipsichiatria, non crea una pratica rivoluzio-
naria, ma segue i l movimento stesso del capitalismo...». Oppure (V. Pagliaro,
sempre in opposizione a Jervis) (7): «... Per finire, se l'approccio analitico è rifiutato,
evidentemente la scelta cade su un intervento di tipo psichiatrico, il che necessaria-
mente suppone la malattia e la sua scienza, la devianza e la sua legge...».
A costoro risponderà giustamente Jervis, abbandonando per un attimo l'ideo-
logismo anti-psicoanalitico (8): «... cioè il problema... è di gestire una situazione, di
muoversi in un mondo reale... Ebbene di fronte a questo mondo di preoccupazioni,
115
















