
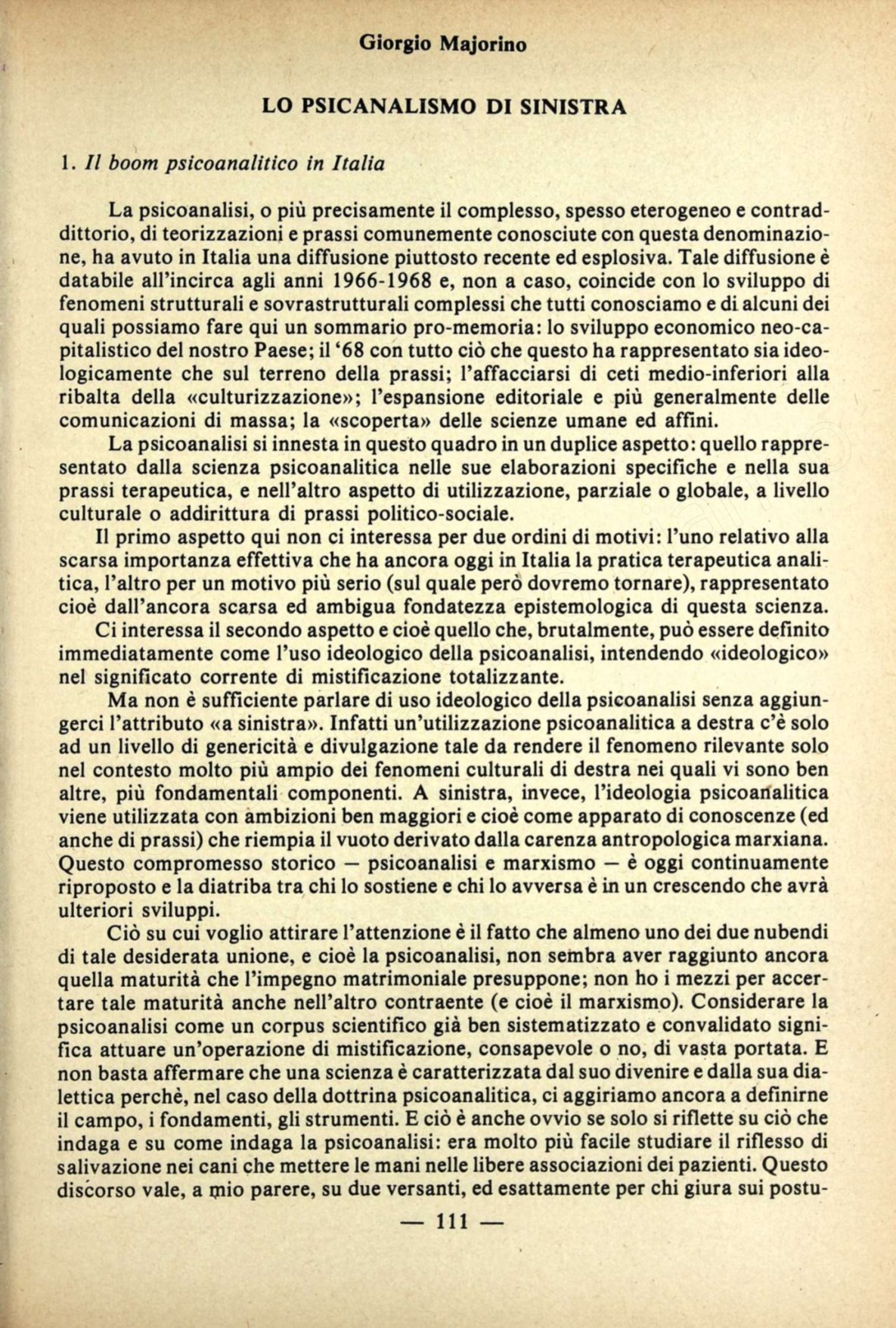
Giorgio Majorino
LO PSICANALISMO DI SINISTRA
1. I l boom psicoanalitico in Ital ia
La psicoanalisi, o più precisamente il complesso, spesso eterogeneo e contrad-
dittorio, di teorizzazioni e prassi comunemente conosciute con questa denominazio-
ne, ha avuto in Italia una diffusione piuttosto recente ed esplosiva. Tale diffusione è
databile all'incirca agli anni 1966-1968 e, non a caso, coincide con lo sviluppo di
fenomeni strutturali e sovrastrutturali complessi che tutti conosciamo e di alcuni dei
quali possiamo fare qui un sommario pro-memoria: lo sviluppo economico neo-ca-
pitalistico del nostro Paese; il '68 con tutto ciò che questo ha rappresentato sia ideo-
logicamente che sul terreno della prassi; l'affacciarsi di ceti medio-inferiori alla
ribalta della «culturizzazione»; l'espansione editoriale e più generalmente delle
comunicazioni di massa; la «scoperta» delle scienze umane ed affini.
La psicoanalisi si innesta in questo quadro in un duplice aspetto: quello rappre-
sentato dalla scienza psicoanalitica nelle sue elaborazioni specifiche e nella sua
prassi terapeutica, e nell'altro aspetto di utilizzazione, parziale o globale, a livello
culturale o addirittura di prassi politico-sociale.
Il primo aspetto qui non ci interessa per due ordini di motivi: l'uno relativo alla
scarsa importanza effettiva che ha ancora oggi in Italia la pratica terapeutica anali-
tica, l'altro per un motivo più serio (sul quale però dovremo tornare), rappresentato
cioè dall'ancora scarsa ed ambigua fondatezza epistemologica di questa scienza.
Ci interessa il secondo aspetto e cioè quello che, brutalmente, può essere definito
immediatamente come l'uso ideologico della psicoanalisi, intendendo «ideologico»
nel significato corrente di mistificazione totalizzante.
Ma non è sufficiente parlare di uso ideologico della psicoanalisi senza aggiun-
gerci l'attributo «a sinistra». Infatti un'utilizzazione psicoanalitica a destra c'è solo
ad un livello di genericità e divulgazione tale da rendere il fenomeno rilevante solo
nel contesto molto più ampio dei fenomeni culturali di destra nei quali vi sono ben
altre, più fondamentali componenti. A sinistra, invece, l'ideologia psicoanalitica
viene utilizzata con ambizioni ben maggiori e cioè come apparato di conoscenze (ed
anche di prassi) che riempia il vuoto derivato dalla carenza antropologica marxiana.
Questo compromesso storico —psicoanalisi e marxismo—è oggi continuamente
riproposto e la diatriba tra chi lo sostiene e chi lo avversa è in un crescendo che avrà
ulteriori sviluppi.
Ciò su cui voglio attirare l'attenzione è il fatto che almeno uno dei due nubendi
di tale desiderata unione, e cioè la psicoanalisi, non sembra aver raggiunto ancora
quella maturità che l'impegno matrimoniale presuppone; non ho i mezzi per accer-
tare tale maturità anche nell'altro contraente (e cioè il marxismo). Considerare la
psicoanalisi come un corpus scientifico già ben sistematizzato e convalidato signi-
fica attuare un'operazione di mistificazione, consapevole o no, di vasta portata. E
non basta affermare che una scienza è caratterizzata dal suo divenire e dalla sua dia-
lettica perchè, nel caso della dottrina psicoanalitica, ci aggiriamo ancora a definirne
il campo, i fondamenti, gli strumenti. E ciò è anche ovvio se solo si riflette su ciò che
indaga e su come indaga la psicoanalisi: era molto più facile studiare il riflesso di
salivazione nei cani che mettere le mani nelle libere associazioni dei pazienti. Questo
disCorso vale, a mio parere, su due versanti, ed esattamente per chi giura sui postu-
- 111
















