
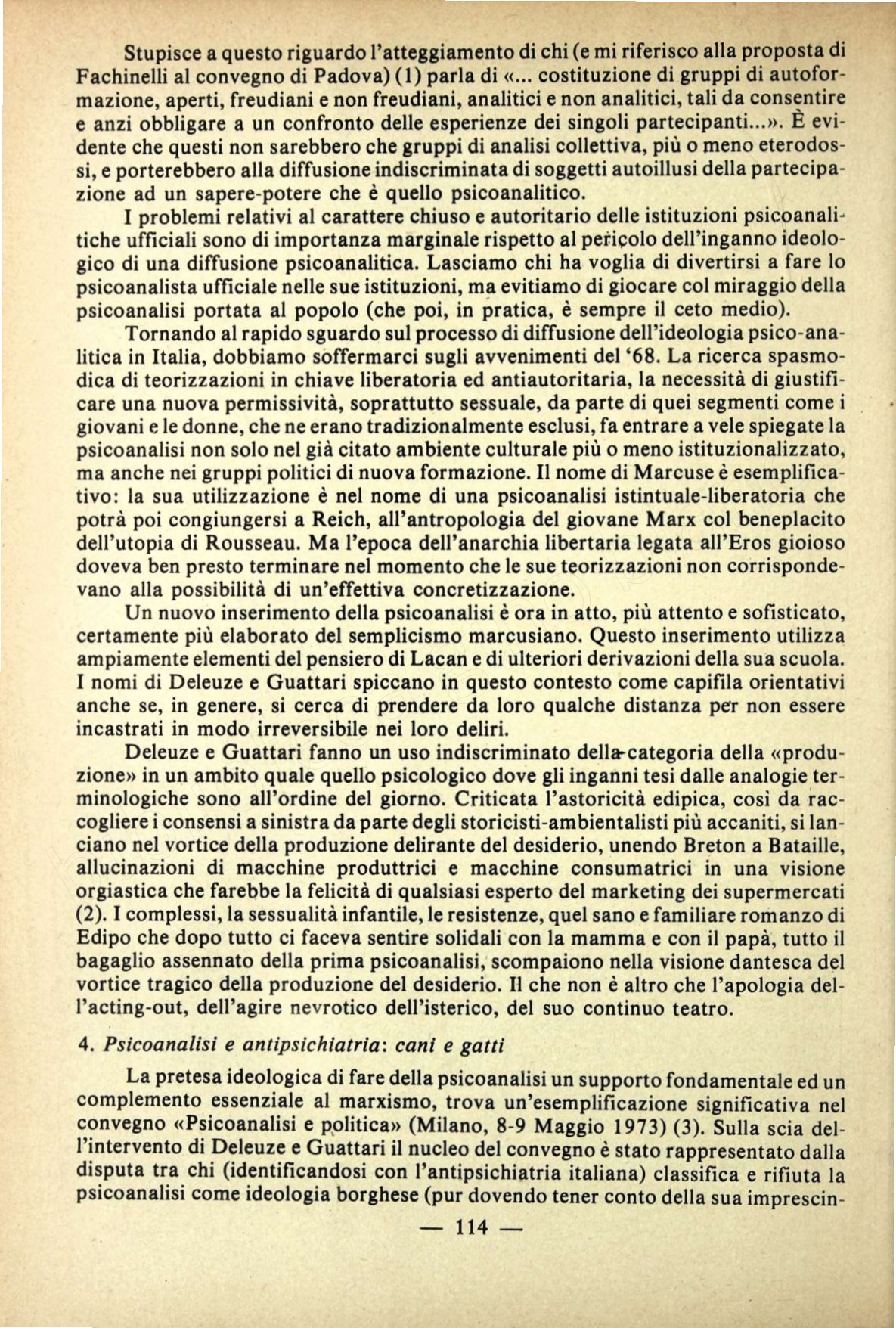
Stupisce a questo riguardo l'atteggiamento di chi (e mi riferisco alla proposta di
Fachinelli al convegno di Padova) (1) parla di «... costituzione di gruppi di autofor-
mazione, aperti, freudiani e non freudiani, analitici e non analitici, tali da consentire
eanzi obbligare a un confronto delle esperienze dei singoli partecipanti...». È evi-
dente che questi non sarebbero che gruppi di analisi collettiva, più o meno eterodos-
si, e porterebbero alla diffusione indiscriminata di soggetti autoillusi della partecipa-
zione ad un sapere-potere che è quello psicoanalitico.
I problemi relativi al carattere chiuso e autoritario delle istituzioni psicoanali-
tiche ufficiali sono di importanza marginale rispetto al pericolo dell'inganno ideolo-
gico di una diffusione psicoanalitica. Lasciamo chi ha voglia di divertirsi a fare lo
psicoanalista ufficiale nelle sue istituzioni, ma evitiamo di giocare col miraggio della
psicoanalisi portata al popolo (che poi, in pratica, è sempre i l ceto medio).
Tornando al rapido sguardo sul processo di diffusione dell'ideologia psico-ana-
litica in Italia, dobbiamo soffermarci sugli avvenimenti del '68. La ricerca spasmo-
dica di teorizzazioni in chiave liberatoria ed antiautoritaria, la necessità di giustifi-
care una nuova permissività, soprattutto sessuale, da parte di quei segmenti come i
giovani e le donne, che ne erano tradizionalmente esclusi, fa entrare a vele spiegate la
psicoanalisi non solo nel già citato ambiente culturale più o meno istituzionalizzato,
ma anche nei gruppi politici di nuova formazione. Il nome di Marcuse è esemplifica-
tivo: la sua utilizzazione è nel nome di una psicoanalisi istintuale-liberatoria che
potrà poi congiungersi a Reich, all'antropologia del giovane Marx col beneplacito
dell'utopia di Rousseau. Ma l'epoca dell'anarchia libertaria legata all'Eros gioioso
doveva ben presto terminare nel momento che le sue teorizzazioni non corrisponde-
vano alla possibilità di un'effettiva concretizzazione.
Un nuovo inserimento della psicoanalisi è ora in atto, più attento e sofisticato,
certamente più elaborato del semplicismo marcusiano. Questo inserimento utilizza
ampiamente elementi del pensiero di Lacan e di ulteriori derivazioni della sua scuola.
I nomi di Deleuze e Guattari spiccano in questo contesto come capifila orientativi
anche se, in genere, si cerca di prendere da loro qualche distanza per non essere
incastrati in modo irreversibile nei loro deliri.
Deleuze e Guattari fanno un uso indiscriminato della-categoria della «produ-
zione» in un ambito quale quello psicologico dove gli inganni tesi dalle analogie ter-
minologiche sono all'ordine del giorno. Criticata l'astoricità edipica, così da rac-
cogliere i consensi a sinistra da parte degli storicisti-ambientalisti più accaniti, si lan-
ciano nel vortice della produzione delirante del desiderio, unendo Breton a Bataille,
allucinazioni d i macchine produttrici e macchine consumatrici i n una visione
orgiastica che farebbe la felicità di qualsiasi esperto del marketing dei supermercati
(2). I complessi, la sessualità infantile, le resistenze, quel sano e familiare romanzo di
Edipo che dopo tutto ci faceva sentire solidali con la mamma e con il papà, tutto il
bagaglio assennato della prima psicoanalisi, scompaiono nella visione dantesca del
vortice tragico della produzione del desiderio. I l che non è altro che l'apologia del-
l'acting-out, dell'agire nevrotico dell'isterico, del suo continuo teatro.
4. Psicoanalisi e antipsichiatria: cani e gatti
La pretesa ideologica di fare della psicoanalisi un supporto fondamentale ed un
complemento essenziale al marxismo, trova un'esemplificazione significativa nel
convegno «Psicoanalisi e politica» (Milano, 8-9 Maggio 1973) (3). Sulla scia del-
l'intervento di Deleuze e Guattari il nucleo del convegno è stato rappresentato dalla
disputa tra chi (identificandosi con l'antipsichiatria italiana) classifica e rifiuta la
psicoanalisi come ideologia borghese (pur dovendo tener conto della sua imprescin-
114
















