
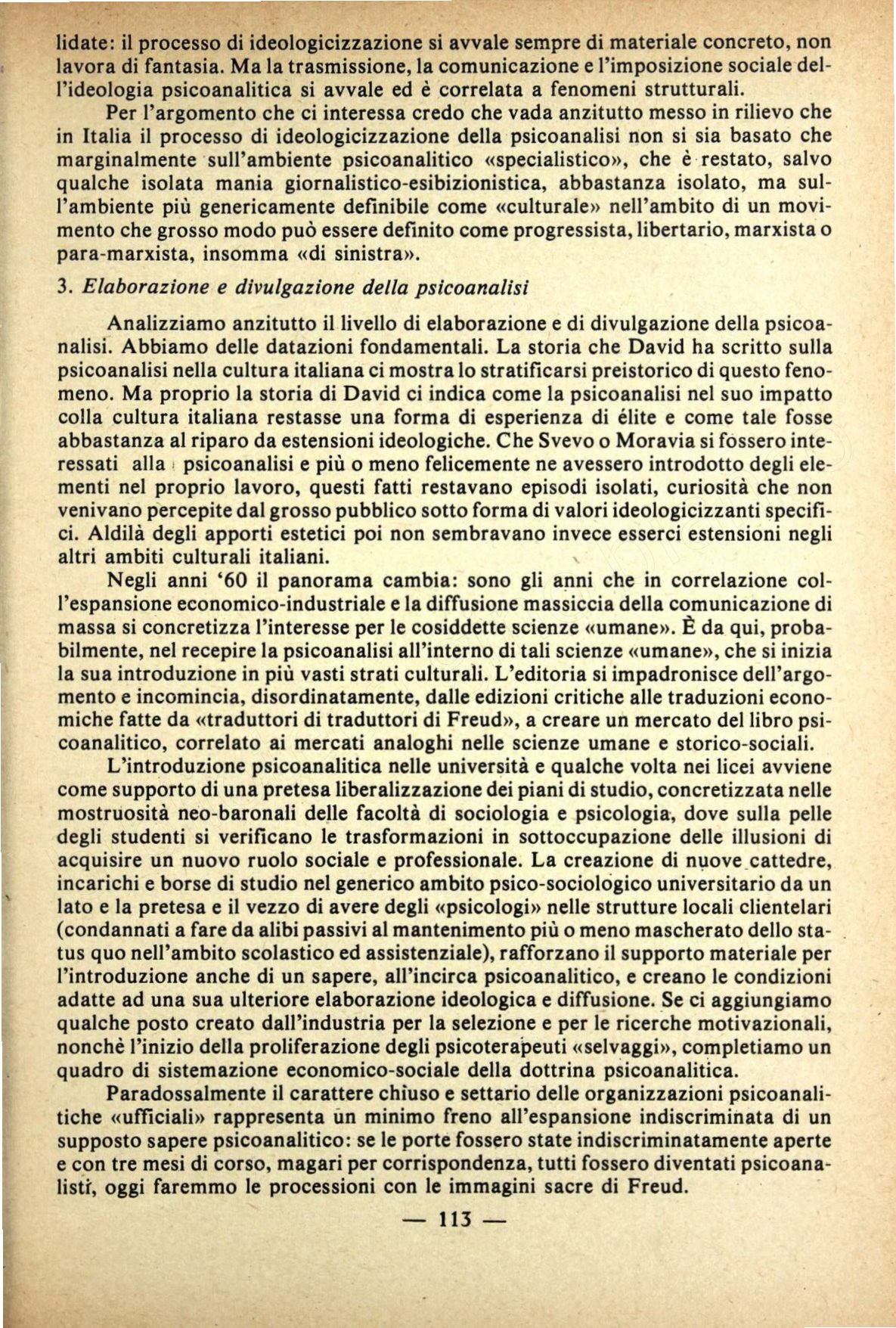
lidate: il processo di ideologicizzazione si avvale sempre di materiale concreto, non
lavora di fantasia. Ma la trasmissione, la comunicazione e l'imposizione sociale del-
l'ideologia psicoanalitica si avvale ed è correlata a fenomeni strutturali.
Per l'argomento che ci interessa credo che vada anzitutto messo in rilievo che
in Ital ia i l processo di ideologicizzazione della psicoanalisi non si sia basato che
marginalmente sull'ambiente psicoanalitico «specialistico», che è restato, salvo
qualche isolata mania giornalistico-esibizionistica, abbastanza isolato, ma sul-
l'ambiente più genericamente definibile come «culturale» nell'ambito di un movi-
mento che grosso modo può essere definito come progressista, libertario, marxista o
para-marxista, insomma «di sinistra».
3. Elaborazione e divulgazione della psicoanalisi
Analizziamo anzitutto il livello di elaborazione e di divulgazione della psicoa-
nalisi. Abbiamo delle datazioni fondamentali. La storia che David ha scritto sulla
psicoanalisi nella cultura italiana ci mostra lo stratificarsi preistorico di questo feno-
meno. Ma proprio la storia di David ci indica come la psicoanalisi nel suo impatto
colla cultura italiana restasse una forma di esperienza di élite e come tale fosse
abbastanza al riparo da estensioni ideologiche. Che Svevo o Moravia si fossero inte-
ressati al la psicoanal isi e più o meno felicemente ne avessero introdotto degli ele-
menti nel proprio lavoro, questi fatt i restavano episodi isolati, curiosità che non
venivano percepite dal grosso pubblico sotto forma di valori ideologicizzanti specifi-
ci. Aldi là degli apporti estetici poi non sembravano invece esserci estensioni negli
altri ambiti culturali italiani.
Negli anni '60 i l panorama cambia: sono gl i anni che in correlazione col-
l'espansione economico-industriale e la diffusione massiccia della comunicazione di
massa si concretizza l'interesse per le cosiddette scienze «umane». É da qui, proba-
bilmente, nel recepire la psicoanalisi all'interno di tali scienze «umane», che si inizia
la sua introduzione in più vasti strati culturali. L'editoria si impadronisce dell'argo-
mento e incomincia, disordinatamente, dalle edizioni critiche alle traduzioni econo-
miche fatte da «traduttori di traduttori di Freud», a creare un mercato del libro psi-
coanalitico, correlato ai mercati analoghi nelle scienze umane e storico-sociali.
L'introduzione psicoanalitica nelle università e qualche volta nei licei avviene
come supporto di una pretesa liberalizzazione dei piani di studio, concretizzata nelle
mostruosità neo-baronali delle facoltà di sociologia e psicologia, dove sulla pelle
degli studenti si verificano le trasformazioni in sottoccupazione delle illusioni di
acquisire un nuovo ruolo sociale e professionale. La creazione di nuove cattedre,
incarichi e borse di studio nel generico ambito psico-sociologico universitario da un
lato e la pretesa e il vezzo di avere degli «psicologi» nelle strutture locali clientelari
(condannati a fare da alibi passivi al mantenimento più o meno mascherato dello sta-
tus quo nell'ambito scolastico ed assistenziale), rafforzano il supporto materiale per
l'introduzione anche di un sapere, all'incirca psicoanalitico, e creano le condizioni
adatte ad una sua ulteriore elaborazione ideologica e diffusione. Se ci aggiungiamo
qualche posto creato dall'industria per la selezione e per le ricerche motivazionali,
nonché l'inizio della proliferazione degli psicoterapeuti «selvaggi», completiamo un
quadro di sistemazione economico-sociale della dottrina psicoanalitica.
Paradossalmente il carattere chiuso e settario delle organizzazioni psicoanali-
tiche «ufficiali» rappresenta un minimo freno all'espansione indiscriminata di un
supposto sapere psicoanalitico: se le porte fossero state indiscriminatamente aperte
econ tre mesi di corso, magari per corrispondenza, tutti fossero diventati psicoana-
listi, oggi faremmo le processioni con le immagini sacre di Freud.
113
















