
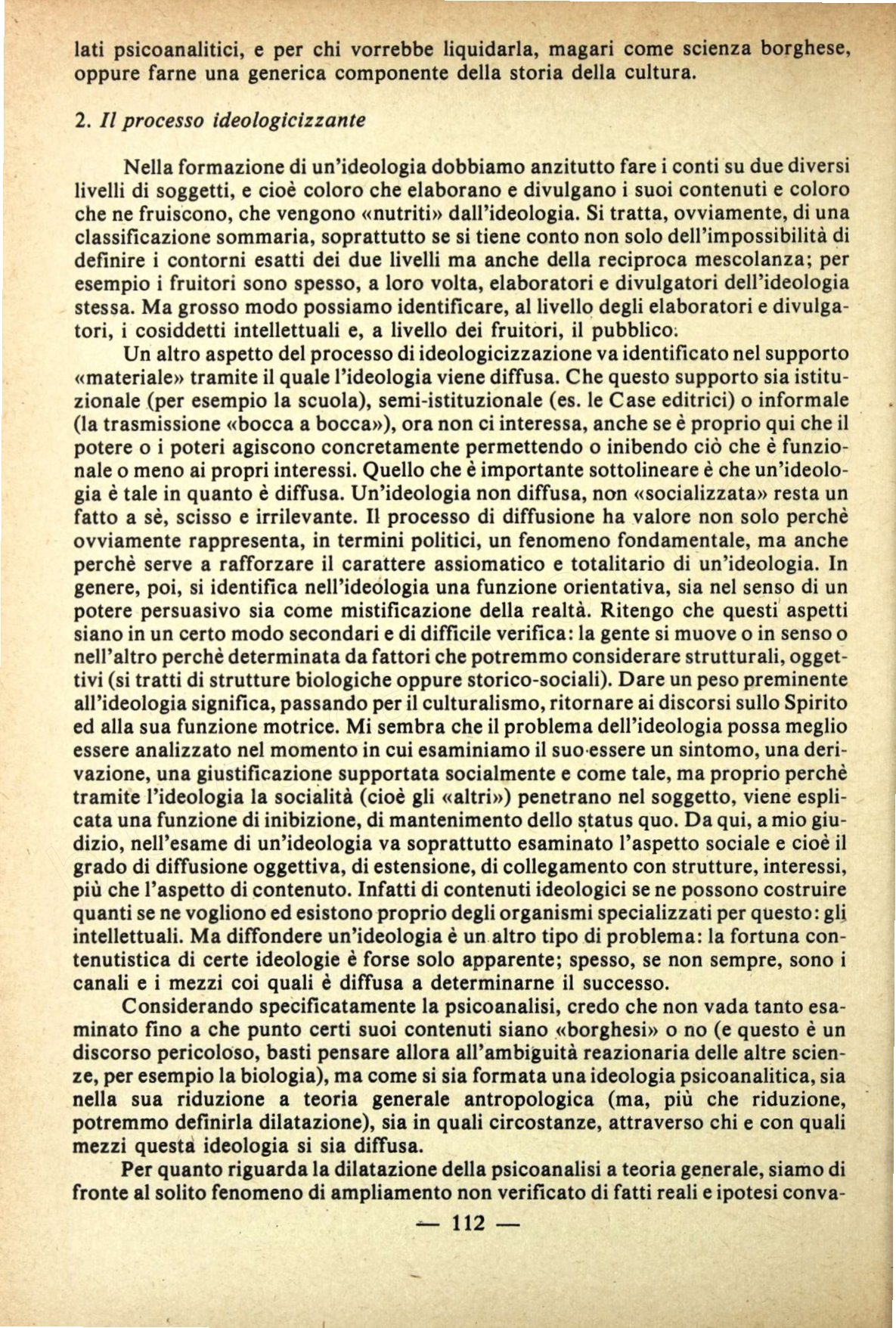
lati psicoanalitici, e per chi vorrebbe liquidarla, magari come scienza borghese,
oppure farne una generica componente della storia della cultura.
2. 11 processo ideologicizzante
Nella formazione di un'ideologia dobbiamo anzitutto fare i conti su due diversi
livelli di soggetti, e cioè coloro che elaborano e divulgano i suoi contenuti e coloro
che ne fruiscono, che vengono «nutriti» dall'ideologia. Si tratta, ovviamente, di una
classificazione sommaria, soprattutto se si tiene conto non solo dell'impossibilità di
definire i contorni esatti dei due livelli ma anche della reciproca mescolanza; per
esempio i fruitori sono spesso, a loro volta, elaboratori e divulgatori dell'ideologia
stessa. Ma grosso modo possiamo identificare, al livello degli elaboratori e divulga-
tori, i cosiddetti intellettuali e, a livello dei fruitori, i l pubblico.
Un altro aspetto del processo di ideologicizz azione va identificato nel supporto
«materiale» tramite il quale l'ideologia viene diffusa. Che questo supporto sia istitu-
zionale (per esempio la scuola), semi-istituzionale (es. le Case editrici) o informale
(la trasmissione «bocca a bocca»), ora non ci interessa, anche seè proprio qui che il
potere o i poteri agiscono concretamente permettendo o inibendo ciò che è funzio-
nale o meno ai propri interessi. Quello che è importante sottolineare è che un'ideolo-
gia è tale in quanto è diffusa. Un'ideologia non diffusa, non «socializzata» resta un
fatto a se, scisso e irrilevante. I l processo di diffusione ha valore non solo perchè
ovviamente rappresenta, in termini politici, un fenomeno fondamentale, ma anche
perchè serve a rafforzare i l carattere assiomatico e totalitario di un'ideologia. In
genere, poi, si identifica nell'ideologia una funzione orientativa, sia nel senso di un
potere persuasivo sia come mistificazione della realtà. Ritengo che questi aspetti
siano in un certo modo secondari e di difficile verifica: la gente si muove o in senso o
nell'altro perchè determinata da fattori che potremmo considerare strutturali, ogget-
tivi (si tratti di strutture biologiche oppure storico-sociali). Dare un peso preminente
all'ideologia significa, passando per il culturalismo, ritornare ai discorsi sullo Spirito
ed alla sua funzione motrice. Mi sembra che il problema dell'ideologia possa meglio
essere analizzato nel momento in cui esaminiamo il suo essere un sintomo, una deri-
vazione, una giustificazione supportata socialmente e come tale, ma proprio perchè
tramite l'ideologia la socialità (cioè gli ((altri») penetrano nel soggetto, viene espli-
cata una funzione di inibizione, di mantenimento dello status quo. Da qui, a mio giu-
dizio, nell'esame di un'ideologia va soprattutto esaminato l'aspetto sociale e cioè il
grado di diffusione oggettiva, di estensione, di collegamento con strutture, interessi,
più che l'aspetto di contenuto. Infatti di contenuti ideologici se ne possono costruire
quanti sene vogliono ed esistono proprio degli organismi specializzati per questo: gli
intellettuali. Ma diffondere un'ideologia è un altro tipo di problema: la fortuna con-
tenutistica di certe ideologie è forse solo apparente; spesso, se non sempre, sono i
canali e i mezzi coi quali è diffusa a determinarne i l successo.
Considerando specificatamente la psicoanalisi, credo che non vada tanto esa-
minato fino a che punto certi suoi contenuti siano «borghesi» o no (e questo è un
discorso pericoloso, basti pensare allora all'ambiguità reazionaria delle altre scien-
ze, per esempio la biologia), ma come si sia formata una ideologia psicoanalitica, sia
nella
sua riduzione a teoria generale antropologica (ma, p i ù che riduzione,
potremmo definirla dilatazione), sia in quali circostanze, attraverso chi e con quali
mezzi questa ideologia si sia diffusa.
Per quanto riguarda la dilatazione della psicoanalisi a teoria generale, siamo di
fronte al solito fenomeno di ampliamento non verificato di fatti reali e ipotesi conva-
112
















