
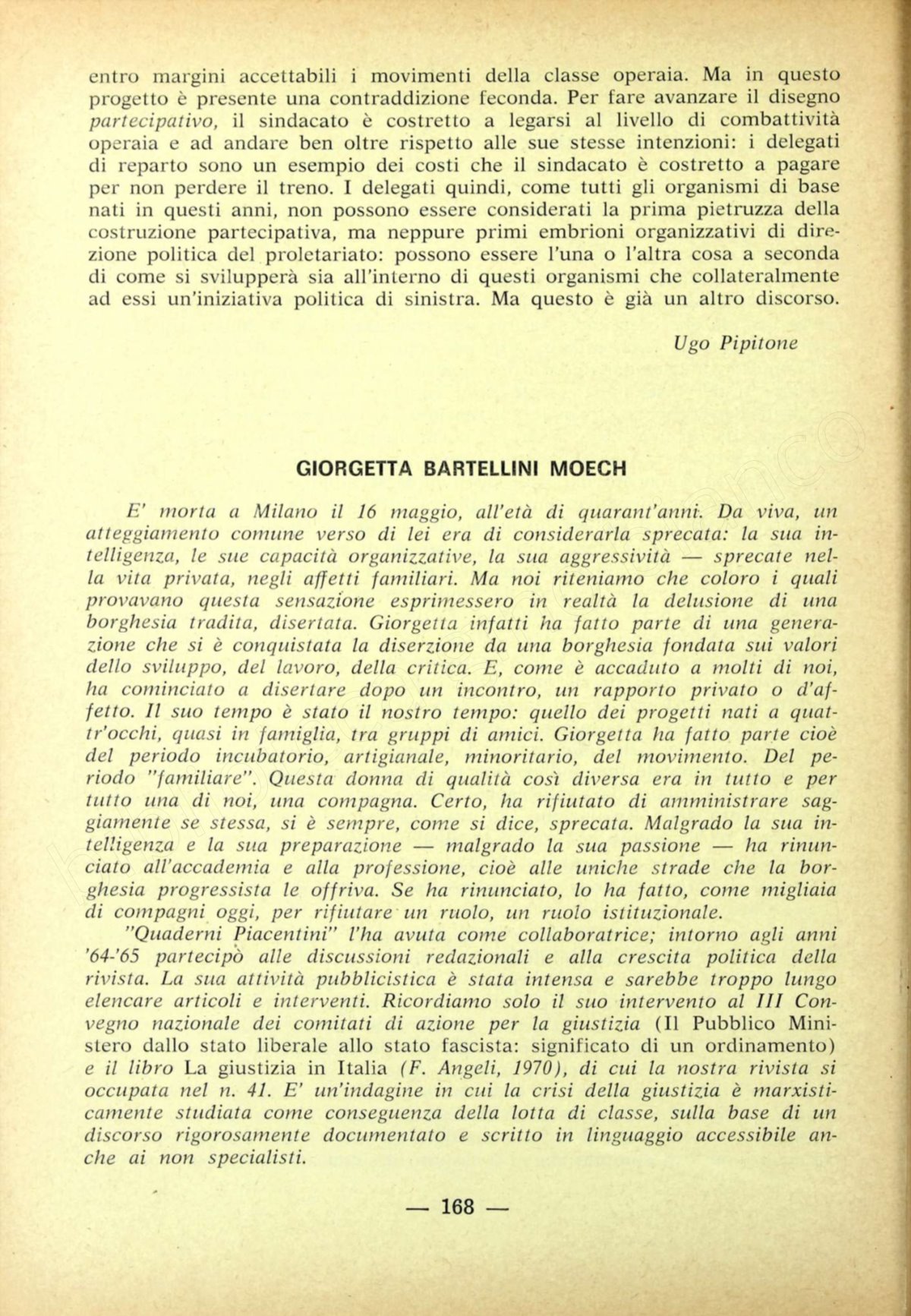
entro margini accettabi l i i moviment i del la classe operaia. Ma i n questo
progetto è presente una contraddizione feconda. Per fare avanzare i l disegno
partecipativo,
i l sindacato è costretto a legarsi a l l ivel lo d i combat t ivi tà
operaia e ad andare ben ol t re rispetto al le sue stesse intenzioni: i delegati
di reparto sono un esempio dei costi che i l sindacato è costretto a pagare
per non perdere i l treno. I delegati quindi, come tut t i gl i organismi d i base
nati i n questi anni, non possono essere considerati l a pr ima pietruzza del la
costruzione partecipativa, ma neppure pr imi embrioni organizzativi d i dire-
zione pol itica del proletariato: possono essere l 'una o l 'al tra cosa a seconda
di come si svilupperà sia all ' interno d i questi organismi che collateralmente
ad essi un'iniziativa pol i t ica d i sinistra. Ma questo è già un al t ro discorso.
Ugo Pipitone
GIORGETTA BARTELLINI MOECH
E' mor ta a Mi lano i l 16 maggio, al l 'età d i quarant'anni.. Da viva, u n
atteggiamento comune verso d i lei era d i considerarla sprecata: l a sua in-
telligenza, le sue capacità organizzative, l a sua aggressività — sprecate nel-
la vi ta privata, negl i affet t i fami l iari . Ma no i ri teniamo che coloro i qual i
provavano questa sensazione esprimessero i n real tà l a delusione d i una
borghesia tradi ta, disertata. Giorgetta infat t i ha fat to parte d i una genera-
zione che si è conquistata la diserzione da una borghesia fondata sui valori
dello sviluppo, del lavoro, del la critica. E, come è accaduto a mol t i d i noi ,
ha cominciato a disertare dopo un incontro, u n rappor to pr ivato o d'af -
fetto. I l suo tempo è stato i l nostro tempo: quel lo dei progetti nat i a quat-
tr'occhi, quasi in famiglia, t ra gruppi d i amici. Giorgetta ha fat to parte cioè
del per iodo incubatorio, artigianale, minor i tar io, de l movimento. De l pe-
riodo "fami l iare". Questa donna d i qual i tà così diversa era i n t u t t o e per
tutto una d i noi , una compagna. Certo, ha r i f iutato d i amministrare sag-
giamente se stessa, si è sempre, come s i dice, sprecata. Malgrado l a sua in-
telligenza e l a sua preparazione — malgrado l a sua passione — ha r inun-
ciato all'accademia e al la professione, cioè al le uniche strade che l a bor -
ghesia progressista le offr iva. Se ha rinunciato, l o ha fatto, come migl iaia
di compagni oggi, per ri f iutare- un ruolo, un ruolo istituzionale.
"Quaderni Piacentini" l 'ha avuta come collaboratrice; intorno agl i anni
64-65 partecipò a l l e discussioni redazionali e a l l a cresci ta pol i t ica del la
rivista. La sua at t ivi tà pubblicistica è stata intensa e sarebbe troppo lungo
elencare art icol i e interventi. Ricordiamo solo i l suo intervento a l I I I Con-
vegno nazionale dei comi tat i d i azione pe r l a giustizia ( I l Pubbl ico Mini -
stero dal lo stato liberale al lo stato fascista: significato d i un ordinamento)
e i l l ibro La giustizia i n I tal ia (F. Angeli, 1970), d i cu i l a nostra r ivista s i
occupata nel n. 41. E ' un'indagine i n cu i l a cr isi del la giustizia è marxisti-
camente studiata come conseguenza del la lot ta d i classe, sul la base d i un
discorso rigorosamente documentato e scr i t to i n linguaggio accessibile an-
che a i non specialisti.
•
168
















