
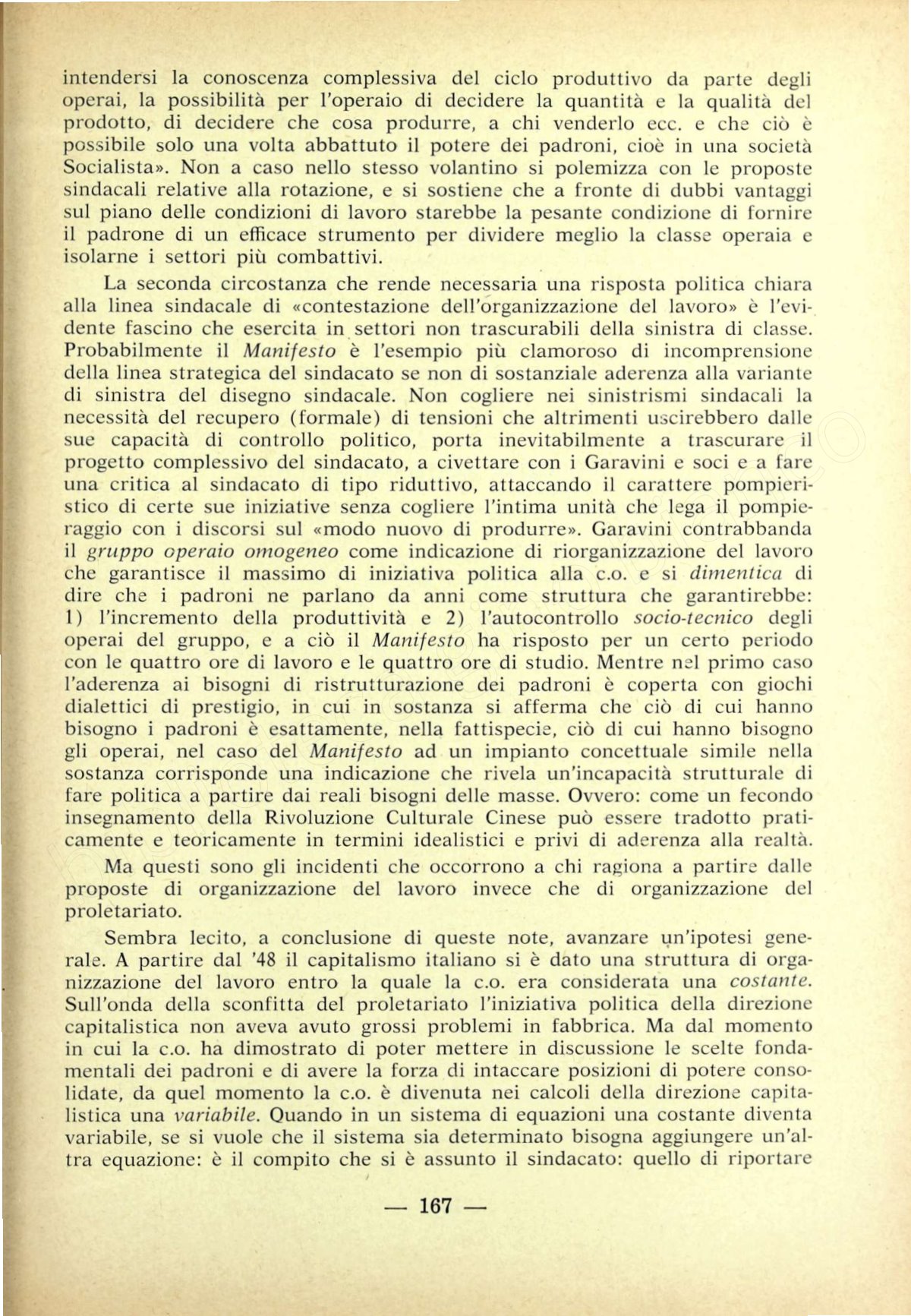
•
intendersi l a conoscenza complessiva del ciclo produttivo da parte degli
operai, la possibilità per l'operaio di decidere la quantità e la qualità del
prodotto, d i decidere che cosa produrre, a chi venderlo ecc. e che ciò è
possibile solo una volta abbattuto i l potere dei padroni, cioè in una società
Socialista». Non a caso nello stesso volantino si polemizza con le proposte
sindacali relative alla rotazione, e si sostiene che a fronte di dubbi vantaggi
sul piano delle condizioni di lavoro starebbe la pesante condizione di fornire
il padrone di un efficace strumento per dividere meglio la classe operaia e
isolarne i settori più combattivi.
La seconda circostanza che rende necessaria una risposta politica chiara
alla linea sindacale di «contestazione dell'organizzazione del lavoro» è l'evi-
•
dente fascino che esercita in, settori non trascurabili della sinistra di classe.
Probabilmente i l
Manifesto
è l'esempio più clamoroso d i incomprensione
della linea strategica del sindacato se non di sostanziale aderenza alla variante
di sinistra del disegno sindacale. Non cogliere nei sinistrismi sindacali l a
necessità del recupero (formale) di tensioni che altrimenti uscirebbero dalle
sue capacità d i controllo politico, porta inevitabilmente a trascurare i l
progetto complessivo del sindacato, a civettare con i Garavini e soci e a fare
una critica al sindacato di tipo riduttivo, attaccando i l carattere pompieri-
stico di certe sue iniziative senza cogliere l'intima unità che lega i l pompie-
raggio con i discorsi sul «modo nuovo di produrre». Garavini contrabbanda
il
gruppo operaio omogeneo
come indicazione di riorganizzazione del lavoro
che garantisce i l massimo di iniziativa politica alla c.o. e si
dimentica
di
dire che i padroni ne parlano da anni come struttura che garantirebbe:
1) l'incremento della produttività e 2 ) l'autocontrollo
socio-tecnico
degli
operai del gruppo, e a ciò i l
Manifesto
ha risposto per un certo periodo
con le quattro ore di lavoro e le quattro ore di studio. Mentre nel primo caso
l'aderenza a i bisogni d i ristrutturazione dei padroni è coperta con giochi
dialettici d i prestigio, in cui in sostanza si afferma che ciò di cui hanno
bisogno i padroni è esattamente, nella fattispecie, ciò di cui hanno bisogno
gli operai, nel caso del
Manifesto
ad un impianto concettuale simile nella
sostanza corrisponde una indicazione che rivela un'incapacità strutturale di
fare politica a partire dai reali bisogni delle masse. Ovvero: come un fecondo
insegnamento della Rivoluzione Culturale Cinese può essere tradotto prati-
camente e teoricamente in termini idealistici e privi di aderenza alla realtà.
Ma questi sono gli incidenti che occorrono a chi ragiona a partire dalle
proposte d i organizzazione de l lavoro invece che d i organizzazione del
proletariato.
Sembra lecito, a conclusione di queste note, avanzare un'ipotesi gene-
rale. A partire dal '48 i l capitalismo italiano si è dato una struttura di orga-
nizzazione del lavoro entro la quale l a c.o. era considerata una
costante.
Sull'onda della sconfitta del proletariato l'iniziativa politica della direzione
capitalistica non aveva avuto grossi problemi in fabbrica. Ma dal momento
in cui la c.o. ha dimostrato di poter mettere in discussione le scelte fonda-
mentali dei padroni e di avere la forza di intaccare posizioni di potere conso-
lidate, da quel momento la c.o. è divenuta nei calcoli della direzione capita-
listica una
variabile.
Quando in un sistema di equazioni una costante diventa
variabile, se si vuole che il sistema sia determinato bisogna aggiungere un'al-
tra equazione: è i l compito che si è assunto i l sindacato: quello di riportare
167
















