
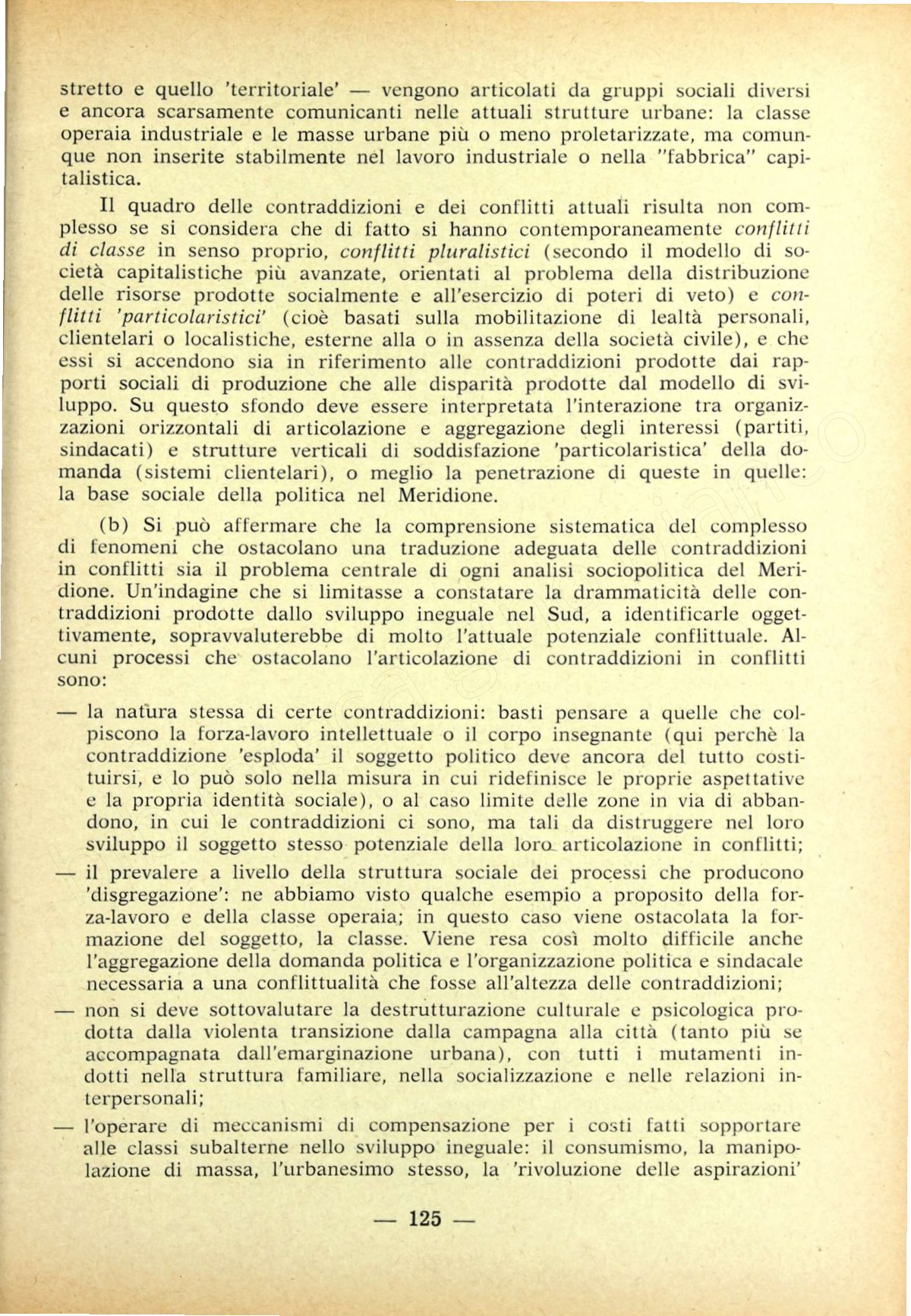
stretto e quello 'territoriale' v e n g o n o articolati da gruppi sociali diversi
e ancora scarsamente comunicanti nelle attuali strutture urbane: l a classe
operaia industriale e le masse urbane più o meno proletarizzate, ma comun-
que non inserite stabilmente nel lavoro industriale o nella "fabbrica" capi-
talistica.
I l quadro delle contraddizioni e dei conflitti attuati risulta non com-
plesso se si considera che di fatto si hanno contemporaneamente
conflitti
di classe
in senso proprio,
conflitti pluralistici
(secondo i l modello di so-
cietà capitalistiche più avanzate, orientati a l problema della distribuzione
delle risorse prodotte socialmente e all'esercizio d i poteri d i veto) e
con-
flitti 'particolaristici'
(cioè basati sulla mobilitazione d i lealtà personali,
clientelari o localistiche, esterne alla o in assenza della società civile), e che
essi si accendono sia i n riferimento alle contraddizioni prodotte dai rap-
porti sociali di produzione che alle disparità prodotte dal modello di svi-
luppo. Su questo sfondo deve essere interpretata l'interazione t ra organiz-
zazioni orizzontali d i articolazione e aggregazione degli interessi (partiti,
sindacati) e strutture verticali d i soddisfazione 'particolaristica della do-
manda (sistemi clientelari), o meglio la penetrazione di queste in quelle:
la base sociale della politica nel Meridione.
(b) S i può affermare che l a comprensione sistematica del complesso
di fenomeni che ostacolano una traduzione adeguata delle contraddizioni
in conflitti sia i l problema centrale di ogni analisi sociopolitica del Meri-
dione. Un'indagine che si limitasse a constatare la drammaticità delle con-
traddizioni prodotte dallo sviluppo ineguale nel Sud, a identificarle ogget-
tivamente, sopravvaluterebbe d i molto l'attuale potenziale conflittuale. Al -
cuni processi che ostacolano l'articolazione d i contraddizioni i n conflitti
sono:
— la natura stessa di certe contraddizioni: basti pensare a quelle che col-
piscono la forza-lavoro intellettuale o i l corpo insegnante (qui perchè la
contraddizione 'esploda' i l soggetto politico deve ancora del tutto costi-
tuirsi, e lo può solo nella misura in cui ridefinisce le proprie aspettative
•e la propria identità sociale), o al caso limite delle zone in via di abban-
dono, in cui le contraddizioni ci sono, ma tal i da distruggere nel loro
sviluppo i l soggetto stesso potenziale della loro_ articolazione in conflitti;
il prevalere a livello della struttura sociale dei processi che producono
'disgregazione': ne abbiamo visto qualche esempio a proposito della for-
za-lavoro e della classe operaia; i n questo caso viene ostacolata la for-
mazione del soggetto, l a classe. Viene resa così molto difficile anche
l'aggregazione della domanda politica e l'organizzazione politica e sindacale
necessaria a una conflittualità che fosse all'altezza delle contraddizioni;
non si deve sottovalutare la destnitturazione culturale e psicologica pro-
dotta dalla violenta transizione dalla campagna alla città (tanto più se
accompagnata dall'emarginazione urbana), con tut t i i mutamenti i n -
dotti nella struttura familiare, nella socializzazione e nelle relazioni in-
terpersonali;
l'opérare d i meccanismi d i compensazione per i costi fatt i sopportare
alle classi subalterne nello sviluppo ineguale: i l consumismo, la manipo-
lazione d i massa, l'urbanesimo stesso, l a 'rivoluzione delle aspirazioni'
125
















