
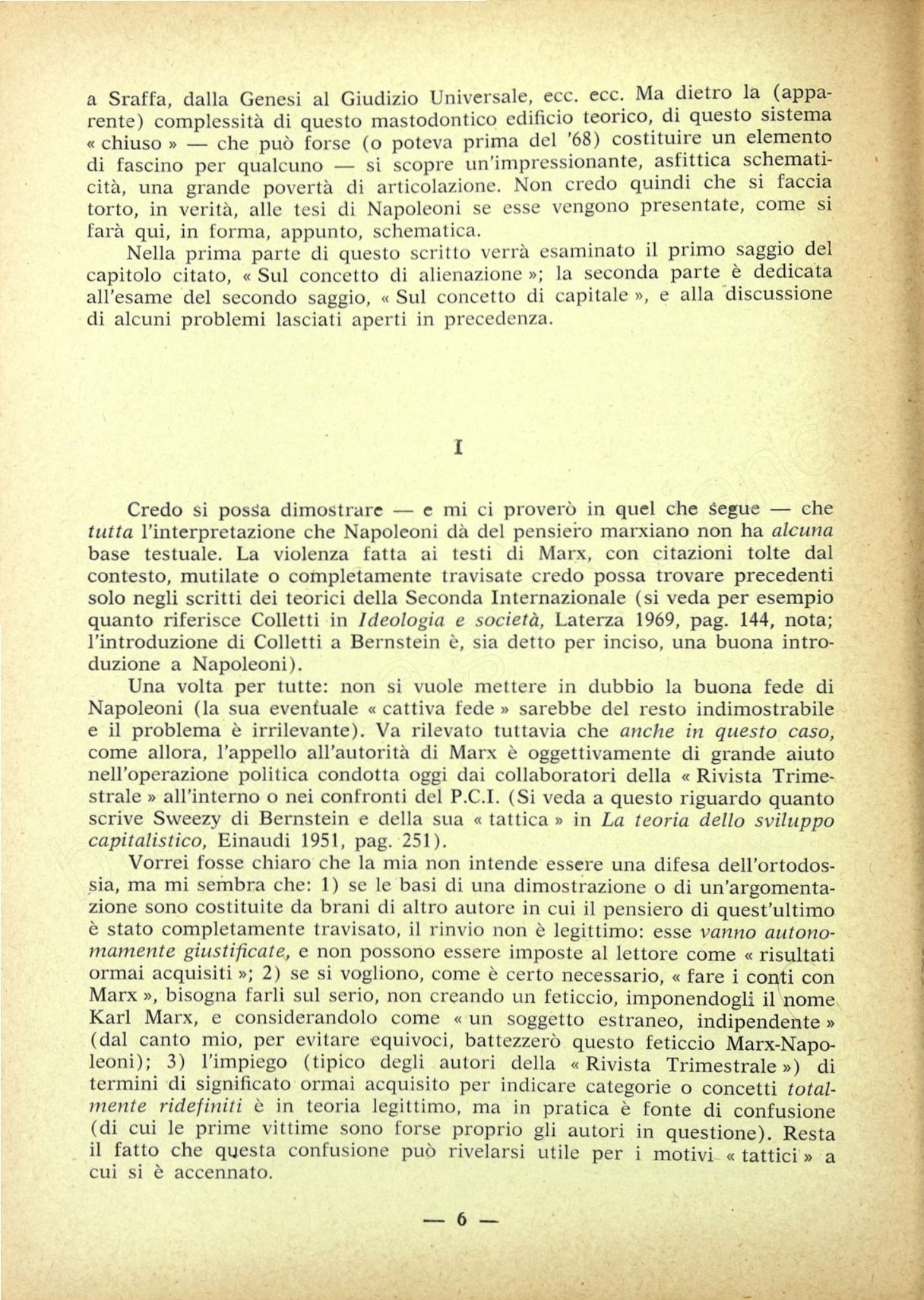
a Sraffa, dal la Genesi a l Giudizio Universale, ecc. ecc. Ma diet ro l a (appa-
rente) complessità di questo mastodontico edificio teorico, d i questo sistema
«chiuso » — che può forse ( o poteva pr ima del '68) cost i tuire un elemento
di fascino per qualcuno — s i scopre un'impressionante, asf i tt ica schemati-
cità, una grande povertà d i articolazione. Non credo qu i nd i che s i faccia
torto, i n verità, al le tesi d i Napoleoni se esse vengono presentate, come s i
farà qui , i n forma, appunto, schematica.
Nella pr ima parte d i questo scri tto verrà esaminato i l pr imo saggio del
capitolo citato, « Sul concetto d i alienazione », l a seconda parte è dedicata
all'esame del secondo saggio, « Sul concetto d i capitale », e al la -discussione
di alcuni problemi lasciati apert i in precedenza.
Credo si possa dimostrare — e mi c i proverò i n quel che Segue c h e
tutta
l'interpretazione che Napoleoni dà del pensiei-o marxiano non ha
alcuna
base testuale. L a violenza fat ta a i tes t i d i Marx, con ci tazioni t o l t e da l
contesto, mut i late o completamente travisate credo possa trovare precedenti
solo negli scri tt i dei teorici della Seconda Internazionale (si veda per esempio
quanto riferisce Col letti i n
Ideologia
e
società,
Laterza 1969, pag. 144, nota;
l'introduzione di Colletti a Bernstein è, sia detto per inciso, una buona intro-
duzione a Napoleoni).
Una vol ta per tut te: non s i vuole mettere i n dubbio l a buona fede d i
Napoleoni ( l a sua eventuale « cattiva fede » sarebbe del resto indimostrabi le
e i l problema è irri levante). Va ri levato tut tavia che
anche i n questo caso,
come allora, l 'appello al l 'autorità d i Marx è oggettivamente d i grande aiuto
nell'operazione pol itica condotta oggi dai collaboratori della « Rivista Trime-
strale » all ' interno o nei confronti del P.C.I. (Si veda a questo riguardo quanto
scrive Sweezy d i Bernstein e della sua « tattica » i n
La teoria del lo sviluppo
capitalistico,
Einaudi 1951, pag. 251).
Vorrei fosse chiaro che la mia non intende essere una difesa dell'ortodos-
sia, ma mi seinbra che: 1) se le basi di una dimostrazione o di un'argomenta-
zione sono costituite da brani di altro autore in cui i l pensiero di quest'ultimo
è stato completamente travisato, i l rinvio non è legittimo: esse
vanno autono-
mamente giustificate,
e non possono essere imposte al lettore come «r isul tat i
ormai acquisiti »; 2) se si vogliono, come è certo necessario, « fare i conti con
Marx », bisogna far l i sul serio, non creando un feticcio, imponendogli i l nome
Karl Marx, e considerandolo come « un soggetto estraneo, indipendente »
(dal canto mio, per evitare equivoci, battezzerò questo fet iccio Marx-Napo-
leoni); 3 ) l ' impiego ( t i p i co degl i autor i del la «Ri v i sta Tr imest rale ») d i
termini d i significato• ormai acquisito per indicare categorie o concetti
total-
mente r idef ini t i
è i n teor ia legittimo, ma i n prat ica è fonte d i confusione
(di cu i le pr ime vi t t ime sono forse propr io g l i autor i i n questione). Resta
i l fat to che questa confusione può rivelarsi ut i le per i mot i v i « tattici » a
cui si è accennato.
6
















