
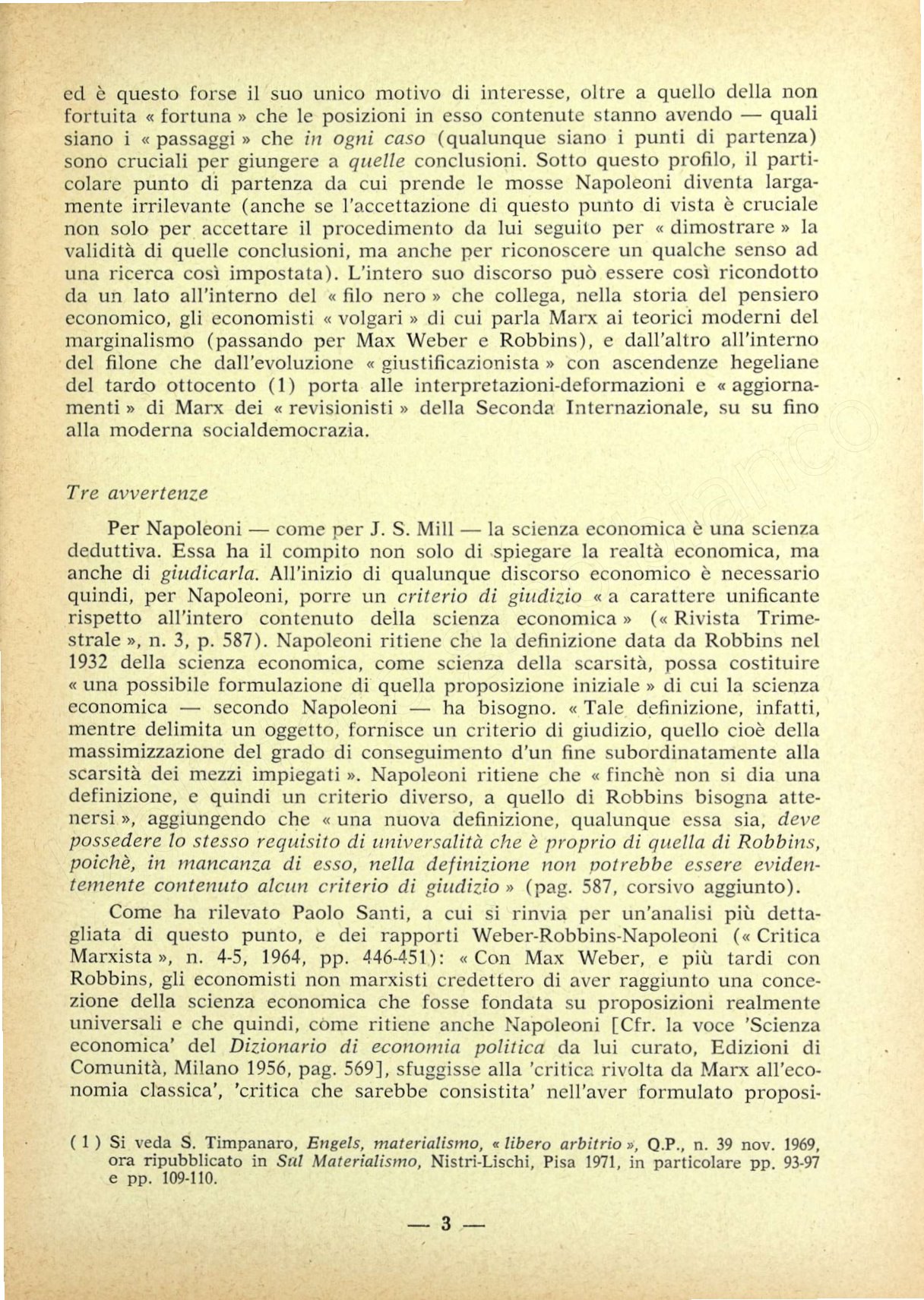
ed è questo forse i l suo unico motivo di interesse, oltre a quello della non
fortuita « fortuna » che le posizioni in esso contenute stanno avendo — quali
siano i « passaggi » che
in ogni caso
(qualunque siano i punti di partenza)
sono cruciali per giungere a
quelle
conclusioni. Sotto questo profilo, i l parti-
colare punto d i partenza da cui prende le mosse Napoleoni diventa larga-
mente irrilevante (anche se l'accettazione di questo punto di vista è cruciale
non solo per. accettare i l procedimento da lui seguito per « dimostrare » la
validità di quelle conclusioni, ma anche per riconoscere un qualche senso ad
una ricerca così impostata). L'intero suo discorso può essere così ricondotto
da un lato all'interno del « filo nero » che collega, nella storia del pensiero
economico, gli economisti « volgari » di cui parla Marx ai teorici moderni del
marginalismo (passando per Max Weber e Robbins), e dall'altro all'interno
del filone che dall'evoluzione « giustificazionista » con ascendenze hegeliane
del tardo ottocento (1) porta alle interpretazioni-deformazioni e « aggiorna-
menti » di Ma n dei « revisionisti)) della Seconda Internazionale, su su fino
alla moderna socialdemocrazia.
Tre avvertenze
Per Napoleoni c o m e per
J.
S. Mill l a scienza economica è una scienza
deduttiva. Essa ha i l compito non solo di spiegare la realtà economica, ma
anche di
giudicarla.
All'inizio di qualunque discorso economico è necessario
quindi, per Napoleoni, porre un
criterio di giudizio
« a carattere unificante
rispetto all'intero contenuto del la scienza economica » ( « Rivista Tr ime-
strale », n. 3, p. 587). Napoleoni ritiene che la definizione data da Robbins nel
1932 della scienza economica, come scienza della scarsità, possa costituire
«una possibile formulazione di quella proposizione iniziale » di cui la scienza
economica — secondo Napoleoni — ha bisogno. « Tale definizione, infatti,
mentre delimita un oggetto, fornisce un criterio di giudizio, quello cioè della
massimizzazione del grado di conseguimento d'un fine subordinatamente alla
scarsità dei mezzi impiegati ». Napoleoni ritiene che «finche non si dia una
definizione, e quindi un criterio diverso, a quello di Robbins bisogna atte-
nersi.», aggiungendo che « una nuova definizione, qualunque essa sia,
deve
possedere lo stesso requisito di universalità che è proprio di quella di Robbins,
poichè, i n mancanza d i esso, nella definizione non potrebbe essere eviden-
temente contenuto alcun criterio di giudizio » (pag. 587, corsivo aggiunto).
Come ha rilevato Paolo Santi, a cui si rinvia per un'analisi più detta-
gliata d i questo punto, e dei rapporti Weber-Robbins-Napoleoni ( « Critica
Marxista », n . 4-5, 1964, pp. 446-451): « Con Max Weber, e più tardi con
Robbins, gli economisti non marxisti credettero di aver raggiunto una conce-
zione della scienza economica che fosse fondata su proposizioni realmente
universali e che quindi, cóme ritiene anche Napoleoni [Cfr. la voce 'Scienza
economica del
Dizionario d i economia politica
da lui curato, Edizioni d i
Comunità, Milano 1956, pag. 569], sfuggisse alla 'critica rivolta da Marx all'eco-
nomia classica', 'critica che sarebbe consistita' nell'aver formulato proposi-
( 1 ) Si veda S. Timpanaro,
Engels, materialismo, «libero arbitrio
Q . P. , n. 39 nov. 1969,
ora ripubblicato in
Sal Materialismo,
Nistri-Lischi, Pisa 1971, in particolare pp. 93-97
e pp. 109-110.
















