
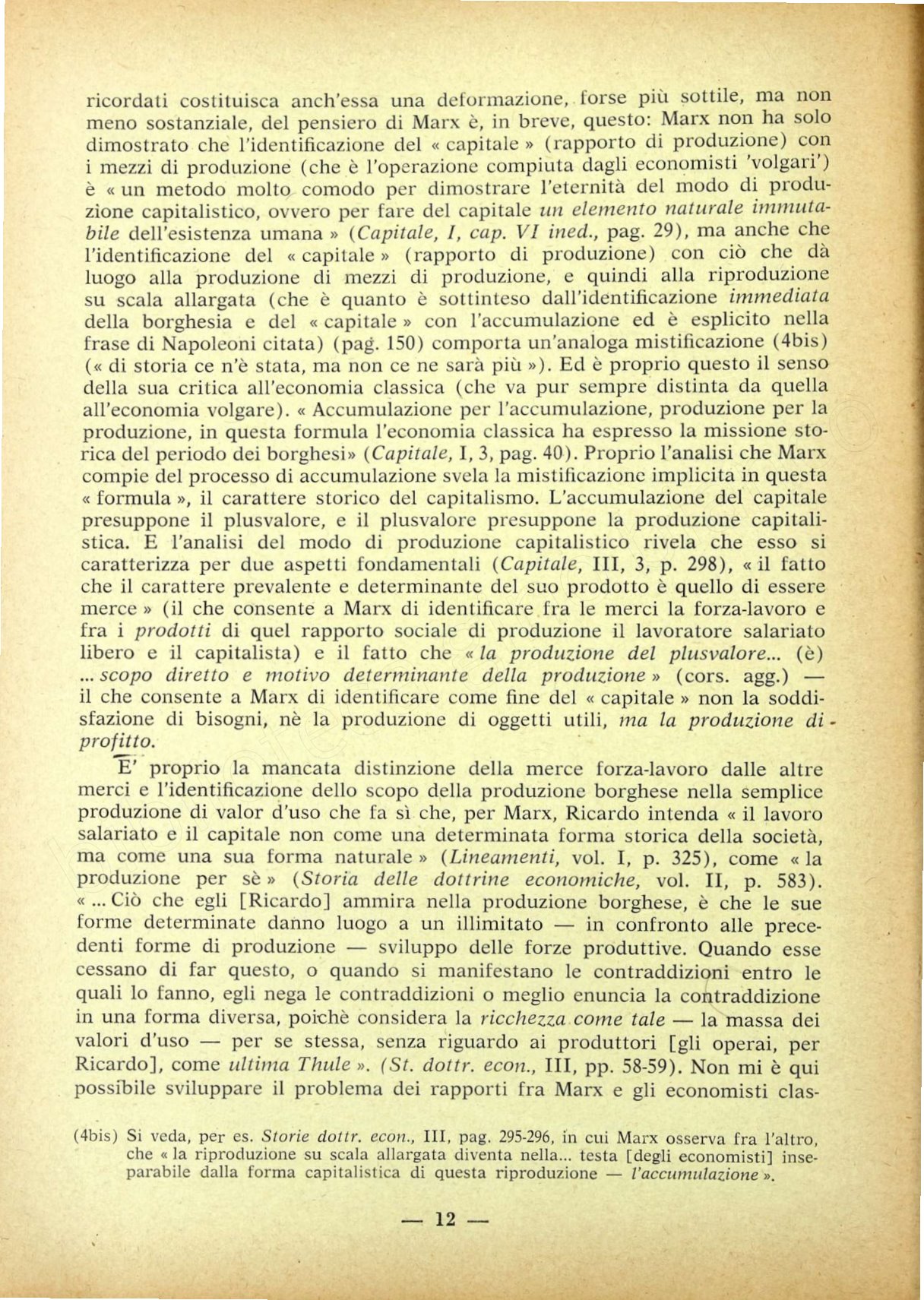
ricordati costituisca anch'essa una deformazione, forse p i ù sotti le, ma non
meno sostanziale, del pensiero di Marx è, in breve, questo: Marx non ha solo
dimostrato che l'identificazione del «capitale » (rapporto d i produzione) con
i mezzi di produzione (che è l'operazione compiuta dagli economisti 'volgari ')
è « un metodo mol to comodo per dimostrare l 'eterni tà del modo d i produ-
zione capitalistico, ovvero per fare del capitale
un elemento naturale immuta-
bile
dell'esistenza umana))
(Capitale, I , cap. V I ined.,
pag. 29), ma anche che
l'identificazione de l « capitale » ( rappor to d i produzione) c o n c i ò che d à
luogo al la produzione d i mezzi d i produzione, e qu i nd i a l l a riproduzione
su scala allargata (che è quanto è sottinteso dall'identificazione
immediata
della borghesia e de l « capitale » con l'accumulazione ed è espl ici to nel la
frase di Napoleoni citata) (pag. 150) comporta un'analoga mistificazione (4bis)
(« di storia ce n'è stata, ma non ce ne sarà più »). Ed è proprio questo i l senso
della sua cri t ica all'economia classica (che va pur sempre dist inta da quella
all'economia volgare). « Accumulazione per l'accumulazione, produzione per la
produzione, in questa formula l'economia classica ha espresso la missione sto-
rica del periodo dei borghesi»
(Capitale,
I,
3, pag. 40). Proprio l'analisi che Marx
compie del processo di accumulazione svela la mistificazione impl icita in questa
«formula », i l carattere storico del capitalismo. L'accumulazione del capitale
presuppone i l plusvalore, e i l plusvalore presuppone l a produzione capitali-
stica. E l 'anal isi de l modo d i produzione capi tal ist ico r i vela che esso s i
caratterizza per due aspetti fondamentali
(Capitale,
I I I ,
3, p. 298), « i l fat to
che i l carattere prevalente e determinante del suo prodotto è quello di essere
merce » ( i l che consente a Ma n di identificare f ra le merci la forza-lavoro e
fra i
prodot t i
d i quel rapporto sociale d i produzione i l lavoratore salariato
libero e i l capital ista) e i l fat to che «
la produzione de l plusvalore... ( è )
... scopo di ret to e mot ivo determinante del la produzione » (cors. agg.)
i l che consente a Marx di identificare come fine del « capitale » non la soddi-
sfazione d i bisogni, nè l a produzione d i oggetti ut i l i ,
ma l a produzione d i
-
profitto.
•
•
E' propr io l a mancata distinzione del la merce forza-lavoro dal le al t re
merci e l'identificazione dello scopo della produzione borghese nella semplice
produzione di valor d'uso che fa sì che, per Marx, Ricardo intenda « i l lavoro
salariato e i l capitale non come una determinata forma storica della società,
ma come una sua forma naturale »
(Lineamenti, vol .
I ,
p. 325), come « la
produzione p e r sè » (St or i a del le dot t r i ne economiche, vo l . I I , p . 583).
«... Ciò che egl i [Ricardo] ammi ra nel la produzione borghese, è che l e sue
forme determinate danno luogo a un i l l imi tato — i n confronto al le prece-
denti forme d i produzione — sviluppo del le forze produttive. Quando esse
cessano d i f a r questo, o quando s i manifestano l e contraddizioni •entro l e
quali lo fanno, egli nega le contraddizioni o meglio enuncia la cofitraddizione
in una forma diversa, poichè considera la
ricchezza come tale
— la massa dei
valori d'uso — per se stessa, senza riguardo a i produt tor i [ g l i operai, per
Ricardo], come
ul t ima Thule ». (St. dot tr. econ.,
I I I ,
pp. 58-59). Non mi è qui
possibile sviluppare i l problema dei rapport i f ra Marx e gl i economisti clas-
•
(4bis) Si veda, per es.
Storie dottr. econ., I I I ,
pag. 295-296, in cui Marx osserva f ra l 'altro,
che « la riproduzione su scala allargata diventa nella... testa [degli economisti] inse-
parabile dalla forma capitalistica d i questa riproduzione
l ' accumu l az i one ».
12
















