
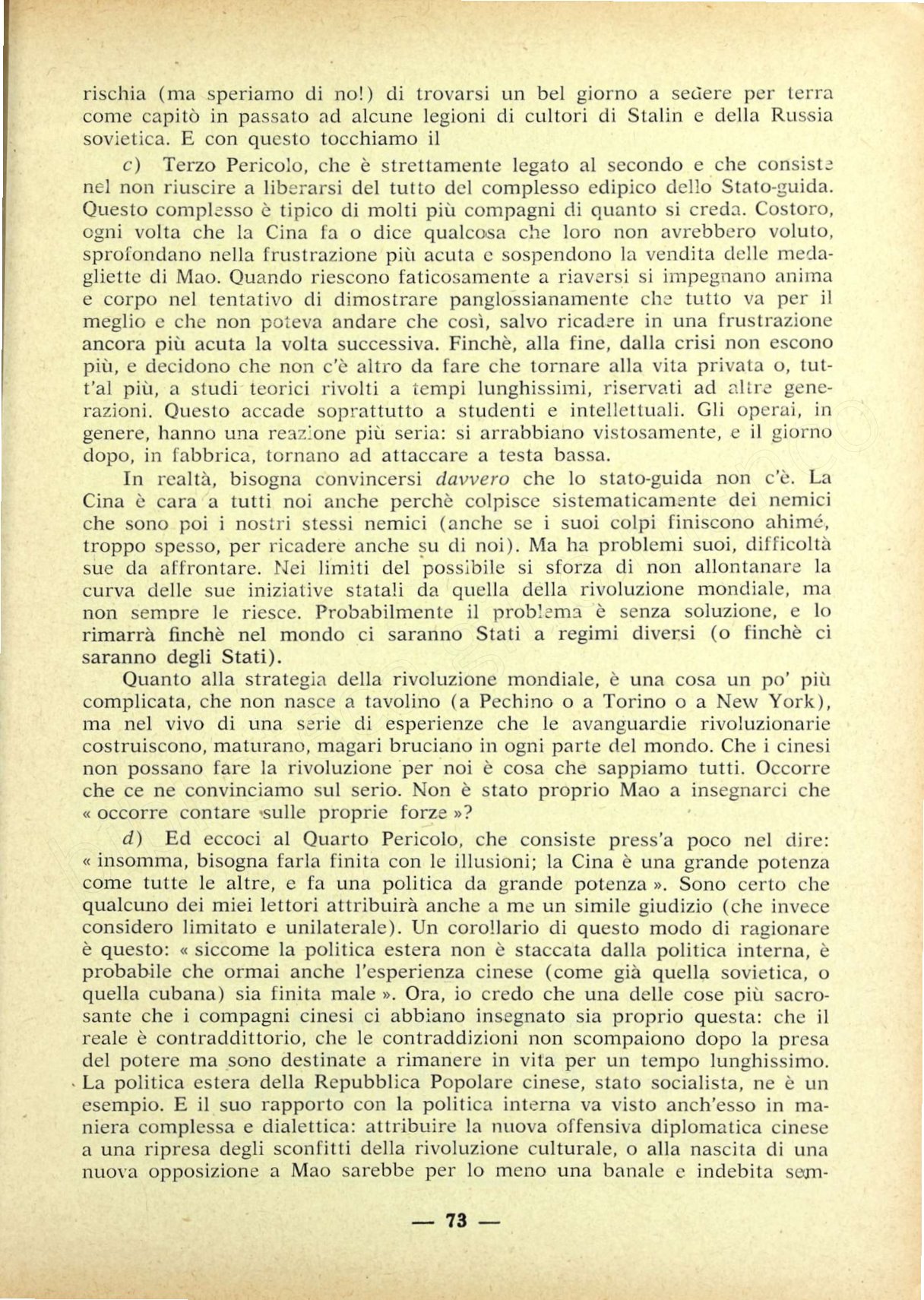
rischia (ma speriamo d i no! ) d i trovarsi un bel giorno a sedere per ter ra
come capitò i n passato ad alcune legioni d i cul tor i d i Stal in e del la Russia
sovietica. E con questo tocchiamo i l
c)
Te r z o Pericolo, che è strettamente legato a l secondo e che consiste
nel non riuscire a liberarsi del tut to del complesso edipico del lo Stato-guida.
Questo complesso è tipico di mol t i più compagni di quanto si creda. Costoro,
ogni vol ta che l a Cina f a o dice qualcosa che l oro non avrebbero voluto,
sprofondano nella frustrazione più acuta e sospendono la vendita delle meda-
gliette di Mao. Quando riescono faticosamente a riaversi si impegnano anima
e corpo nel tentat ivo d i dimostrare panglossianamente che t u t t o va per i l
meglio e che non poteva andare che così, salvo ricadere i n una frustrazione
ancora più acuta la vol ta successiva. Finchè, al la fine, dal la crisi non escono
più, e decidono che non c'è al tro da fare che tornare al la vi ta privata o, tut -
t'al più, a studi teor ici r i vo l t i a tempi lunghissimi, riservat i ad al t re gene-
razioni. Questo accade soprat tut to a student i e intel lettual i . Gl i operai, i n
genere, hanno una reazione più seria: si arrabbiano vistosamente, e i l giorno
dopo, i n fabbrica, tornano ad attaccare a testa bassa.
In real tà, bisogna convincersi
davvero
che l o stato-guida non c'è. L a
Cina è cara a t u t t i no i anche perchè colpisce sistematicamente dei nemici
che sono poi i nost r i stessi nemici (anche se i suoi colpi finiscono ahimé,
troppo spesso, per ricadere anche su di noi ). Ma ha problemi suoi, di ff icol tà
sue da affrontare. Ne i l imi t i de l 'possibile s i sforza d i non al lontanare l a
curva del le sue iniziat ive statal i da quel la del la rivoluzione mondiale, ma
non sempre l e riesce. Probabi lmente i l problema è senza soluzione, e l o
rimarrà f inchè ne l mondo •ci saranno Stat i a regimi diversi ( o f inchè c i
saranno degli Stat i ).
Quanto al la strategia del la rivoluzione mondiale, è una cosa un po' p i ù
complicata, che non nasce a tavolino (a Pechino o a Tor ino o a New York) ,
ma ne l v i vo d i una serie d i esperienze che l e avanguardie rivoluzionarie
costruiscono, maturano, magari bruciano in ogni parte del mondo. Che i cinesi
non possano fare la rivoluzione 'per noi è cosa che sappiamo tut t i . Occorre
che ce ne convinciamo sul serio. Non è stato propr io Mao a insegnarci che
«occorre contare 'sulle propr ie forze »?
d)
E d eccoci a l Quarto Pericolo, che consiste press'a poco ne l di re:
«insomma, bisogna farla f ini ta con le illusioni; la Cina è una grande potenza
come tut te l e al tre, e f a una pol i t ica da grande potenza ». Sono certo che
qualcuno dei miei lettori at tr ibui rà anche a me un simile giudizio (che invece
considero l imi tato e unilaterale). Un corol lario d i questo modo d i ragionare
è questo: «siccome la pol itica estera non è staccata dal la pol itica interna, è
probabile che ormai anche l'esperienza cinese (come già quel la sovietica, o
quella cubana) sia f ini ta male ». Ora, io credo che una delle cose p i ù sacro-
sante che i compagni cinesi c i abbiano insegnato sia propr io questa: che i l
reale è contraddittorio, che le contraddizioni non scompaiono dopo la presa
del potere ma sono destinate a rimanere i n vi ta per un tempo lunghissimo.
La pol itica estera della Repubblica Popolare cinese, stato socialista, ne è un
esempio. E i l suo rapporto con la pol itica interna va visto anch'esso i n ma-
niera complessa e dialettica: at tr ibui re la nuova offensiva diplomatica cinese
a una ripresa degli sconf i tt i del la rivoluzione culturale, o al la nascita di una
nuova opposizione a Mao sarebbe per l o meno una banale e indebi ta serri-
73 —
















