
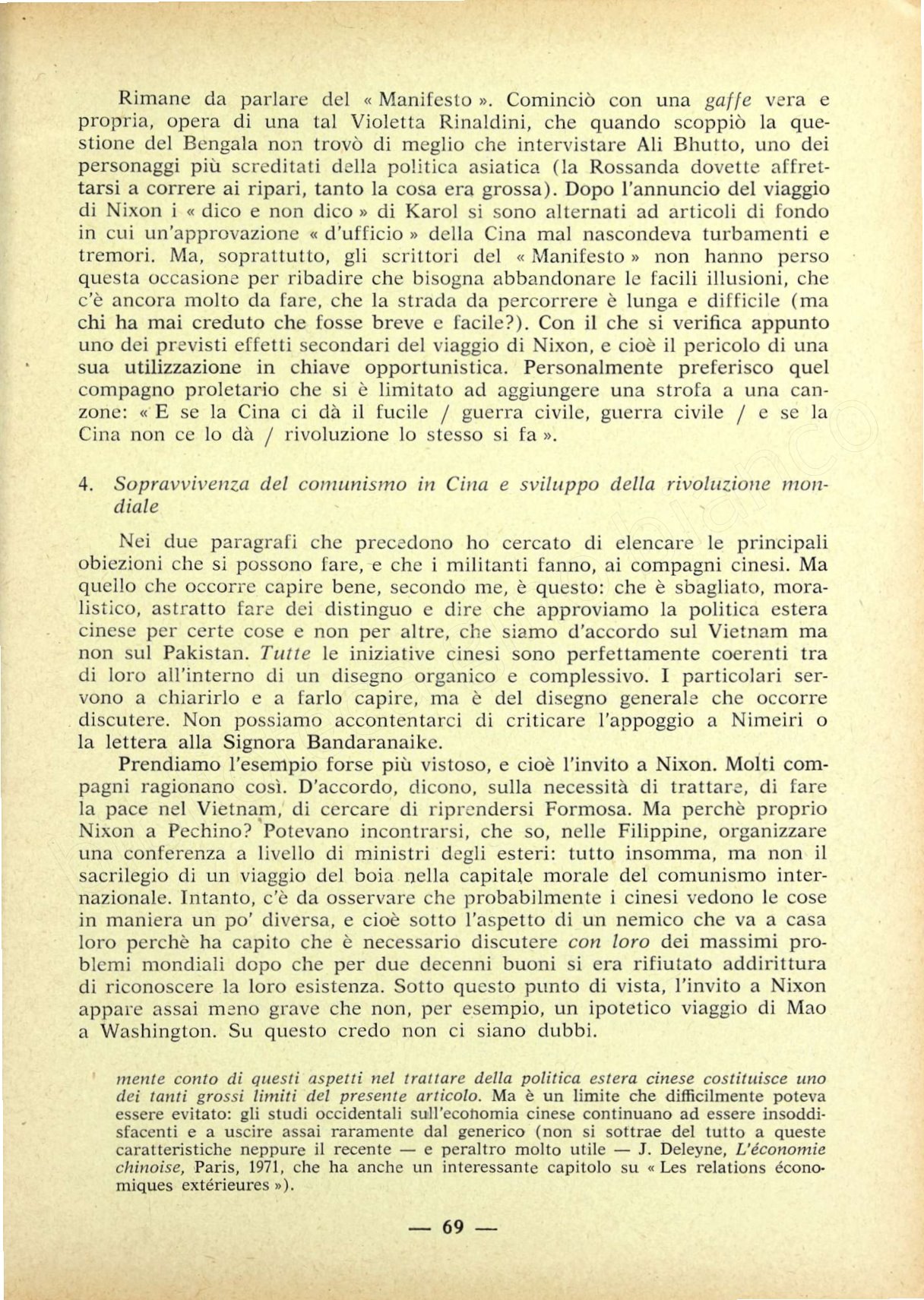
Rimane da par lare de l « Manifesto ». Cominciò con una
gaffe
vera e
propria, opera d i una t a l Violet ta Rinaldini , che quando scoppiò l a que-
stione del Bengala non trovò d i megl io che intervistare A l i Bhut to, uno dei
personaggi p i ù screditati del la pol i t ica asiatica ( l a Rossanda dovette affret-
tarsi a correre ai ripari, tanto la cosa era grossa). Dopo l'annuncio del viaggio
di Nixon i « dico e non dico)> d i Karol si sono al ternat i ad art icol i d i fondo
in cui un'approvazione « d'ufficio » del la Cina mal nascondeva turbament i e
tremori. Ma , soprat tut to, g l i scr i t tor i de l «Mani festo » non hanno perso
questa occasione per ribadire che bisogna abbandonare le faci l i i l lusioni, che
c'è ancora mol to da fare, che la strada da percorrere è lunga e di ff ici le (ma
chi ha mai creduto che fosse breve e facile?). Con i l che si verifica appunto
uno dei previsti effetti secondari del viaggio di Nixon, e cioè i l pericolo di una
sua utilizzazione i n chiave opportunist ica. Personalmente prefer isco que l
compagno proletario che si è l imi tato ad aggiungere una strofa a una can-
zone: (c• E se l a Cina c i dà i l fuci le / guerra civi le, guerra civi le / e se l a
Cina non ce lo dà / rivoluzione l o stesso si fa ».
4.
Sopravvivenza del comunismo i n Cina e svi luppo del la rivoluzione mon-
diale
Nei due paragraf i che precedono ho cercato d i elencare l e pr incipal i
obiezioni che si possono fare, e che i mi l i tant i fanno, ai compagni cinesi. Ma
quello che occorre capire bene, secondo me, è questo: che è sbagliato, mora-
listico, astratto fare dei distinguo e di re che approviamo l a pol i t ica estera
cinese per certe cose e non per altre, che siamo d'accordo sul Vietnam ma
non sul Pakistan.
Tut te
l e iniziative cinesi sono perfettamente coerenti t r a
di l oro al l ' interno d i un disegno organico e complessivo. I par t icolar i ser-
vono a chiar i r lo e a far l o capire, ma è de l disegno generale che occorre
discutere. Non possiamo accontentarci d i cr i t icare l'appoggio a Nime i r i o
la lettera al la Signora Bandaranaike.
Prendiamo l'esempio forse più vistoso, e cioè l ' invi to a Nixon. Mol t i com-
pagni ragionano così. D'accordo, dicono, sul la necessità d i trat tare, d i fare
la pace nel Vietnam,' di cercare d i riprendersi Formosa. Ma perchè propr io
Nixon a Pechino? "Potevano incontrarsi, che so, nel le Fi l ippine, organizzare
una conferenza a l ivel lo d i minist r i degl i esteri: t u t t o insomma, ma non i l
sacrilegio di un viaggio del boia nel la capitale morale del comunismo inter-
nazionale. Intanto, c'è da osservare che probabilmente i cinesi vedono le cose
in maniera un po' diversa, e cioè sotto l'aspetto di un nemico che va a casa
loro perchè ha capito che è necessario discutere
con loro
dei massimi pro-
blemi mondial i dopo che per due decenni buoni s i era r i f iutato addi r i t tura
di riconoscere la loro esistenza. Sotto questo punto di vista, l ' invi to a Nixon
appare assai meno grave che non, per esempio, un ipotetico viaggio d i Mao
a Washington. Su questo credo non c i siano dubbi .
mente conto di questi aspetti nel trattare della politica estera cinese costituisce uno
dei tanti grossi limiti del presente articolo. Ma è un limite che difficilmente poteva
essere
evitato: gli studi occidentali sull'economia cinese continuano ad essere insoddi-
sfacenti e a uscire assai raramente dal generico (non si sottrae del tutto a queste
caratteristiche neppure i l recente — e peraltro molto utile — J. Deleyne,
L'économie
chinoise,
Paris, 1971, che ha anche un interessante capitolo su « Les relations écono-
miques extérieures »).
— 69
















