
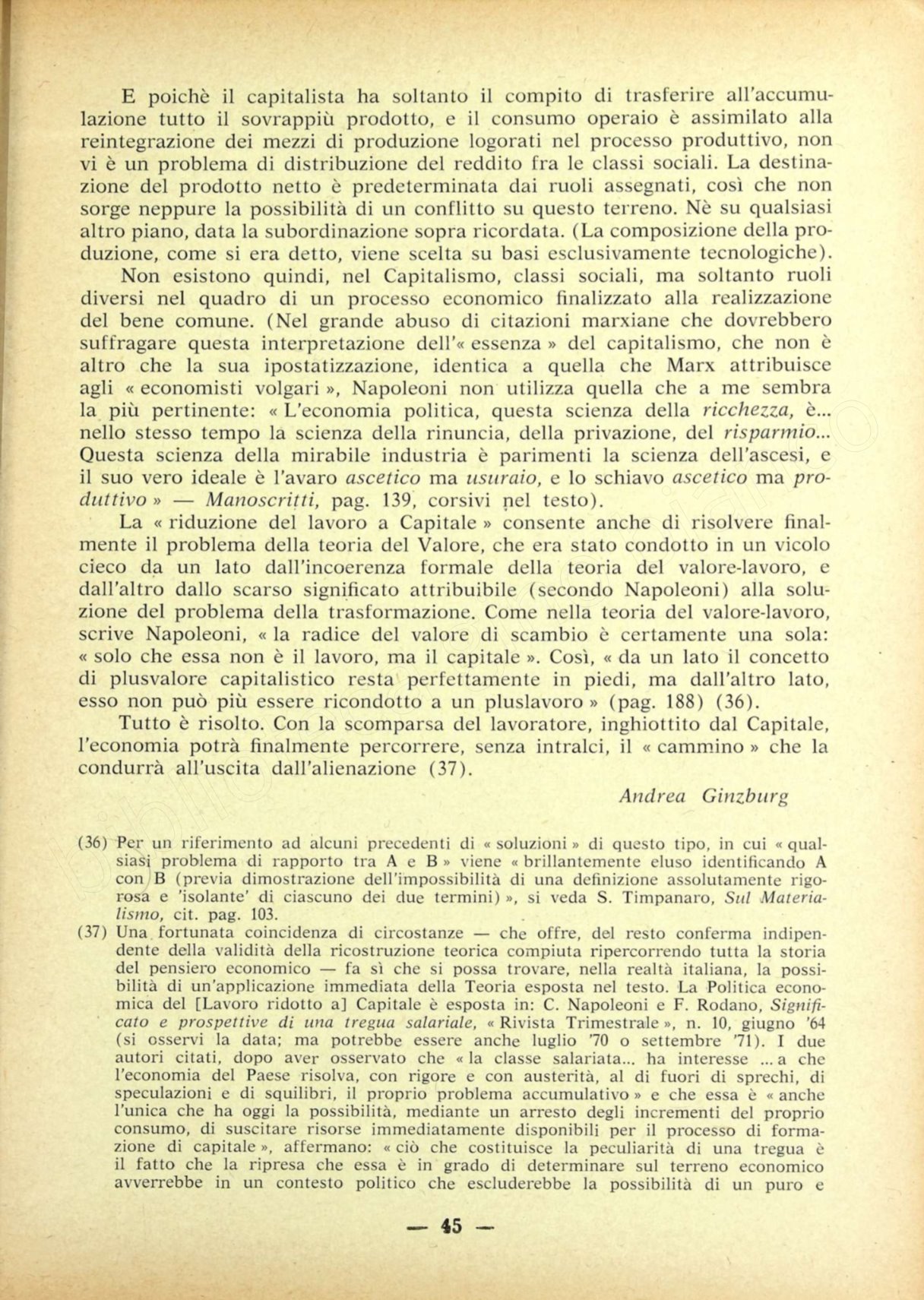
Epoichè il capitalistahasoltanto il compito di trasferireal'accumu-
lazionetutto il sovrappiùprodotto, e il consumooperaioèassimilatoalla
reintegrazionedeimezzidiproduzionelogoratinelprocessoproduttivo,non
vièunproblemadi distribuzionedel reddito fra leclassisociali.Ladestina-
zionedelprodottonettoèpredeterminatadai ruoliassegnati,cosìchenon
sorgeneppurelapossibilitàdiunconflittosuquestoterreno.Nèsuqualsiasi
altropiano,datalasubordinazionesopraricordata.(Lacomposizionedellapro-
duzione,comesieradetto,vienesceltasubasiesclusivamentetecnologiche).
Nonesistonoquindi, nelCapitalismo,classi sociali,masoltanto ruoli
diversinel quadro di unprocessoeconomicofinalizzatoallarealizzazione
delbenecomune.(Nelgrandeabusodi citazionimarxianechedovrebbero
sufragarequestainterpretazionedell'«essenza»delcapitalismo,chenonè
altroche la suaipostatizzazione, identica a quellacheMarxattribuisce
agli(<economistivolgari»,Napoleoninonutilizzaquellacheamesembra
lapiùpertinente:«L'economiapolitica,questascienzadella
ricchezza,
è...
nelostessotempolascienzadellarinuncia,dellaprivazione,del
risparmio...
Questascienzadellamirabileindustriaèparimenti lascienzadel'ascesi,e
il suoveroidealeèl'avaro
ascetico
ma
usuraio,
eloschiavo
ascetico
ma
pro-
duttivo»
—
Manoscritti,
pag.139,corsivi nel testo).
La«riduzionedel lavoroaCapitale»consenteanchedi risolverefinal-
menteil problemadellateoriadelValore,cheerastatocondottoinunvicolo
ciecoda
un
latodal'incoerenzaformaledella teoria del valore-lavoro, e
dall'altrodalloscarsosignificatoattribuibile(secondoNapoleoni)allasolu-
zionedelproblemadellatrasformazione.Comenellateoriadelvalore-lavoro,
scriveNapoleoni,«la radicedelvalore di scambioècertamenteunasola:
«solocheessanonè il lavoro,ma il capitale».Così,«daunlato il concetto
diplusvalorecapitalisticorestaperfettamente in piedi,madall'altro lato,
essononpuòpiùesserericondottoaunpluslavoro»(pag.188)(36).
Tuttoèrisolto.Conlascomparsadel lavoratore, inghiottitodalCapitale,
l'economiapotràfinalmentepercorrere,senzaintralci, il «cammino»chela
condurràall'uscitadal'alienazione(37).
AndreaGinzburg
(36)Perunriferimentoadalcuniprecedenti di «soluzioni»di questotipo, in cui «qual-
siasiproblemadi rapporto tra Ae B»viene«brilantementeelusoidentificandoA
con
!B
(previadimostrazionedell'impossibilità di unadefinizioneassolutamenterigo-
rosae 'isolante' di ciascunodeiduetermini)», si vedaS.Timpanaro,
SulMateria-
lismo,
cit. pag.103.
(37)Unafortunatacoincidenzadi circostanze—cheoffre, del restoconfermaindipen-
dentedellavaliditàdellaricostruzioneteoricacompiutaripercorrendo tutta la storia
.delpensieroeconomico—fa si chesi possatrovare,nellarealtà italiana, lapossi-
bilità di un'applicazioneimmediatadellaTeoriaespostanel testo.LaPoliticaecono-
micadel [Lavororidotto a]Capitaleèespostain: C.NapoleonieF.Rodano,
Signifi-
catoeprospettive di unatreguasalariale,«RivistaTrimestrale»,n. 10,giugno'64
(siosservi la data;mapotrebbeessereanche luglio '70 o settembre'71). I due
autori citati, dopoaverosservatoche «laclassesalariata... ha interesse ...ache
l'economiadelPaeserisolva, conrigore econausterità, al di fuori di sprechi, di
speculazionie di squilibri, il proprioproblemaaccumulativo»echeessaè«anche
l'unicachehaoggi la possibilità,medianteunarrestodegli incrementi del proprio
consumo,di suscitarerisorseimmediatamentedisponibili per il processodi forma-
zionedi capitale»,affermano: «ciòchecostituisce la peculiarità di unatregua è
il fattoche la ripresacheessaè in grado di determinaresul terrenoeconomico
avverrebbe in un contestopolitico cheescluderebbe la possibilità di un puro e
- 45.-.
















