
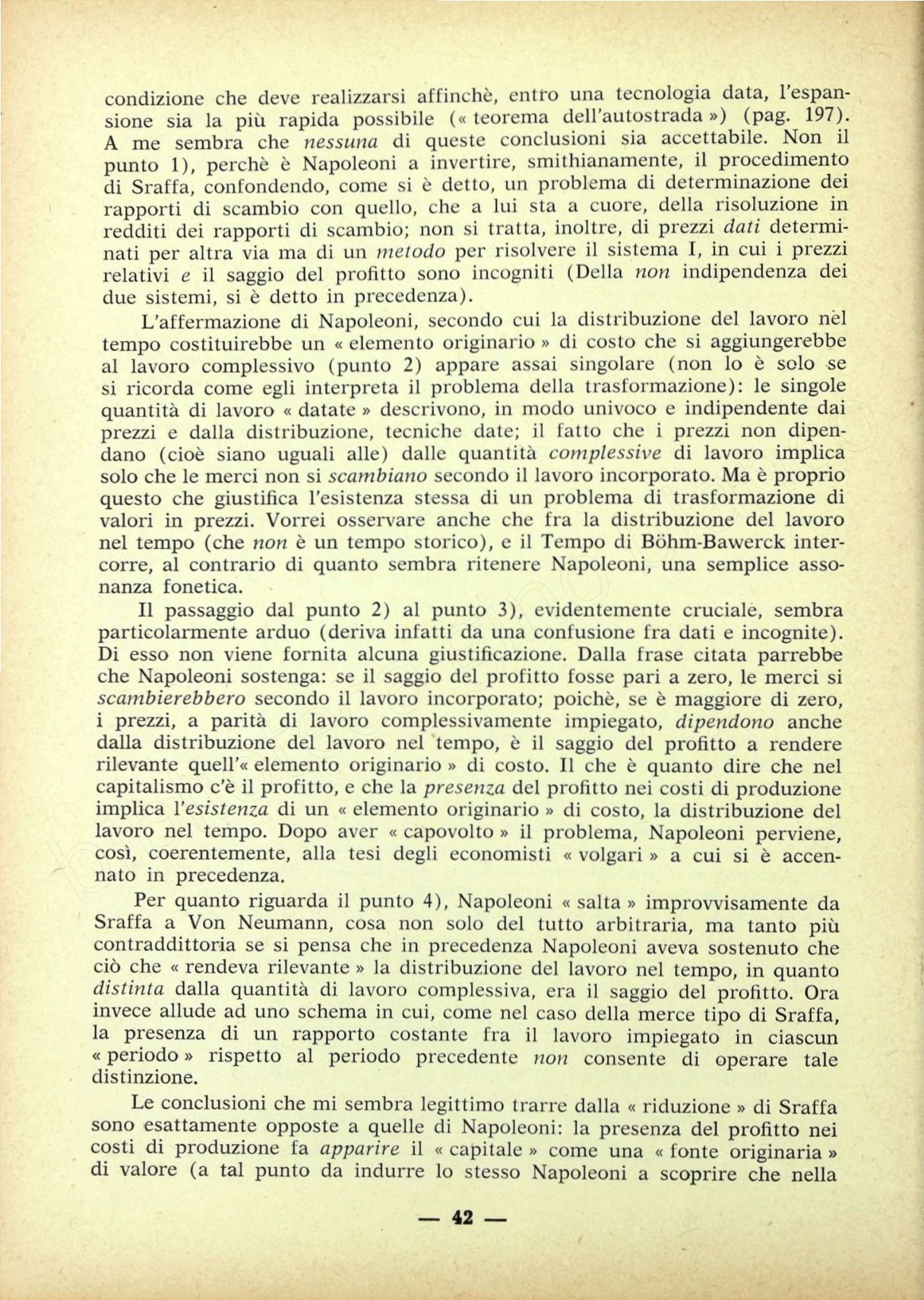
condizione che deve realizzarsi affinché, ent ro una tecnologia data, l'espan-
sione s i a l a p i ù rapida possibile ( « teorema dell 'autostrada ») (pag. 197).
A me sembra che
nessuna
d i queste conclusioni s i a accettabile. No n i l
punto 1) , perchè è Napoleoni a invertire, smithianamente, i l procedimento
di Sraffa, confondendo, come si è detto, un problema d i determinazione dei
rapporti d i scambio con quello, che a l u i sta a cuore, del la risoluzione i n
redditi dei rapport i d i scambio; non si tratta, inoltre, di prezzi
dat i
determi-
nati per al tra via ma di un
metodo
per risolvere i l sistema I , i n cui i prezzi
relativi e i l saggio del prof i t to sono incogni t i (Del la
non
indipendenza dei
due sistemi, si è detto in precedenza).
L'affermazione d i Napoleoni, secondo cui la distribuzione del lavoro nél
tempo costituirebbe un « elemento originario » d i costo che si aggiungerebbe
al lavoro complessivo (punto 2) appare assai singolare ( non l o è solo se
si ricorda come egli interpreta i l problema del la trasformazione): l e singole
quantità di lavoro « datate » descrivono, in modo univoco e indipendente dai
prezzi e dal la distribuzione, tecniche date; i l fat to che i prezzi non dipen-
dano (cioè siano ugual i al le) dal le quant i tà
complessive
d i lavoro impl ica
solo che le merci non si
scambiano
secondo i l lavoro incorporato. Ma è proprio
questo che giustifica l'esistenza stessa d i un problema d i trasformazione d i
valori i n prezzi. Vor rei osservare anche che f r a l a distribuzione del lavoro
nel tempo (che
non
è un tempo storico), e i l Tempo di Bohm-Bawerck inter-
corre, al contrario d i quanto sembra ritenere Napoleoni, una semplice asso-
nanza fonetica.
I l passaggio dal punto 2) a l punto 3) , evidentemente cruciale, sembra
particolarmente arduo (deriva infat t i da una confusione f ra dati e incognite).
Di esso non viene forni ta alcuna giustificazione. Dal la frase ci tata parrebbe
che Napoleoni sostenga: se i l saggio del prof i t to fosse pari a zero, le merci si
scambierebbero
secondo i l lavoro incorporato; poichè, se è maggiore di zero,
i prezzi, a par i tà d i lavoro complessivamente impiegato,
dipendono
anche
dalla distribuzione del lavoro nel 'tempo, è i l saggio del prof i t to a rendere
rilevante quell'« elemento originario» d i costo. I l che è quanto di re che nel
capitalismo c'è i l profitto, e che la
presenza
del profitto nei costi di produzione
implica
l'esistenza
di un « elemento originario)) d i costo, la distribuzione del
lavoro nel tempo. Dopo aver « capovolto » i l problema, Napoleoni perviene,
così, coerentemente, al la tesi degl i economisti « volgari » a cu i s i è accen-
nato i n precedenza.
Per quanto riguarda i l punto
4),
Napoleoni « salta » improvvisamente da
Sraffa a Von Neumann, cosa non solo de l t u t t o arbi trar ia, ma tanto p i ù
contraddittoria se si pensa che in precedenza Napoleoni aveva sostenuto che
ciò che « rendeva rilevante » la distribuzione del lavoro nel tempo, i n quanto
distinta
dal la quantità d i lavoro complessiva, era i l saggio del prof i tto. Ora
invece allude ad uno schema in cui, come nel caso della merce t ipo di Sraffa,
la presenza d i u n rappor to costante f r a i l l avoro impiegato i n ciascun
« periodo » r ispet to a l per iodo precedente
non
consente d i operare t a l e
distinzione.
Le conclusioni che mi sembra legittimo trarre dalla « riduzione » di Sraffa
sono esattamente opposte a quelle d i Napoleoni: l a presenza del prof i t to nei
costi d i produzione f a
apparire
i l «capitale » come una «fonte originaria »
di valore ( a t a l punto da indurre l o stesso Napoleoni a scoprire che nel la
















