
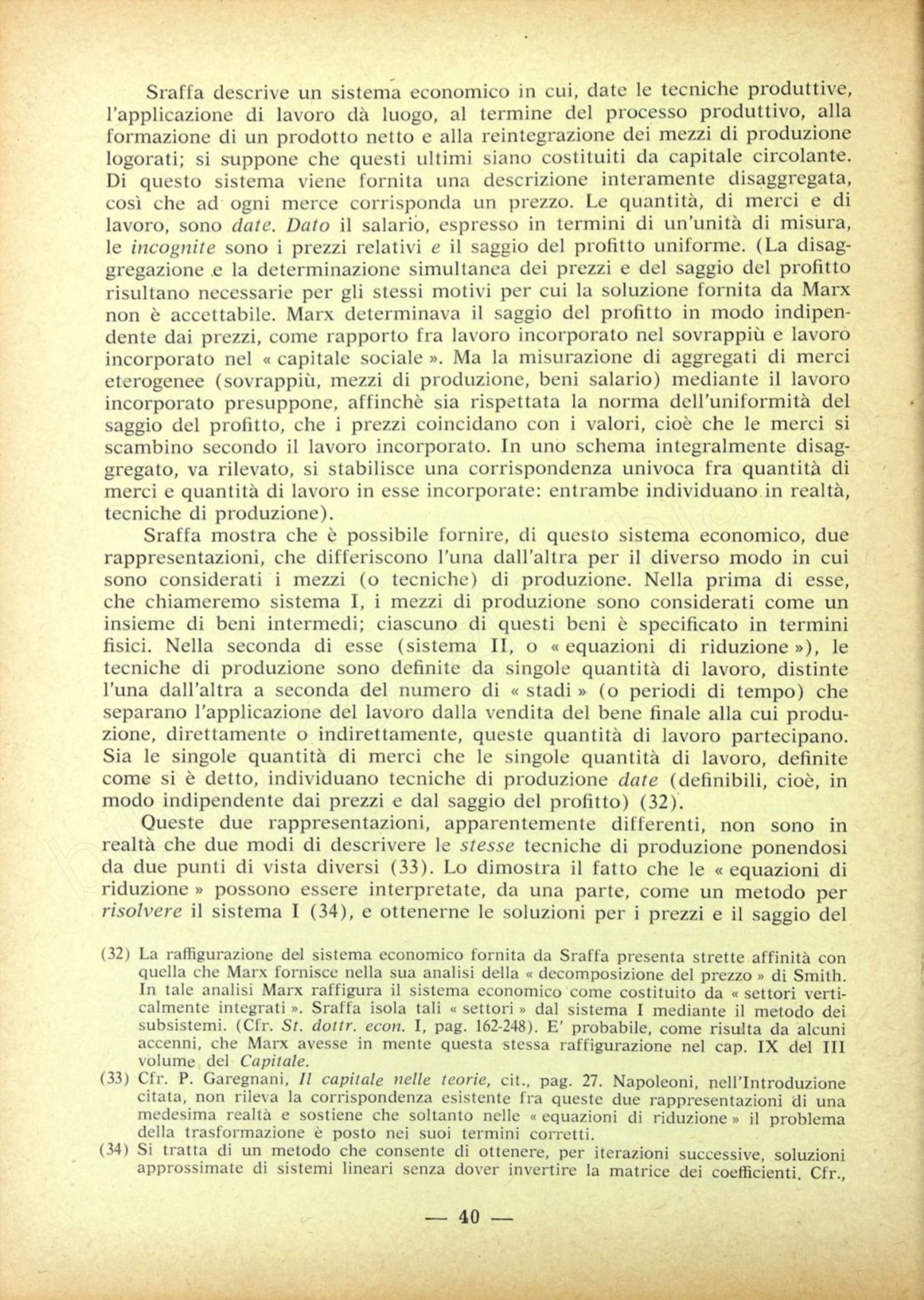
•
Sraffa descrive un sistema economico in cui, date le tecniche produttive,
l'applicazione d i lavoro dà luogo, a l termine de l processo produt t ivo, al la
formazione di un prodotto netto e alla reintegrazione dei mezzi di produzione
logorati; s i suppone che questi ul t imi siano cost i tui t i da capitale circolante.
Di questo sistema viene forni ta una descrizione interamente disaggregata,
così che ad- ogni merce corrisponda un prezzo. Le quantità, d i merci e d i
lavoro, sono
date. Dato
i l salario, espresso i n termini d i un'uni tà d i misura,
le
incognite
sono i prezzi relativi e i l saggio del prof i tto uniforme. (La disag-
gregazione .e la determinazione simultanea dei prezzi e del saggio del prof i tto
risultano necessarie per gl i stessi mot ivi per cui la soluzione forni ta da Marx
non è accettabile. Marx determinava i l saggio del prof i t to i n modo indipen-
dente dai prezzi, come rapporto fra lavoro incorporato nel sovrappiù e lavoro
incorporato nel « capitale sociale ». Ma la misurazione d i aggregati d i merci
eterogenee (sovrappiù, mezzi d i produzione, beni salario) mediante i l lavoro
incorporato presuppone, affinchè sia rispettata l a norma del l 'uni formi tà del
saggio del profitto, che i prezzi coincidano con i valori, cioè che le merci si
scambino secondo i l lavoro incorporato. I n uno schema integralmente disag-
gregato, va rilevato, si stabilisce una corrispondenza univoca f ra quantità d i
merci e quantità di lavoro in esse incorporate: entrambe individuano in realtà,
tecniche di produzione).
Sraffa mostra che è possibile fornire, d i questo sistema economico, due
rappresentazioni, che differiscono l 'una dal l 'altra per i l diverso modo i n cui
sono considerati i mezzi ( o tecniche) d i produzione. Nel la pr ima d i esse,
che chiameremo sistema I , i mezzi d i produzione sono considerati come un
insieme d i beni intermedi; ciascuno d i questi beni è specificato i n termini
fisici. Nel la seconda d i esse (sistema I I , o « equazioni d i r iduzione »), l e
tecniche d i produzione sono definite da singole quant i tà d i lavoro, dist inte
l'una dal l 'al tra a seconda del numero d i « stadi » ( o periodi d i tempo) che
separano l'applicazione del lavoro dalla vendita del bene finale alla cui produ-
zione, direttamente o indirettamente, queste quant i tà d i lavoro partecipano.
Sia l e singole quant i tà d i merci che l e singole quant i tà d i lavoro, definite
come si è detto, individuano tecniche d i produzione
date
(def inibi l i , cioè, i n
modo indipendente dai prezzi e dal saggio del prof i tto) (32)..
Queste due rappresentazioni, apparentemente di fferent i , non sono i n
realtà che due modi di descrivere le
stesse
tecniche di produzione ponendosi
da due punt i d i vista diversi (33). Lo dimostra i l fat to che le « equazioni d i
riduzione » possono essere interpretate, da una parte, come un metodo per
risolvere
i l sistema I (34), e ottenerne le soluzioni per i prezzi e i l saggio del
(32) La raffigurazione del sistema economico fornita da Sraffa presenta strette affinità con
quella che Marx fornisce nella sua analisi della « decomposizione del prezzo)) di Smith.
In tale analisi Marx raffigura i l sistema economico come costituito da « settori verti-
calmente integrati ». Sraffa isola tal i « settori » dal sistema I mediante i l metodo dei
subsistemi. (Cf r.
St. dot t r. econ.
I , pag. 162-248). E' probabile, come risul ta da alcuni
accenni, che Marx avesse i n mente questa stessa raffigurazione nel cap. I X del I I I
volume del
Capitale.
(33) Cfr. P. Garegnani,
I l capitale nelle teorie,
ci t., pag. 27. Napoleoni, nell'Introduzione
citata, non rileva la corrispondenza esistente f ra queste due rappresentazioni d i una
medesima realtà e sostiene che soltanto nelle «equazioni d i riduzione)) i l problema
della trasformazione è posto nei suoi termini corretti.
(34) Si t rat ta d i un metodo che consente d i ottenere, per iterazioni successive, soluzioni
approssimate di sistemi l ineari senza dover invertire la matrice dei coefficienti. Cfr.,
40 —
















