
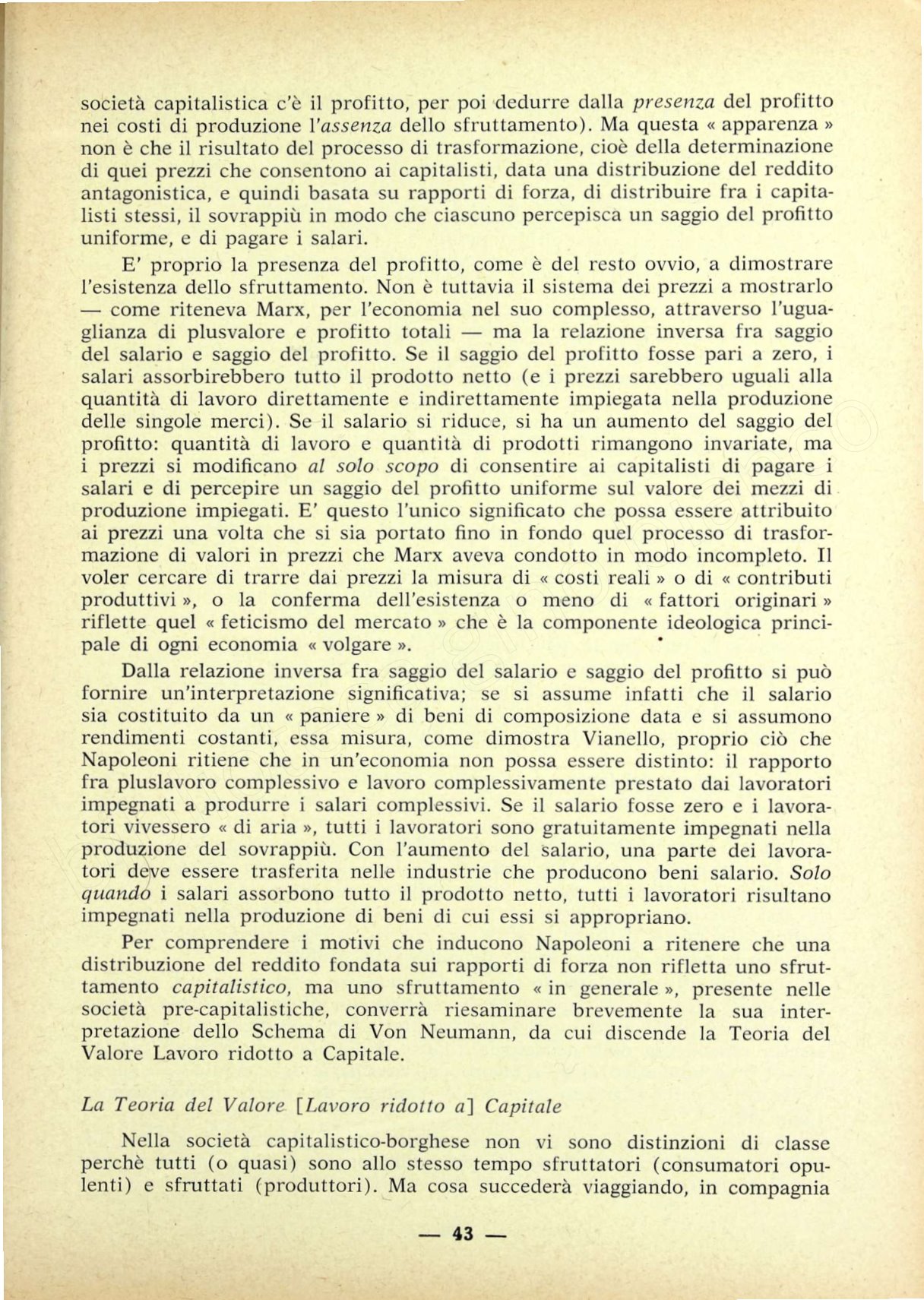
società capitalistica c'è il profitto, per poi 'dedurre dalla
presenza
del profitto
nei costi di produzione
l'assenza
dello sfruttamento). Ma questa « apparenza »
non è che il risultato del processo di trasformazione, cioè della determinazione
di quei prezzi che consentono ai capitalisti, data una distribuzione del reddito
antagonistica, e quindi basata su rapporti di forza, di distribuire fra i capita-
listi stessi, il sovrappiù in modo che ciascuno percepisca un saggio del profitto
uniforme, e di pagare i salari.
E' proprio la presenza del profitto, come è del resto ovvio, a dimostrare
l'esistenza dello sfruttamento. Non è tuttavia il sistema dei prezzi a mostrarlo
come riteneva Marx, per l'economia nel suo complesso, attraverso l'ugua-
glianza di plusvalore e profitto totali — ma la relazione inversa fra saggio
del salario e saggio del profitto. Se i l saggio del profitto fosse pari a zero, i
salari assorbirebbero tutto il prodotto netto (e i prezzi sarebbero uguali alla
quantità di lavoro direttamente e indirettamente impiegata nella produzione
delle singole merci). Se i l salario si riduce, si ha un aumento del saggio del
profitto: quantità di lavoro e quantità di prodotti rimangono invariate, ma
i prezzi si modificano
al solo scopo
di consentire ai capitalisti di pagare i
salari e di percepire un saggio del profitto uniforme sul valore dei mezzi di
produzione impiegati. E' questo l'unico significato che possa essere attribuito
ai prezzi una volta che si sia portato fino in fondo quel processo di trasfor-
mazione di valori in prezzi che Marx aveva condotto in modo incompleto. I l
voler cercare di trarre dai prezzi la misura di « costi reali » o di « contributi
produttivi », o l a conferma dell'esistenza o meno d i « fattori originari »
riflette quel « feticismo del mercato'> che è la componente ideologica princi-
pale di ogni economia « volgare ».
Dalla relazione inversa fra saggio del salario e saggio del profitto si può
fornire un'interpretazione significativa; se s i assume infatti che i l salario
sia costituito da un « paniere » di beni di composizione data e si assumono
rendimenti costanti, essa misura, come dimostra Vianello, proprio ciò che
Napoleoni ritiene che in un'economia non possa essere distinto: i l rapporto
fra pluslavoro complessivo e lavoro complessivamente prestato dai lavoratori
impegnati a produrre i salari complessivi. Se i l salario fosse zero e i lavora-
tori vivessero «di aria », tutti i lavoratori sono gratuitamente impegnati nella
produzione del sovrappiù. Con l'aumento del salario, una parte dei lavora-
tori Ove essere trasferita nelle industrie che producono beni salario.
Solo
quandò
i salari assorbono tutto i l prodotto netto, tutti i lavoratori risultano
impegnati nella produzione di beni di cui essi si appropriano.
Per comprendere i motivi che inducono Napoleoni a ritenere che una
distribuzione del reddito fondata sui rapporti di forza non rifletta uno sfrut-
tamento
capitalistico,
ma uno sfruttamento « in generale », presente nelle
società pre-capitalistiche, converrà riesaminare brevemente l a sua inter-
pretazione dello Schema d i Von Neumann, da cui discende l a Teoria del
Valore Lavoro ridotto a Capitale.
La Teoria del Valore [Lavoro ridotto a] Capitale
Nella società capitalistico-borghese non v i sono distinzioni d i classe
perchè tutti (o quasi) sono allo stesso tempo sfruttatori (consumatori opu-
lenti) e sfruttati (produttori). Ma cosa succederà viaggiando, in compagnia
43 - -
















