
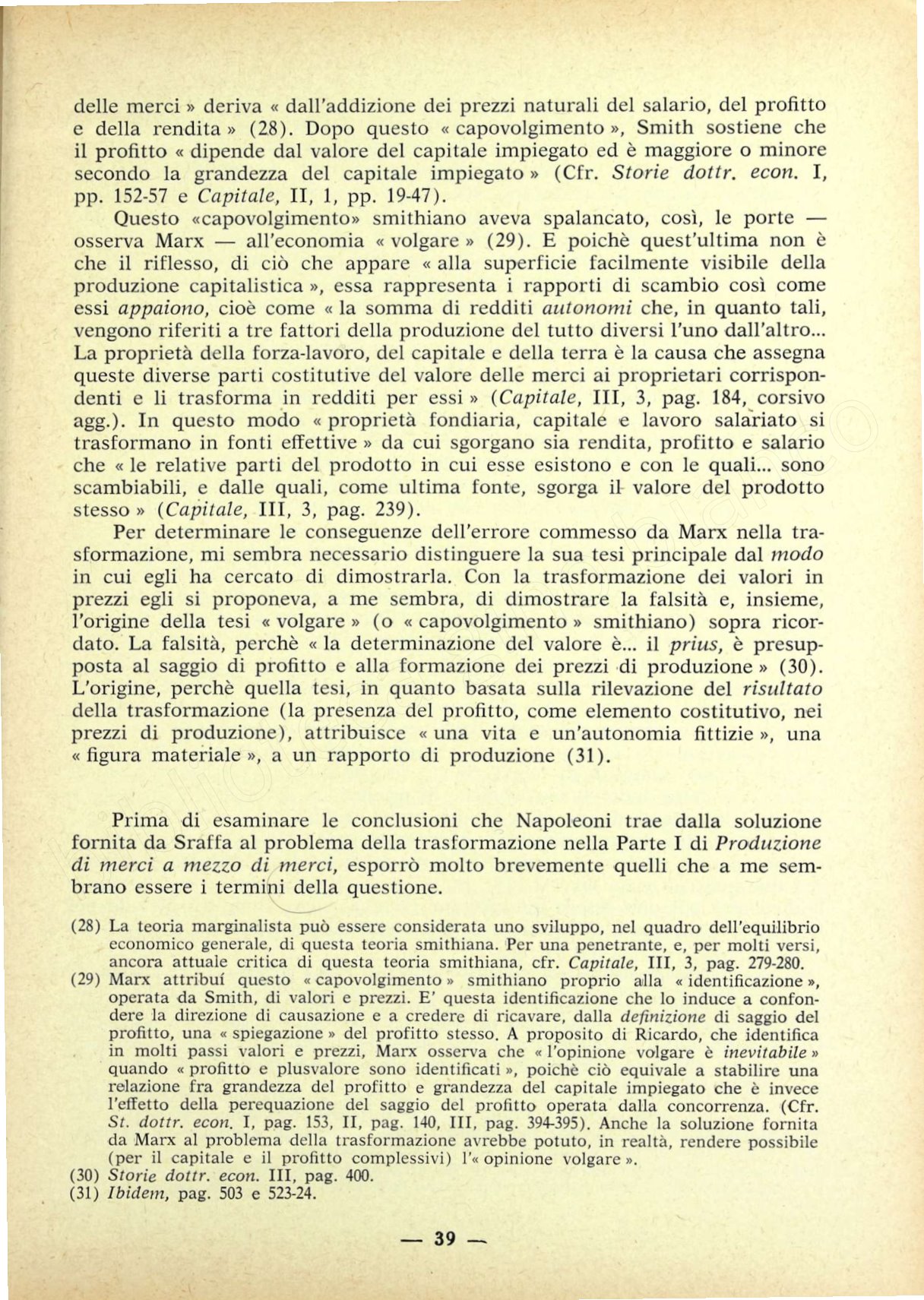
delle merci » deriva « dall'addizione dei prezzi naturali del salario, del profitto
e della rendita)) (28) . Dopo questo « capovolgimento », Smith sostiene che
il profitto « dipende dal valore del capitale impiegato ed è maggiore o minore
secondo l a grandezza del capitale impiegato » (Cf r.
Storie dottr. econ.
I ,
pp. 152-57 e
Capitale, I I ,
1, pp. 19-47).
Questo «capovolgimento» smithiano aveva spalancato, così, l e porte —
osserva Marx — all'economia « volgare » (29). E poichè quest'ultima non è
che i l riflesso, d i ciò che appare <calla superficie facilmente visibile della
produzione capitalistica », essa rappresenta i rapporti di scambio così come
essi
appaiono,
cioè come « la somma di redditi
autonomi
che, in quanto tali,
vengono riferiti a tre fattori della produzione del tutto diversi l'uno dall'altro...
La proprietà della forza-lavoro, del capitale e della terra è la causa che assegna
queste diverse parti costitutive del valore delle merci ai proprietari corrispon-
denti e l i trasforma in redditi per essi »
(Capitale,
I I I , 3, pag. 184, corsivo
agg.). I n questo modo « proprietà fondiaria, capitale e lavoro sala-riato si
trasformano in fonti effettive » da cui sgorgano sia rendita, profitto e salario
che « le relative parti del prodotto in cui esse esistono e con le quali.., sono
scambiabili, e dalle quali, come ultima fonte, sgorga i l valore del prodotto
stesso »
(Cap-itale,
I I I , 3, pag. 239).
Per determinare le conseguenze dell'errore commesso da Marx nella tra-
sformazione, mi sembra necessario distinguere la sua tesi principale dal
modo
in cui egli ha cercato d i dimostrarla. Con l a trasformazione dei valori i n
prezzi egli si proponeva, a me sembra, di dimostrare la falsità e, insieme,
l'origine della tesi « volgare » ( o « capovolgimento » smithiano) sopra ricor-
dato. La falsità, perchè « la determinazione del valore è... i l
prius,
è presup-
posta al saggio di profitto e alla formazione dei prezzi idi produzione » (30).
L'origine, perchè quella tesi, in quanto basata sulla rilevazione del
risultato
della trasformazione ( la presenza del profitto, come elemento costitutivo, nei
prezzi d i produzione), attribuisce «una vita e un'autonomia fittizie », una
«figura materiale », a un rapporto di produzione (31).
Prima d i esaminare l e conclusioni che Napoleoni trae dalla soluzione
fornita da Sraf fa al problema della trasformazione nella Parte I di
Produzione
di merci
a
mezzo di merci,
esporrò molto brevemente quelli che a me sem-
brano essere i termini della questione.
(28) La teoria marginalista può essere considerata uno sviluppo, nel quadro dell'equilibrio
economico generale, di questa teoria smithiana. Per una penetrante, e, per molti versi,
ancora attuale critica di questa teoria smithiana, cfr.
Capitale, I I I ,
3, pag. 279-280.
(29) Ma n attribui questo « capovolgimento » smithiano proprio al la « identificazione »,
operata da Smith, di valori e prezzi. E' questa identificazione che lo induce a confon-
dere la direzione di causazione e a credere di ricavare, dalla
definizione
di saggio del
profitto, una « spiegazione » del profitto stesso. A proposito di Ricardo, che identifica
in molti passi valori e prezzi, Marx osserva che « l'opinione volgare è
inevitabile
»
quando « profitto e plusvalore sono identificati », poichè ciò equivale a stabilire una
relazione fra grandezza del profitto e grandezza del capitale impiegato che è invece
l'effetto della perequazione del saggio del profitto operata dalla concorrenza. (Cfr.
St. dottr. econ.
I , pag. 153, I I , pag. 140, I I I , pag. 394-395). Anche la soluzione fornita
•daMarx al problema della trasformazione avrebbe potuto, in realtà, rendere possibile
(per i l capitale e i l profitto complessivi) l'« opinione volgare ».
(30)
Storie dottr. econ.
I I I , pag. 400.
(31)
Ibidem,
pag. 503 e 523-24.
39 - ~
















