
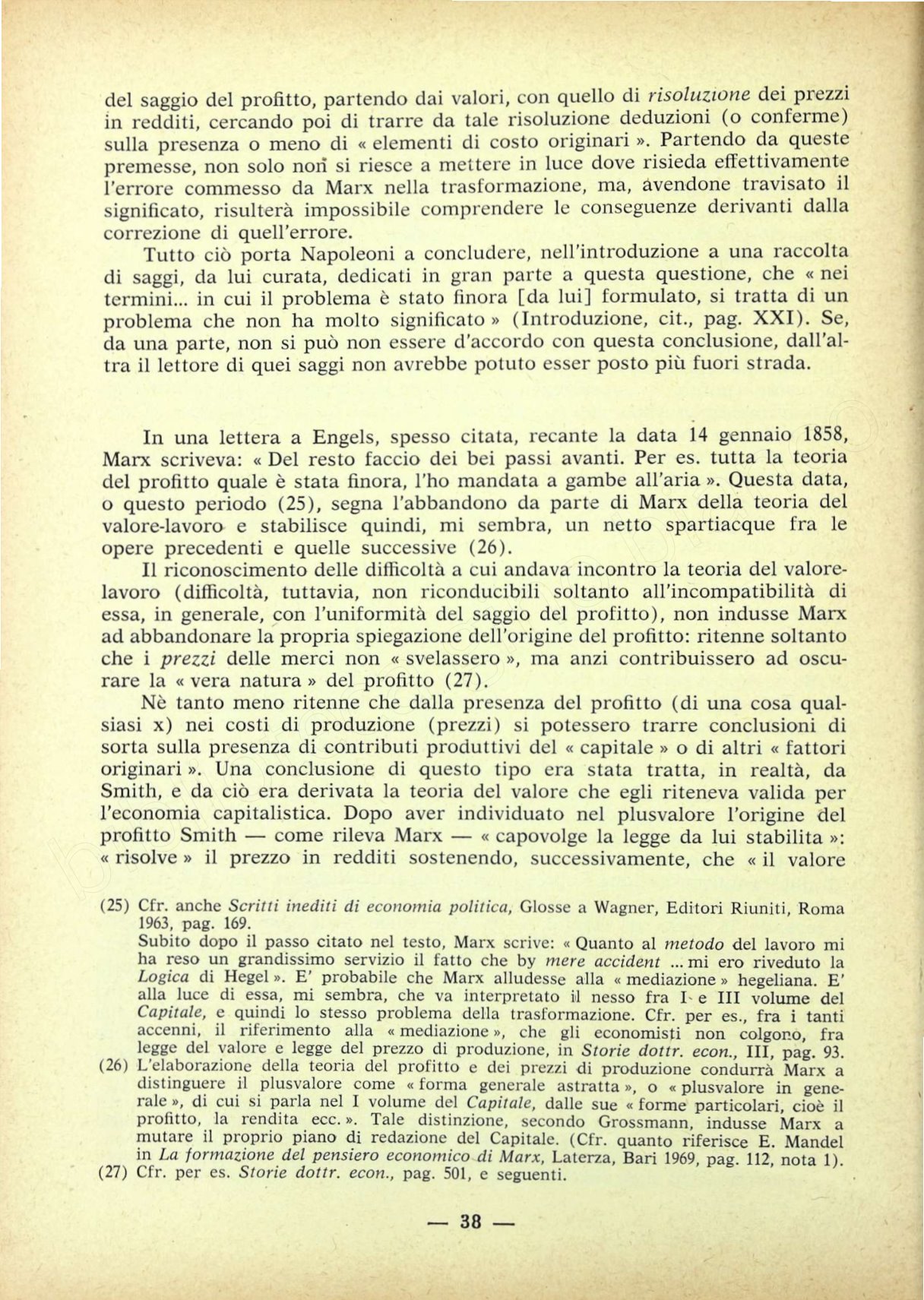
del saggio del profitto, partendo dai valori, con quello di
risoluzione
dei prezzi
in redditi, cercando poi d i trarre da tale risoluzione deduzioni ( o conferme)
sulla presenza o meno d i « elementi d i costo originari ». Partendo da queste
premesse, non solo noni' si riesce a mettere in luce dove risieda effettivamente
l'errore commesso da Marx nel la trasformazione, ma, avendone travisato i l
significato, risulterà impossibile comprendere le conseguenze derivant i dal la
correzione d i quell'errore.
Tutto ciò porta Napoleoni a concludere, nell'introduzione a una raccolta
di saggi, da l u i curata, dedicati i n gran parte a questa questione, che « nei
termini.., i n cui i l problema è stato finora [ da lui ] formulato, si t rat ta di un
problema che non ha mol to significato » (Introduzione, ci t., pag. XX I ) . Se,
da una parte, non si può non essere d'accordo con questa conclusione, dall'al-
tra i l lettore di quei saggi non avrebbe potuto esser posto più fuori strada.
In una lettera a Engels, spesso citata, recante l a data 14 gennaio 1858,
Marx scriveva: « Del resto faccio dei bei passi avanti. Per es. tut ta la teoria
del prof i tto quale è stata finora, l 'ho mandata a gambe al l 'aria ». Questa data,
o questo periodo (25), segna l'abbandono da parte d i Marx del la teoria del
valore-lavora e stabilisce quindi , m i sembra, u n net to spartiacque f r a l e
opere precedenti e quelle successive (26).
I l riconoscimento delle difficoltà a cui andava incontro la teoria del valore-
lavoro (difficoltà, tut tavia, non r iconducibi l i sol tanto al l ' incompat ibi l i tà d i
essa, i n generale, con l 'uni formi tà del saggio del prof i t to) , non indusse Marx
ad abbandonare la propria spiegazione dell'origine del profitto: ritenne soltanto
che i
prezzi
delle merci non « svelassero », ma anzi contribuissero ad oscu-
rare la « vera natura » del prof i tto (27).
Nè tanto meno ritenne che dalla presenza del prof i tto ( d i una cosa qual-
siasi x ) ne i cost i d i produzione (prezzi) s i potessero t rar re conclusioni d i
sorta sulla presenza di contributi produt t ivi del « capitale » o di al t r i « fattori
originari ». Una conclusione d i questo t i po era stata t rat ta, i n real tà, da
Smith, e da ciò era derivata la teoria del valore che egli riteneva val ida per
l'economia capitalistica. Dopo aver individuato nel plusvalore l 'or igine de l
profitto Smi th — come rileva Marx — « capovolge la legge da l u i stabi l ita »:
« risolve » i l prezzo i n reddi t i sostenendo, successivamente, che « i l valore
(25) Cfr. anche
Scritti inediti di economia politica,
Glosse a Wagner, Edi tori Riuniti, Roma
1963, pag. 169.
Subito dopo i l passo citato nel testo, Marx scrive: « Quanto al
metodo
del lavoro mi
ha reso un grandissimo servizio i l fat to che by
mere accident . . .mi
ero riveduto l a
Logica
d i Hegel ». E ' probabile che Marx alludesse al la « mediazione» hegeliana. E '
alla luce d i essa, m i sembra, che va interpretato i l nesso f r a I - e I I I volume del
Capitale,
e quindi l o stesso problema della trasformazione. Cf r. per es., f r a i tant i
accenni, i l r i fer imento a l l a «mediazione », che g l i economisti n o n colgono, f r a
legge del valore e legge del prezzo di produzione, i n
Storie dot tr. econ., I I I ,
pag. 93.
(26) L'elaborazione della teoria del prof i t to e dei prezzi d i produzione condurrà Marx a
distinguere i l plusvalore come « forma generale astratta », o « plusvalore i n gene-
rale », d i cui si parla nel I volume del
Capitale,
dalle sue «forme particolari, cioè i l
profitto, l a rendi ta ecc. ». Ta l e distinzione, secondo Grossmann, indusse Ma r x a
mutare i l proprio piano d i redazione del Capitale. (Cf r. quanto riferisce E. Mandel
in La formazione del pensiero economicmdi Marx, Laterza, Bari 1969, pag. 112, nota 1).
(27) Cf r. per es.
Storie dot tr. econ.,
pag. 501, e seguenti.
38
















