
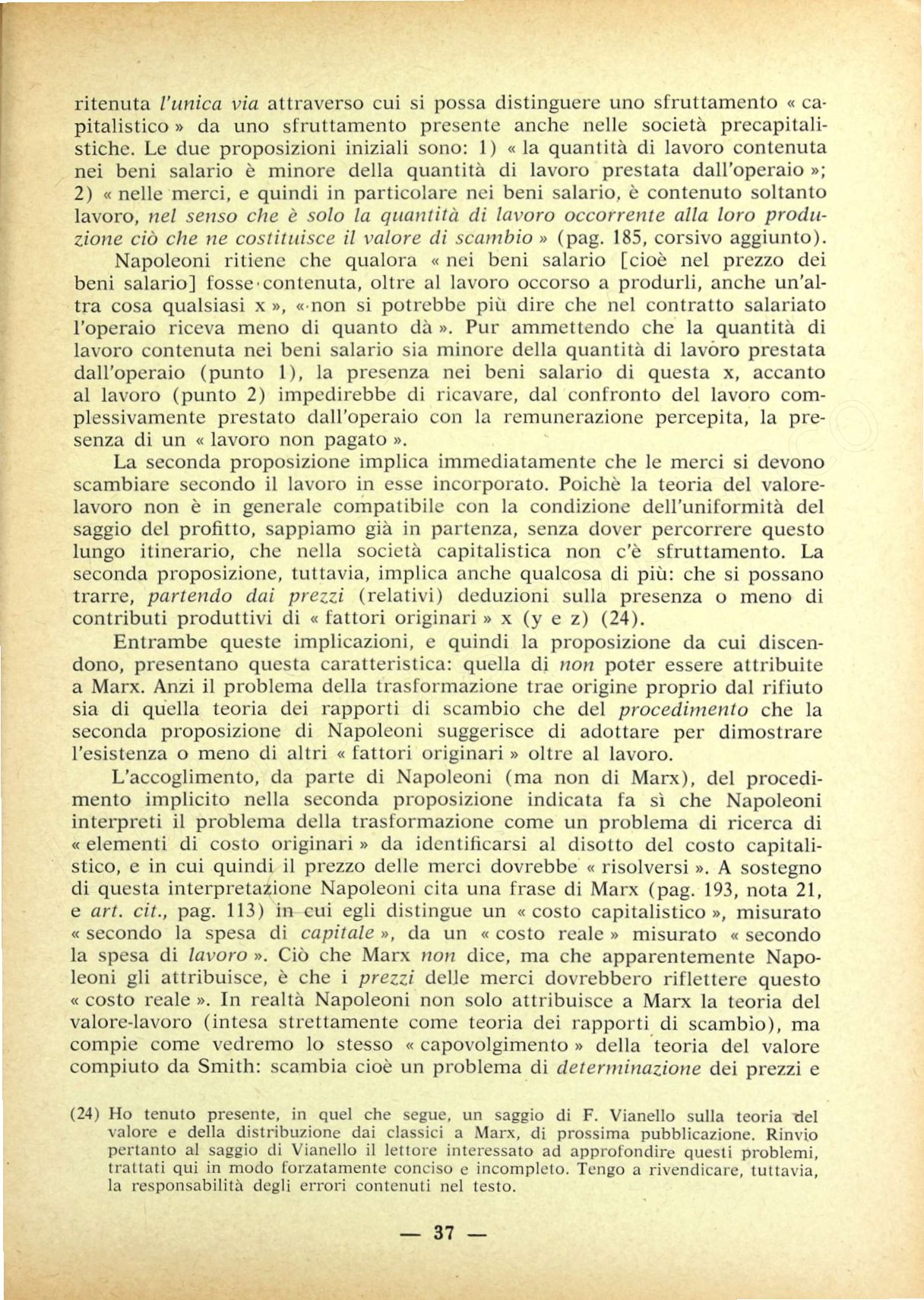
ritenuta
l'unica via
attraverso cui si possa distinguere uno sfruttamento « ca-
pitalistico » da uno sfruttamento presente anche nelle società precapitali-
stiche. Le due proposizioni iniziali sono: 1) « la quantità di lavoro contenuta
nei beni salario è minore della quantità d i lavoro prestata dall'operaio »;
2) « nelle merci, e quindi in particolare nei beni salario, è contenuto soltanto
lavoro,
nel senso che è solo la quantità d i lavoro occorrente al la loro produ-
zione ciò che ne costituisce i l valore di scambio »
(pag. 185, corsivo aggiunto).
Napoleoni ritiene che qualora « nei beni salario [cioè nel prezzo dei
beni salario] fosse contenuta, oltre al lavoro occorso a produrli, anche un'al-
tra cosa qualsiasi x », «non si potrebbe più dire che nel contratto salariato
l'operaio riceva meno d i quanto dà ». Pur ammettendo che l a quantità d i
lavoro contenuta nei beni salario sia minore della quantità di lavoro prestata
dall'operaio (punto 1 ) , l a presenza nei beni salario d i questa x , accanto
al lavoro (punto 2) impedirebbe di ricavare, dal confronto del lavoro com-
plessivamente prestato dall'operaio con l a remunerazione percepita, l a pre-
senza di un « lavoro non pagato ».
La seconda proposizione implica immediatamente che le merci si devono
scambiare secondo i l lavoro in esse incorporato. Poichè la teoria del valore-
lavoro non è in generale compatibile con l a condizione dell'uniformità del
saggio del profitto, sappiamo già in partenza, senza dover percorrere questo
lungo itinerario, che nel la società capitalistica non c'è sfruttamento. L a
seconda proposizione, tuttavia, implica anche qualcosa di più: che si possano
trarre,
partendo dai prezzi
(relativi) deduzioni sulla presenza o meno d i
contributi produttivi di « fattori originari » x ( y e z) (24).
Entrambe queste implicazioni, e quindi l a proposizione da cui discen-
dono, presentano questa caratteristica: quella di
non
poter essere attribuite
a Marx. Anzi il problema della trasformazione trae origine proprio dal rifiuto
sia d i quella teoria dei rapporti d i scambio che del
procedimento
che l a
seconda proposizione d i Napoleoni suggerisce d i adottare per dimostrare
l'esistenza o meno di altri « fattori originari » oltre al lavoro.
L'accoglimento, da parte di Napoleoni (ma non di Marx), del procedi-
mento implicito nella seconda proposizione indicata f a s ì che Napoleoni
interpreti i l problema della trasformazione come un problema di ricerca di
«elementi d i costo originari » da identificarsi a l disotto del costo capitali-
stico, e in cui quindi i l prezzo delle merci dovrebbe" « risolversi ». A sostegno
di questa interpretazione Napoleoni cita una frase di Man (pag. 193, nota 21,
e
art. cit.,
pag. 113) i ncu i egli distingue un « costo capitalistico », misurato
«secondo l a spesa d i
capitale »,
da un «costo reale » misurato « secondo
la spesa di
lavoro ».
Ciò che Marx
non
dice, ma che apparentemente Napo-
leoni gli attribuisce, è che i
prezzi
delle merci dovrebbero riflettere questo
«costo reale ». I n realtà Napoleoni non solo attribuisce a Marx la teoria del
valore-lavoro (intesa strettamente come teoria dei rapporti di scambio), ma
compie come vedremo l o stesso « capovolgimento » della 'teoria del valore
compiuto da Smith: scambia cioè un problema di
determinazione
dei prezzi e
(24) Ho tenuto presente, i n quel che segue, un saggio d i F. Vianello sulla teoria del
valore e della distribuzione dai classici a Marx, d i prossima pubblicazione. Rinvio
pertanto al saggio di Vianello i l lettore interessato ad approfondire questi problemi,
trattati qui in modo forzatamente conciso e incompleto. Tengo a rivendicare, tuttavia,
la responsabilità degli errori contenuti nel testo.
37 —
















