
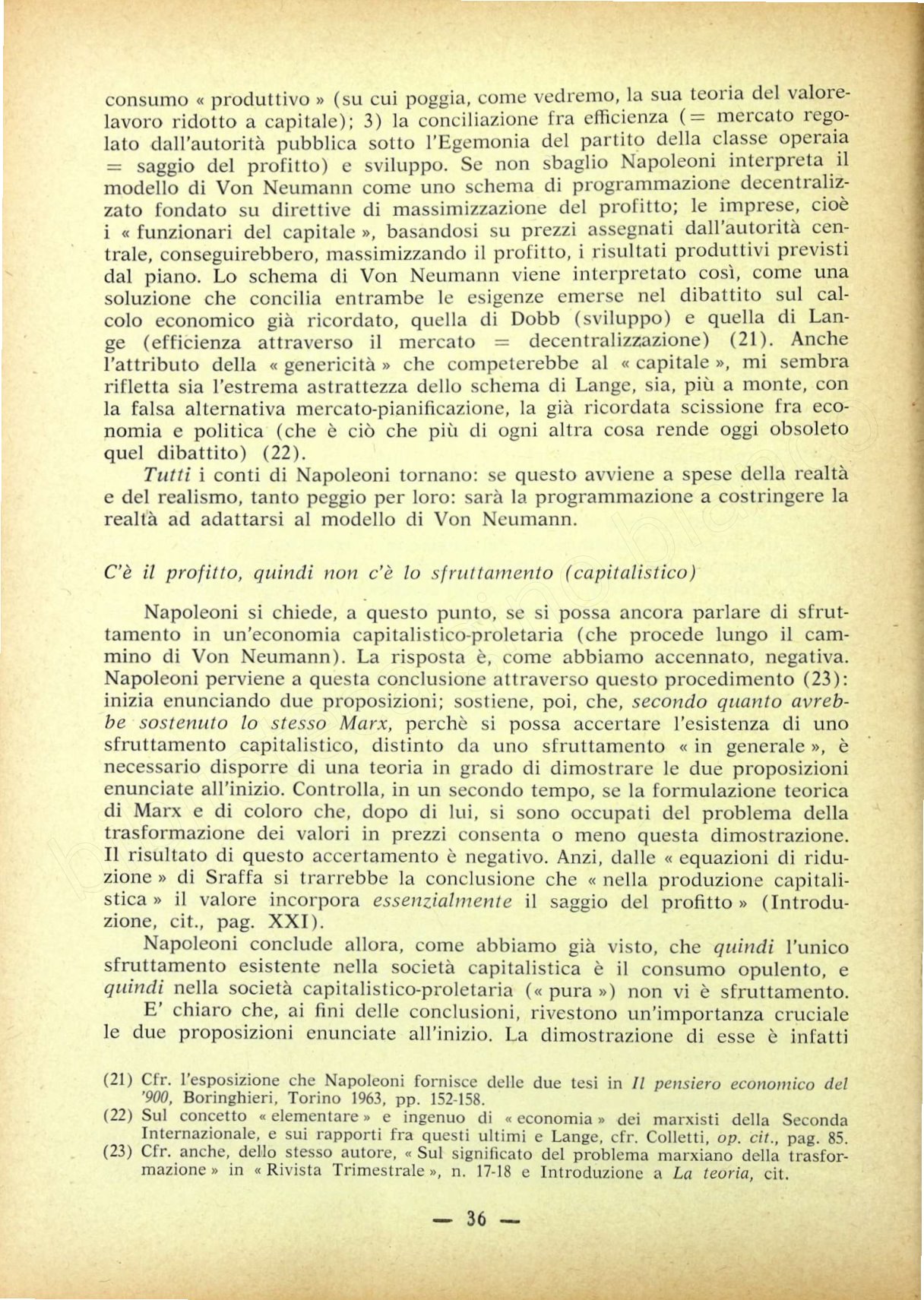
consumo « produttivo » (su cui poggia, come vedremo, la sua teoria del valore-
lavoro ridotto a capitale); 3) la conciliazione fra efficienza ( = mercato rego-
lato dall'autorità pubblica sotto l'Egemonia del partito della classe operaia
= saggio del profitto) e sviluppo. Se non sbaglio Napoleoni interpreta i l
modello di Von Neumann come uno schema di programmazione decentraliz-
zato fondato su direttive di massimizzazione del profitto; l e imprese, cioè
i « funzionari del capitale », basandosi su prezzi assegnati dall'autorità cen-
trale, conseguirebbero, massimizzando il profitto, i risultati produttivi previsti
dal piano. Lo schema di Von Neumann viene interpretato così, come una
soluzione che concilia entrambe l e esigenze emerse nel dibattito sul cal-
colo economico già ricordato, quella d i Dobb (sviluppo) e quella d i Lan-
ge (effibienza attraverso i l mercato = decentralizzazione) ( 21 ) . Anche
l'attributo della « genericità » che competerebbe a l « capitale », mi sembra
rifletta sia l'estrema astrattezza dello schema di Lange, sia, più a monte, con
la falsa alternativa mercato-pianificazione, la già ricordata scissione fra eco-
nomia e politica (che è ciò che più di ogni altra cosa rende oggi obsoleto
quel dibattito) (22) .
Tutti
i conti di Napoleoni tornano: se questo avviene a spese della realtà
e del realismo, tanto peggio per loro: sarà la programmazione a costringere la
realtà ad adattarsi al modello di Von Neumann.
C'è i l prof i tto, quindi non c'è l o sfruttamento (capital istico)
Napoleoni si chiede, a -questo punto, se si possa ancora parlare di sfrut-
tamento in un'economia capitalistico-proletaria (che procede lungo i l cam-
mino di Von Neumann). La risposta è, come abbiamo accennato, negativa.
Napoleoni perviene a questa conclusione attraverso questo procedimento (23):
inizia enunciando due proposizioni; sostiene, poi, che,
secondo quanto avreb-
be sostenuto lo stesso Marx,
perchè si possa accertare l'esistenza d i uno
sfruttamento capitalistico, distinto da uno sfruttamento « in generale », è
necessario disporre di una teoria in grado di dimostrare le due proposizioni
enunciate all'inizio. Controlla, in un secondo tempo, se la formulazione teorica
di Ma n e di coloro che, dopo di lui, si sono occupati del problema della
trasformazione dei valori in prezzi consenta o meno questa dimostrazione.
I l risultato di questo accertamento è negativo. Anzi, dalle « equazioni di ridu-
zione » di Sraffa si trarrebbe la conclusione che « nella produzione capitali-
stica » i l valore incorpora
essenzialmente
i l saggio del profitto » (Introdu-
zione, cit., pag. XX I ) .
Napoleoni conclude allora, come abbiamo già visto, che
quindi
l'unico
sfruttamento esistente nella società capitalistica è i l consumo opulento, e
quindi
nella società capitalistico-proletaria (« pura ») non vi è sfruttamento.
E' chiaro che, ai fini delle conclusioni, rivestono un'importanza cruciale
le due proposizioni enunciate all'inizio. La dimostrazione d i esse è infatti
(21) Cfr. l'esposizione che Napoleoni fornisce delle due tesi i n I l
pensiero economico del
'900,
Boringhieri, Tor ino 1963, pp. 152-158.
(22) Sul concetto « elementare)) e ingenuo d i « economia» de i marxist i del la Seconda
Internazionale, e sui rapporti f ra questi ul t imi e Lange, cf r. Colletti,
op. cit.,
pag. 85.
(23) Cf r. anche, dello stesso autore, « Sul significato del problema marxiano della trasfor-
mazione)> i n « Rivista Trimestrale », n. 17-18 e Introduzione a
La teoria, c i t .
36
















