
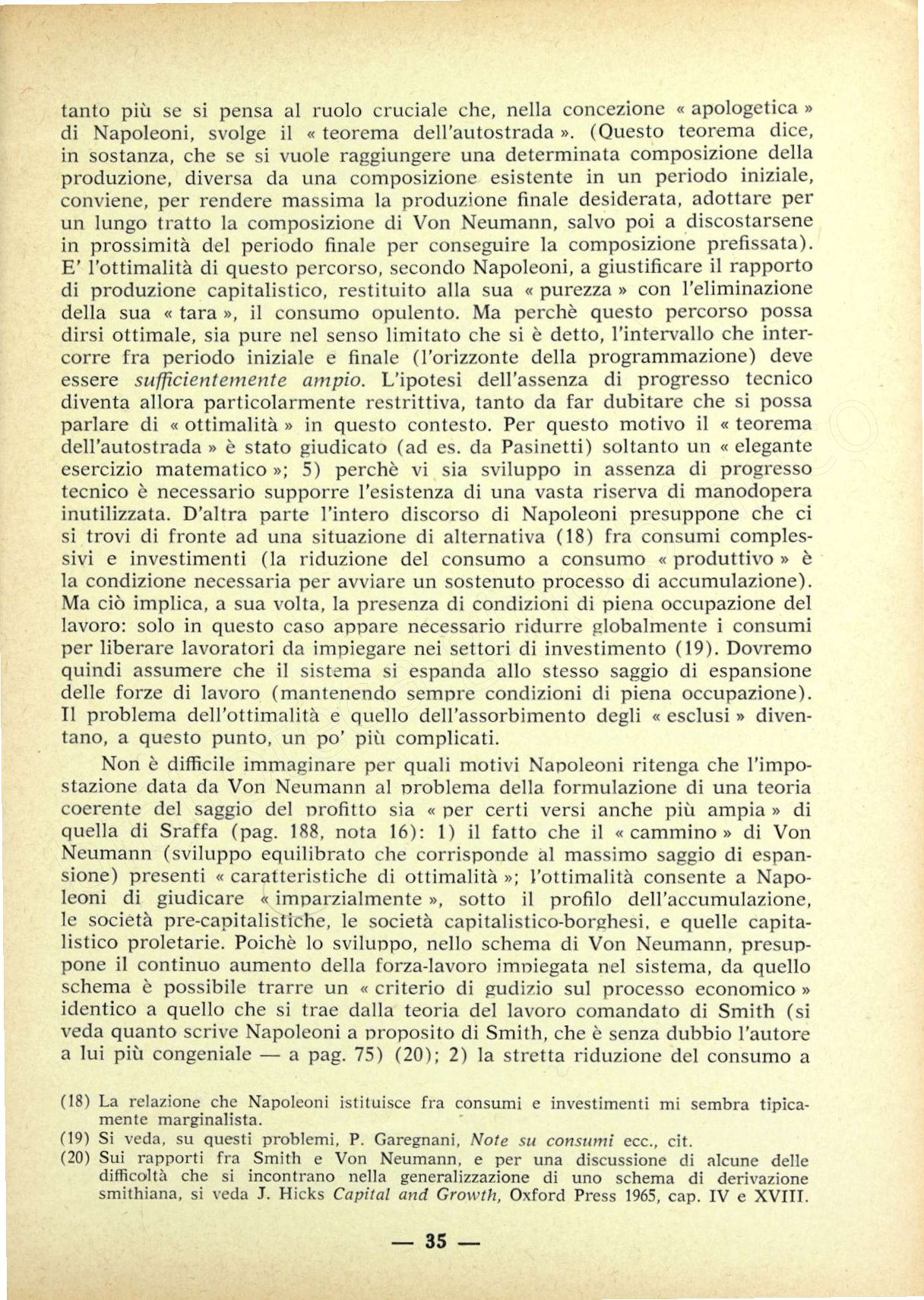
tanto più se si pensa al ruolo cruciale che, nella concezione « apologetica »
di Napoleoni, svolge i l « teorema dell'autostrada ». (Questo teorema dice,
in sostanza, che se si vuole raggiungere una determinata composizione della
produzione, diversa da una composizione esistente i n un periodo iniziale,
conviene, per rendere massima la produzione finale desiderata, adottare per
un lungo tratto la composizione di Von Neumann, salvo poi a discostarsene
in prossimità del periodo finale per conseguire la composizione prefissata).
E' l'ottimalità di questo percorso, secondo Napoleoni, a giustificare il rapporto
di produzione capitalistico, restituito alla sua « purezza » con l'eliminazione
della sua « tara », i l consumo opulento. Ma perchè questo percorso possa
dirsi ottimale, sia pure nel senso limitato che si è detto, l'intervallo che inter-
corre f ra periodo iniziale e finale (l'orizzonte della programmazione) deve
essere
sufficientemente ampio.
L'ipotesi dell'assenza d i progresso tecnico
diventa allora particolarmente restrittiva, tanto da far dubitare che si possa
parlare di « ottimalità » in questo contesto. Per questo motivo i l « teorema
dell'autostrada » è stato giudicato (ad es. da Pasinetti) soltanto un « elegante
esercizio matematico »; 5 ) perchè v i sia sviluppo i n assenza d i progresso
tecnico è necessario supporre l'esistenza di una vasta riserva di manodopera
inutilizzata. D'altra parte l'intero discorso di Napoleoni presuppone che ci
si trovi di fronte ad una situazione di alternativa (18) f ra consumi comples-
sivi e investimenti ( l a riduzione del consumo a consumo « produttivo » è
la condizione necessaria per avviare un sostenuto processo di accumulazione).
Ma ciò implica, a sua volta, la presenza di condizioni di piena occupazione del
lavoro: solo in questo caso appare necessario ridurre globalmente i consumi
per liberare lavoratori da impiegare nei settori di investimento (19). Dovremo
quindi assumere che i l sistema si espanda allo stesso saggio di espansione
delle forze di lavoro (mantenendo sempre condizioni di piena occupazione).
I l problema dell'ottimalità e quello dell'assorbimento degli « esclusi » diven-
tano, a questo punto, un po' più complicati.
Non è difficile immaginare per quali motivi Napoleoni ritenga che l'impo-
stazione data da Von Neumann al problema della formulazione di una teoria
coerente del saggio del profitto sia « per certi versi anche più ampia » d i
quella di Sraffa (pag. 188, nota 16): 1 ) i l fatto che i l « cammino » di Von
Neumann (sviluppo equilibrato che corrisponde al massimo saggio di espan-
sione) presenti « caratteristiche di ottimalità »; l'ottimalità consente a Napo-
leoni d i giudicare e imparzialmente », sotto i l profilo dell'accumulazione,
le società pre-capitalistiche, le società capitalistico-borghesi, e quelle capita-
listico proletarie. Poichè lo sviluppo, nello schema di Von Neumann, presup-
pone i l continuo aumento della forza-lavoro impiegata nel sistema, da quello
schema è possibile trarre un « criterio di gudizio sul processo economico »
identico a quello che si trae dalla teoria del lavoro comandato di Smith (si
veda quanto scrive Napoleoni a proposito di Smith, che è senza dubbio l'autore
a lui più congeniale — a pag. 75) (20); 2) la stretta riduzione del consumo a
(18) La relazione che Napoleoni istituisce f ra consumi e investimenti mi sembra tipica-
mente margrinalista.
(19) Si veda, su questi problemi, P. Garegnani,
Note su consumi ecc.,
cit.
(20) Sui rapporti f r a Smith e Von Neumann, e per una discussione d i alcune delle
difficoltà che s i incontrano nella generalizzazione d i uno schema d i derivazione
smithiana, si veda J. Hicks
Capital and Growth,
Oxford Press 1965, cap. I V e XVI I I .
35 —
















