
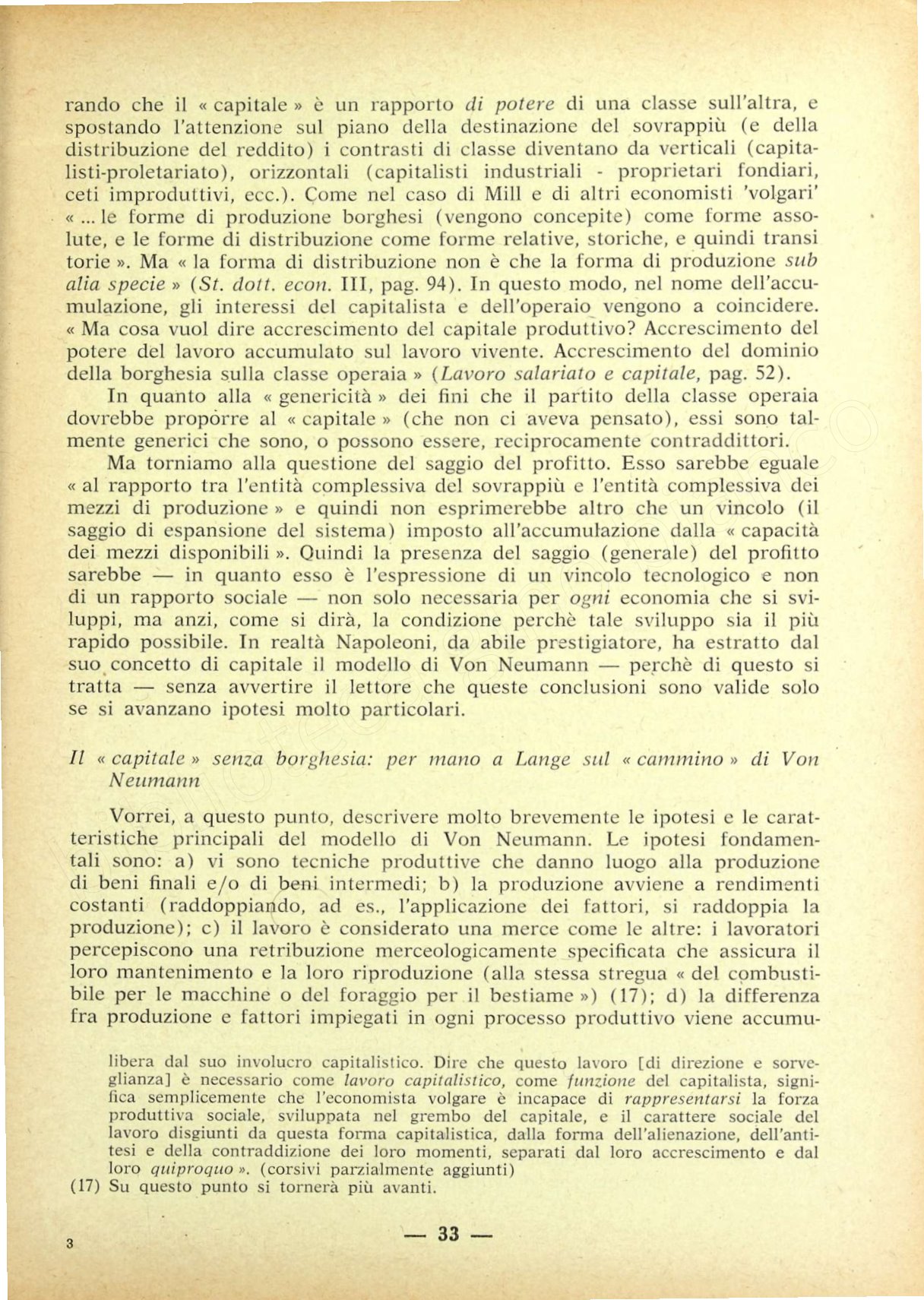
• •
rando che i l « capitale » è un rapporto
d i potere
d i una classe sul l 'altra, e
spostando l 'attenzione su l piano del la destinazione de l sovrappiù ( e del la
distribuzione del reddi to) i contrasti d i classe diventano da vertical i (capita-
l isti-proletariato), or izzontal i (capi tal ist i indust r ial i - propr ietar i fondiar i ,
ceti improdut t ivi , ecc.). Qprne nel caso d i Mi l l e d i a l t r i economisti 'volgari '
«. . . l e forme d i produzione borghesi (vengono concepite) come forme asso-
lute, e le forme di distribuzione come forme relative, storiche, e quindi transi
torie ». Ma « la forma di distribuzione non è che la forma di produzione
sub
alia specie
»
(St. dott. econ.
I I I , pag. 94). I n questo modo, nel nome dell'accu-
mulazione, g l i interessi de l capital ista e del l 'operaio vengono a coincidere.
«Ma cosa vuol dire accrescimento del capitale produttivo? Accrescimento del
potere del lavoro accumulato sul lavoro vivente. Accrescimento del dominio
della borghesia sulla classe operaia »
(Lavoro salariato
e
capitale,
pag. 52).
In quanto al la « genericità » dei f i n i che i l par t i to del la classe operaia
dovrebbe propérre a l « capitale» (che non c i aveva pensato), essi sono tal -
mente generici che sono, o possono essere, reciprocamente contraddittori.
Ma torniamo al la questione del saggio del prof i t to. Esso sarebbe eguale
«a l rapporto t ra l 'ent i tà complessiva del sovrappiù e l 'ent i tà complessiva dei
mezzi d i produzione » e quindi non esprimerebbe a l t ro che un vincolo ( i l
saggio d i espansione del sistema) imposto all'accumulazione dal la « capacità
dei mezzi disponibi l i ». Quindi la presenza del saggio (generale) de l prof i t to
sarebbe - - i n quanto esso è l'espressione d i un vincolo tecnologico e non
di un rapporto sociale — non solo necessaria per
ogni
economia che s i svi-
luppi, ma anzi, come s i di rà, l a condizione perchè tale svi luppo sia i l p i ù
rapido possibile. I n realtà Napoleoni, da abi le prestigiatore, ha estratto dal
suo. concetto d i capitale i l model lo di Von Neumann — perchè d i questo si
tratta — senza avvert ire i l let tore che queste conclusioni sono val ide solo
se s i avanzano ipotesi mol to particolari.
I l « capitale » senza borghesia: pe r mano a Lange sul « cammino » d i Von
Neumann
Vorrei, a questo punto, descrivere molto brevemente le ipotesi e le carat-
teristiche pr inc ipal i de l model lo d i Vo n Neumann. L e ipotesi fondamen-
tali sono: a ) v i sono tecniche produt t ive che danno luogo al la produzione
di beni f inal i e i o d i beni intermedi; b ) l a produzione avviene a rendimenti
costanti (raddoppiando, ad es., l 'applicazione de i fat tor i , s i raddoppia l a
produzione); c) i l lavoro è considerato una merce come le altre: i lavoratori
percepiscono una retribuzione merceologicamente specificata che assicura i l
loro mantenimento e la loro riproduzione (al la stessa stregua «del cpmbusti-
bile per le macchine o del foraggio per i l bestiame ») (17) ; d ) l a differenza
fra produzione e fat tor i impiegati in ogni processo produtt ivo viene accumu-
libera dal suo involucro capitalistico. Di re che questo lavoro [ d i direzione e sorve-
glianza] è necessario come
lavoro capitalistico,
come
funzione
del capitalista, signi-
fica semplicemente che l'economista volgare è incapace d i
rappresentarsi
l a forza
produttiva sociale, svi luppata ne l grembo de l capitale, e i l carattere sociale de l
lavoro disgiunti da questa forma capitalistica, dal la forma dell'alienazione, dell'anti-
tesi e del la contraddizione dei loro momenti, separati dal loro accrescimento e dal
loro
quiproquo ».
(corsivi parzialmente aggiunti)
(17) Su questo punto s i tornerà più avanti.
3
33
















