
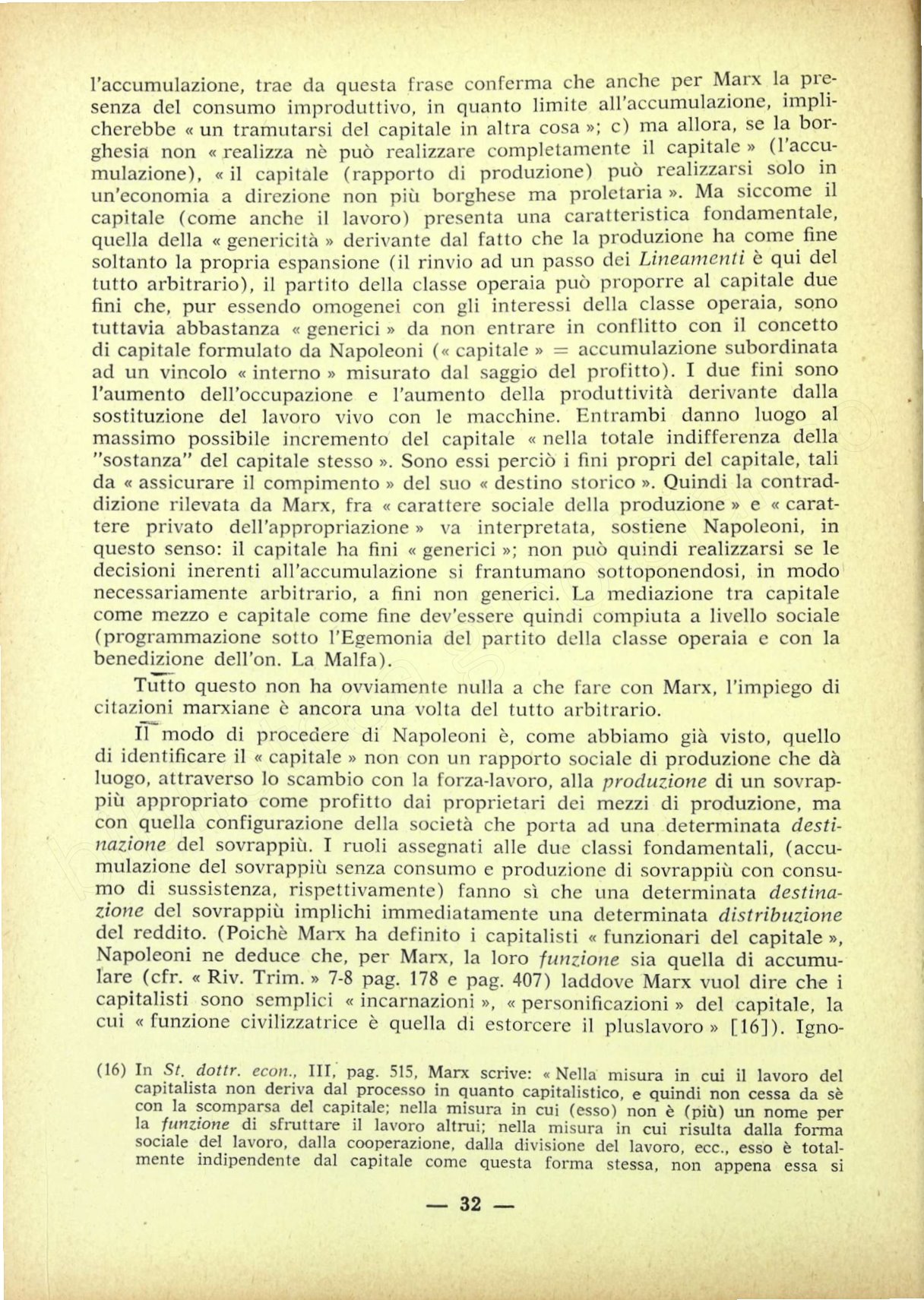
l'accumulazione, trae da questa frase conferma che anche per Marx la pre-
senza del consumo improduttivo, in quanto limite all'accumulazione, impli-
cherebbe « un tramutarsi del capitale in altra cosa »; c) ma allora, se la bor-
ghesia non « realizza nè può realizzare completamente i l capitale » (l'accu-
mulazione), « il capitale (rapporto d i produzione) può realizzarsi solo i n
un'economia a direzione non più borghese ma proletaria ». Ma siccome i l
capitale (come anche i l lavoro) presenta una caratteristica fondamentale,
quella della « genericità » derivante dal fatto che la produzione ha come fine
soltanto la propria espansione ( i l rinvio ad un passo dei
Lineamenti
è qui del
tutto arbitrario), i l partito della classe operaia può proporre al capitale due
fini che, pur essendo omogenei con gli interessi della classe operaia, sono
tuttavia abbastanza « generici » da non entrare in conflitto con i l concetto
di capitale formulato da Napoleoni (« capitale » = accumulazione subordinata
ad un vincolo « interno » misurato dal saggio del profitto). I due fini sono
l'aumento dell'occupazione e l'aumento della produttività derivante dal la
sostituzione del lavoro vivo con l e macchine. Entrambi danno luogo a l
massimo possibile incremento del capitale « nella totale indifferenza della
"sostanza" del capitale stesso ». Sono essi perciò i fini propri del capitale, tali
da « assicurare il compimento)> del suo « destino storico ». Quindi la contrad-
dizione rilevata da Marx, fra « carattere sociale della produzione » e « carat-
tere privato dell'appropriazione» v a interpretata, sostiene Napoleoni, i n
questo senso: i l capitale ha fini « generici »; non può quindi realizzarsi se le
decisioni inerenti all'accumulazione si frantumano sottoponendosi, in modo
necessariamente arbitrario, a fini non generici. La mediazione t ra capitale
come mezzo e capitale come fine dev'essere quindi compiuta a livello sociale
(programmazione sotto l'Egemonia del partito della classe operaia e con la
benedizione dell'on. La Malfa).
Tutto questo non ha ovviamente nulla a che fare con Marx, l'impiego di
citazioni marxiane è ancora una volta del tutto arbitrario.
Il modo di procedere di Napoleoni è, come abbiamo già visto, quello
di identificare il « capitale » non con un rapporto sociale di produzione che dà
luogo, attraverso lo scambio con la forza-lavoro, alla
produzione
di un sovrap-
più appropriato come profitto dai proprietari dei mezzi di produzione, ma
con quella configurazione della società che porta ad una determinata
desti-
nazione
del sovrappiù. I ruoli assegnati alle due classi fondamentali, (accu-
mulazione del sovrappiù senza consumo e produzione di sovrappiù con consu-
mo di sussistenza, rispettivamente) fanno sì che una determinata
destina-
zione
del sovrappiù implichi immediatamente una determinata
distribuzione
del reddito. (Poichè Man ha definito i capitalisti « funzionari del capitale »,
Napoleoni ne deduce che, per Marx, la loro
funzione
sia quella di accumu-
lare (cfr. « Riv. Trim. » 7-8 pag. 178 e pag. 407) laddove Marx vuol dire che i
capitalisti sono semplici « incarnazioni », «personificazioni » del capitale, l a
cui « funzione civilizzatrice è quella di estorcere i l pluslavoro » [16] ) . Igno-
(16) In
St. dottr. econ., I I I ,
pag. 515, Marx scrive: « Nella misura in cui i l lavoro del
capitalista non deriva dal processo in quanto capitalistico, e quindi non cessa da sè
con la scomparsa del capitale; nella misura in cui (esso) non è (più) un nome per
la
funzione
d i sfruttare i l lavoro altrui; nella misura i n cui risulta dalla forma
sociale del lavoro, dalla cooperazione, dalla divisione del lavoro, ecc., esso è total-
mente indipendente dal capitale come questa forma stessa, non appena essa s i
32
















