
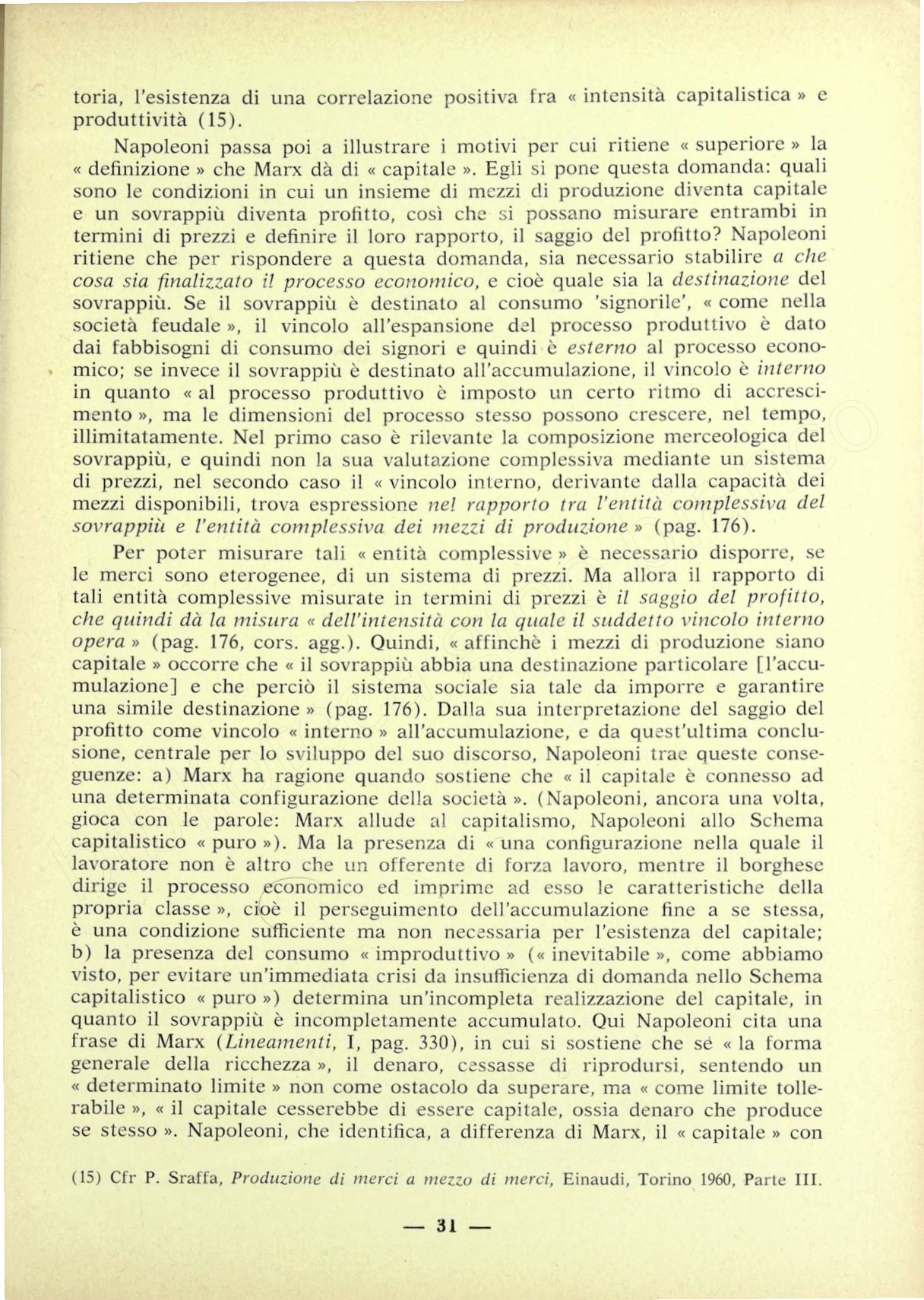
toria, l'esistenza d i una correlazione posi t iva f ra « intensità capitalistica » e
produttività (15).
Napoleoni passa poi a i l lustrare i mot ivi per cui r i t iene «superiore » l a
«definizione » che Marx dà di «capitale ». Egl i si pone questa domanda: qual i
sono le condizioni i n cui un insieme d i mezzi d i produzione diventa capitale
e un sovrappiù diventa prof i t to, così che s i possano misurare ent rambi i n
termini d i prezzi e definire i l loro rapporto, i l saggio del profitto? Napoleoni
ritiene che per rispondere a questa domanda, sia necessario stabi l ire a
che
cosa sia finalizzato i l processo economico, e cioè quale sia la destinazione del
sovrappiù. Se i l sovrappiù è destinato a l consumo 'signorile', « come nel la
società feudale », i l vincolo all'espansione de l processo produt t ivo è da t o
dai fabbisogni d i consumo dei signori e quindi ,è
esterno
al processo econo-
mico; se invece i l sovrappiù è destinato all'accumulazione, i l vincolo è
interno
in quanto « al processo produt t ivo è imposto un cer to r i tmo d i accresci-
mento », ma le dimensioni del processo stesso possono crescere, nel tempo,
illimitatamente. Nel pr imo caso è rilevante la composizione merceologica del
sovrappiù, e quindi non la sua valutazione complessiva mediante un sistema
di prezzi, nel secondo caso i l « vincolo interno, derivante dal la capacità dei
mezzi disponibi l i, trova espressione nel rapporto t ra l 'ent i tà complessiva del
sovrappiù e l 'ent i tà complessiva dei mezzi d i produzione » (pag. 176).
Per poter misurare t a l i «ent i tà complessive?> è necessario disporre, se
le merci sono eterogenee, d i un sistema d i prezzi. Ma al lora i l rapporto d i
tali •entità complessive misurate i n termini d i prezzi è
i l saggio del prof i t to,
che quindi dà la misura « dell'intensità con la quale i l suddetto vincolo interno
opera))
(pag. 176, cors. agg.). Quindi, « affinchè i mezzi d i produzione siano
capitale » occorre che « i l sovrappiù abbia una destinazione particolare [l'accu-
mulazione] e che perciò i l sistema sociale sia tale da imporre e garantire
una simi le destinazione » (pag. 176). Dal la sua interpretazione del saggio del
profitto come vincolo « interno » all'accumulazione, e da quest'ultima conclu-
sione, centrale per lo sviluppo del suo discorso, Napoleoni trae queste conse-
guenze: a ) Marx ha ragione quando sostiene che « i l capitale è connesso ad
una determinata configurazione della società ». (Napoleoni, ancora una volta,
gioca con l e parole: Ma r x al lude a l capital ismo, Napoleoni a l l o Schema
capitalistico «puro »). Ma l a presenza d i « una configurazione nel la quale i l
lavoratore non è al t ro che un offerente d i forza lavoro, mentre i l borghese
dirige i l processo g f a om i c o ed impr ime ad esso l e caratteristiche del la
propria classe », cioè i l perseguimento dell'accumulazione f ine a se stessa,
è una condizione sufficiente ma non necessaria per l'esistenza del capitale;
b) l a presenza del consumo « improduttivo » (« inevitabile », come abbiamo
visto, per evitare un'immediata crisi da insufficienza di domanda nello Schema
capitalistico « puro ») determina un' incompleta realizzazione del capitale, i n
quanto i l sovrappiù è incompletamente accumulato. Qui Napoleoni ci ta una
frase d i Marx
(Lineamenti,
I , pag. 330), i n cui si sostiene che se « la forma
generale del la ricchezza », i l denaro, cessasse d i r iprodursi , sentendo u n
«determinato l imi te » non come ostacolo da superare, ma «come l imi te tolle-
rabile », « i l capitale cesserebbe d i essere capitale, ossia denaro che produce
se stesso ». Napoleoni, che identifica, a differenza di Marx, i l « capitale » con
(15) Cfr P. Sraffa,
Produzione di merci
a mezzo
di merci,
Einaudi, Torino 1960, Parte I I I .
31
















