
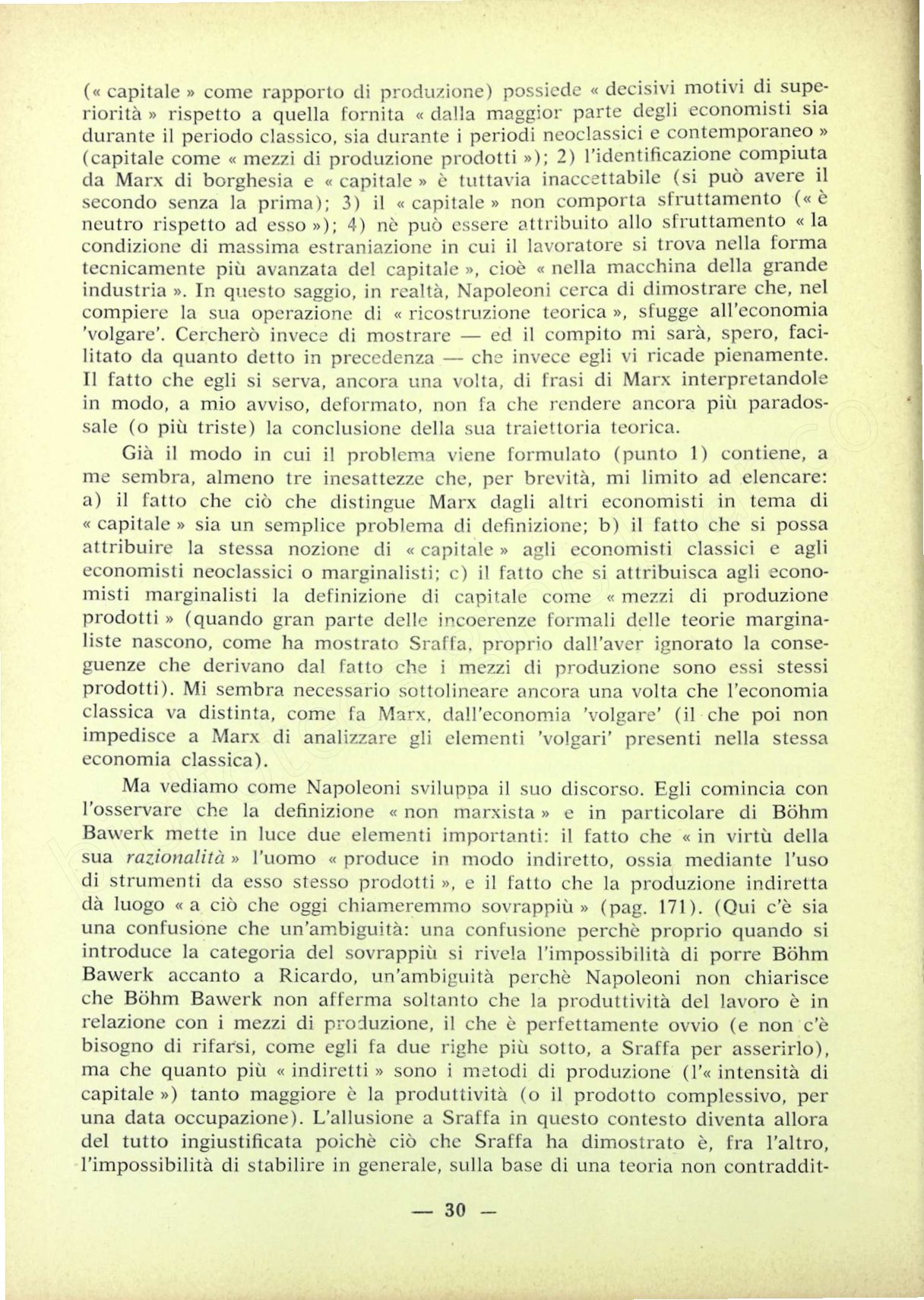
(« capitale » come rapporto di produzione) possiede «decisivi mot ivi di s u i ,
riorità » rispetto a quella forni ta « dalla maggior parte degl i economisti sia
durante i l periodo classico, sia durante i periodi neoclassici e contemporaneo)>
(capitale come (<mezzi di produzione prodotti »); 2) l'identificazione compiuta
da Marx d i borghesia e « capitale » è tuttavia inaccettabile ( s i può avere i l
secondo senza l a pr ima) ; 3 ) i l « capitale » non comporta sfruttamento (« è
neutro rispetto ad esso »); 4) nè può essere at tr ibui to al lo sfruttamento « la
condizione di massima estraniazione in cui i l lavoratore si trova nella forma
tecnicamente p i ù avanzata del capitale », cioè « nella macchina del la grande
industria ». I n questo saggio, in realtà, Napoleoni cerca di dimostrare che, nel
compiere l a sua operazione d i « ricostruzione teorica », sfugge all'economia
'volgare'. Cercherò invece d i mostrare — ed i l compi to mi sarà, spero, faci-
litato da quanto detto in precedenza — che invece egli vi ricade pienamente.
I l fat to che egli si serva, ancora una volta, d i frasi d i Marx interpretandole
in modo, a mi o avviso, deformato, non f a che rendere ancora p i ù parados-
sale ( o più triste) l a conclusione della sua traiettoria teorica.
Già i l modo i n cu i i l problema viene formulato (punto 1) contiene, a
me sembra, almeno t re inesattezze che, per brevità, m i l imi t o ad elencare:
a) i l f a t t o che c i ò che distingue Ma r x dagl i a l t r i economisti i n tema d i
«capitale » sia un semplice problema d i definizione; b ) i l fat to che si possa
attribuire l a stessa nozione d i « capitale » ag l i economisti classici e ag l i
economisti neoclassici o marginalisti; c) i l fat to che si attribuisca agli econo-
misti marginal ist i l a definizione d i capi tale come « mezzi d i produzione
prodotti » (quando gran parte delle incoerenze formal i delle teorie margina-
liste nascono, come ha mostrato Sraffa, propr io dall 'aver ignorato la conse-
guenze che derivano da l fat to che i mezzi d i produzione sono essi stessi
prodotti). Mi sembra necessario sottolineare ancora una volta che l'economia
classica va distinta, come f a Marx, dall'economia 'volgare' ( i l che po i non
impedisce a Mar x d i analizzare g l i elementi 'volgar i ' present i nel la stessa
economia classica).
Ma vediamo come Napoleoni sviluppa i l suo discorso. Egl i comincia con
l'osservare che l a definizione « n o n marxista» e i n part icolare d i B5hm
Bawerk mette i n luce due elementi important i : i l fat to che « in v i r t ù del la
sua
razional ità
» l 'uomo « produce i n modo indi ret to, ossia mediante l 'uso
di strument i da esso stesso prodot t i », e i l fat to che la produzione indi ret ta
dà luogo « a ciò che oggi chiameremmo sovrappiù » (pag. 171). (Qui c'è sia
una confusione che un'ambiguità: una confusione perchè propr io quando si
introduce l a categoria del sovrappiù si rivela l ' impossibi l ità d i porre B5hm
Bawerk accanto a Ricardo, un'ambigui tà perchè Napoleoni non chiarisce
che Bi ihm Bawerk non afferma soltanto che la produt t ivi tà del lavoro è i n
relazione con i mezzi d i produzione, i l che è perfettamente ovvio (e non c'è
bisogno d i ri farsi , come egl i fa due righe p i ù sotto, a Sraffa per asserirlo),
ma che quanto più « indirett i » sono i metodi d i produzione ( l '« intensità d i
capitale ») tanto maggiore è l a produt t ivi tà ( o i l prodot to complessivo, per
una data occupazione). L'allusione a Sraffa in questo contesto diventa al lora
del t u t t o ingiustificata poichè c i ò che Sraffa ha dimostrato è, f r a l 'al t ro,
l'impossibilità di stabilire in generale, sulla base di una teoria non contraddit-
- 30 —
















