
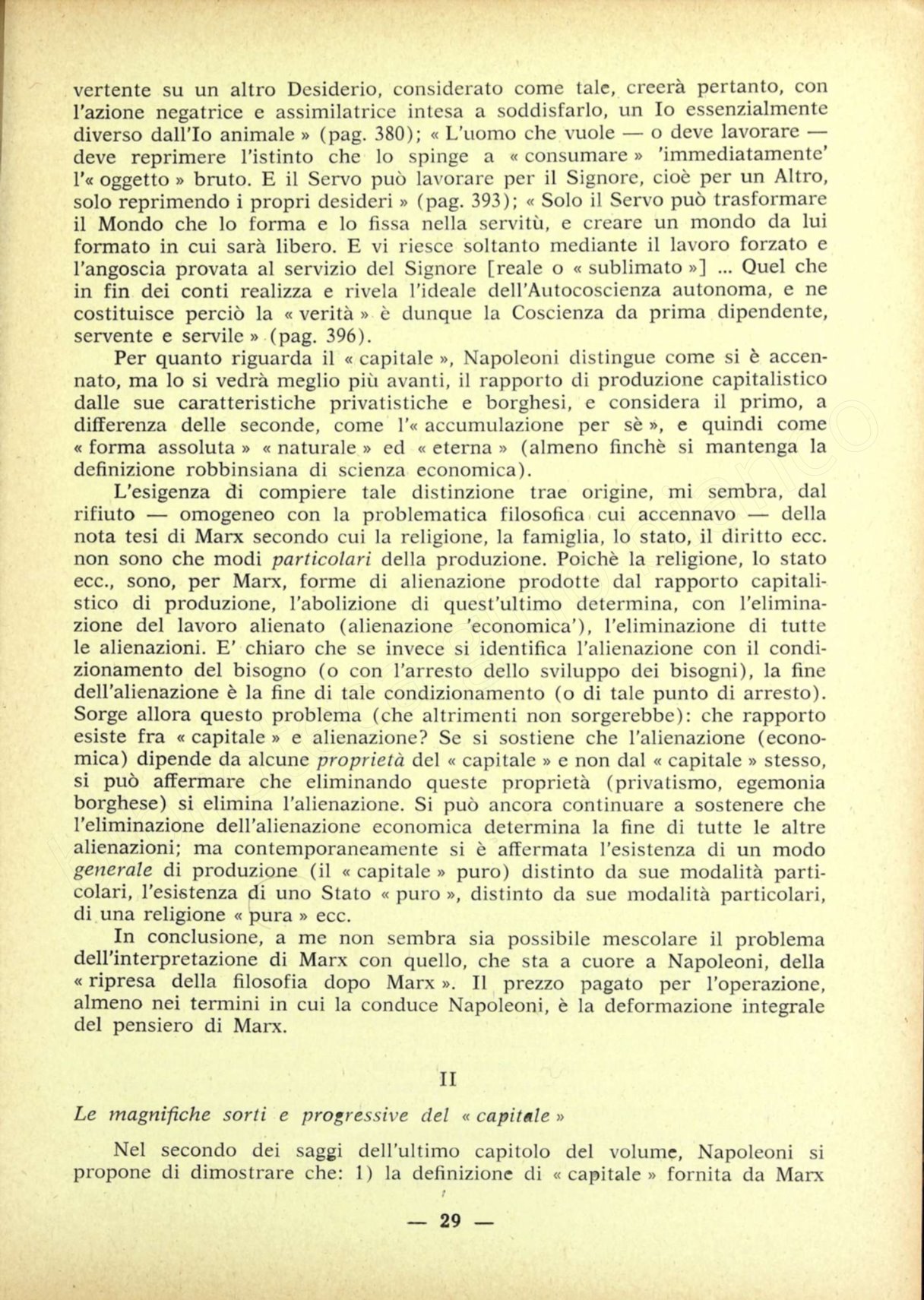
vertente su un altro Desiderio, considerato come tale, creerà pertanto, con
l'azione negatrice e assimilatrice intesa a soddisfarlo, un I o essenzialmente
diverso dall'Io animale » (pag. 380); « L'uomo che vuole — o deve lavorare —
deve reprimere l'istinto che l o spinge a « consumare » 'immediatamente'
l'« oggetto » bruto. E i l Servo può lavorare per i l Signore, cioè per un Altro,
solo reprimendo i propri desideri » (pag. 393); « Solo il Servo può trasformare
il Mondo che lo forma e lo fissa nella servitù, e creare un mondo da lui
formato in cui sarà libero. E vi riesce soltanto mediante i l lavoro forzato e
l'angoscia provata al servizio del Signore [reale o « sublimato »] ... Quel che
in f in dei conti realizza e rivela l'ideale dell'Autocoscienza autonoma, e ne
costituisce perciò la « verità » è dunque la Coscienza da prima dipendente,
servente e servile » (pag. 396).
Per quanto riguarda i l « capitale », Napoleoni distingue come si è accen-
nato, ma lo si vedrà meglio più avanti, il rapporto di produzione capitalistico
dalle sue caratteristiche privatistiche e borghesi, e considera i l primo, a
differenza delle seconde, come l '« accumulazione per se », e quindi come
« forma assoluta » « naturale » ed «eterna » (almeno finchè si mantenga la
definizione robbinsiana di scienza economica).
L'esigenza a i compiere tale distinzione t rae origine, m i sembra, da l
rifiuto — omogeneo con l a problematica filosofica . cui accennavo — della
nota tesi di Marx secondo cui la religione, la famiglia, lo stato, i l diritto ecc.
non sono che modi
particolari
della produzione. Poiché la religione, lo stato
ecc., sono, per Man , forme d i alienazione prodotte dal rapporto capitali-
stico d i produzione, l'abolizione d i quest'ultimo determina, con l'elimina-
zione del lavoro alienato (alienazione 'economica'), l'eliminazione d i tutte
le alienazioni. E chiaro che se invece si identifica l'alienazione con i l condi-
zionamento del bisogno ( o con l'arresto dello sviluppo dei bisogni), la fine
dell'alienazione è la fine di tale condizionamento (o di tale punto di arresto).
Sorge allora questo problema (che altrimenti non sorgerebbe): che rapporto
esiste f ra « capitale » e alienazione? Se si sostiene che l'alienazione (econo-
mica) dipende da alcune
proprietà
del « capitale » e non dal « capitale » stesso,
si può affermare che eliminando queste proprietà (pr iva tismo, egemonia
borghese) si elimina l'alienazione. Si può ancora continuare a sostenere che
l'eliminazione dell'alienazione economica determina la fine di tutte le altre
alienazioni; ma contemporaneamente si è affermata l'esistenza di un modo
generale
di produzione ( i l « capitale» puro) distinto da sue modalità parti-
colari, l'esistenza di uno Stato « puro », distinto da sue modalità particolari,
di. una religione « Pura » ecc.
In conclusione, a me non sembra sia possibile mescolare i l problema
dell'interpretazione di Marx con quello, che sta a cuore a Napoleoni, della
«ripresa del la filosofia dopo Marx ». I l prezzo pagato pe r l'operazione,
almeno nei termini in cui la conduce Napoleoni, è la deformazione integrale
del pensiero di Man .
Le magnifiche sorti e progressive del «capitole »
Nel secondo de i saggi dell'ultimo capitolo de l volume, Napoleoni s i
propone di dimostrare che: 1) l a definizione di « capitale » fornita da Marx
t
— 29 —
















