
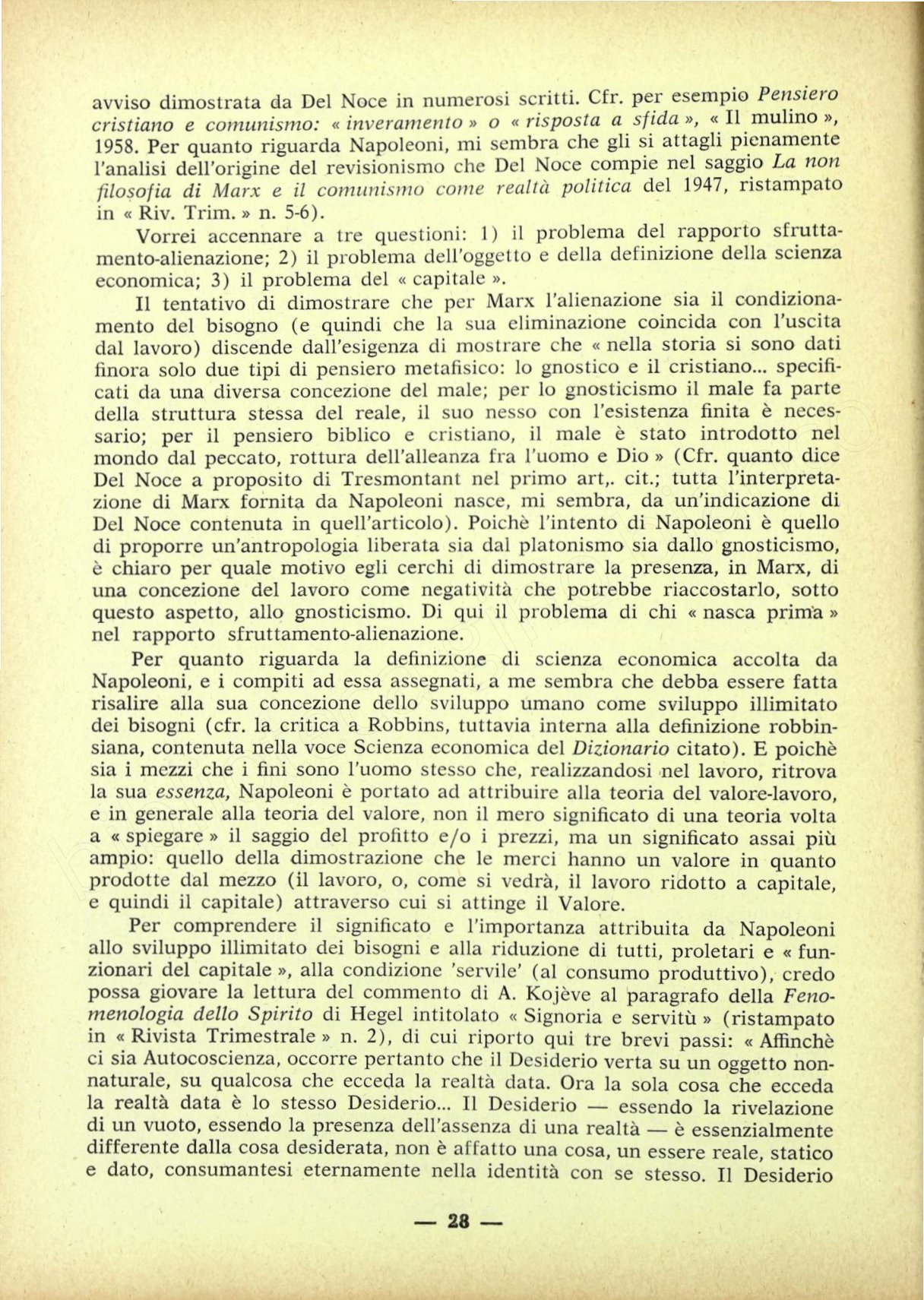
avviso dimostrata da Del Noce in numerosi scritti. Cfr. per esempio
Pensiero
cristiano e comunismo: « inveramento » o « risposta a sf ida », «
I l mulino »,
1958. Per quanto riguarda Napoleoni, mi sembra che gli si attagli pienamente
l'analisi dell'origine del revisionismo che Del Noce compie nel saggio
La non
filosofia d i Marx e i l comunismo come real tà pol i t ica
del 1947, ristampato
in « Riv. Trim. » n. 5-6).
Vorrei accennare a tre questioni: 1 ) i l problema del rapporto sfrutta-
mento-alienazione; 2) i l problema dell'oggetto e della definizione della scienza
economica; 3) i l problema del « capitale ».
I l tentativo di dimostrare che per Marx l'alienazione sia i l condiziona-
mento del bisogno ( e quindi che la sua eliminazione coincida con l'uscita
dal lavoro) discende dall'esigenza di mostrare che « nella storia si sono dati
finora solo due tipi di pensiero metafisico: lo gnostico e i l cristiano.., specifi-
cati da una diversa concezione del male; per lo gnosticismo i l male fa parte
della struttura stessa del reale, i l suo nesso con l'esistenza finita è neces-
sario; pe r i l pensiero biblico e cristiano, i l male è stato introdotto nel
mondo dal peccato, rottura dell'alleanza fra l'uomo e Dio » (Cfr. quanto dice
Del Noce a proposito di Tresmontant nel primo art,. cit.; tutta l'interpreta-
zione di Marx fornita da Napoleoni nasce, mi sembra, da un'indicazione d i
Del Noce contenuta in quell'articolo). Poichè l'intento di Napoleoni è quello
di proporre un'antropologia liberata sia dal platonismo sia dallo gnosticismo,
è chiaro per quale motivo egli cerchi di dimostrare la presenza, in Marx, di
una concezione del lavoro come negatività che potrebbe riaccostarlo, sotto
questo aspetto, allo gnosticismo. Di qui i l problema di chi « nasca prirria »
nel rapporto sfruttamento-alienazione.
Per quanto riguarda l a definizione d i scienza economica accolta da
Napoleoni, e i compiti ad essa assegnati, a me sembra che debba essere fatta
risalire alla sua concezione dello sviluppo umano come sviluppo illimitato
dei bisogni (cfr. la critica a Robbins, tuttavia interna alla definizione robbin-
siana, contenuta nella voce Scienza economica del
Dizionario
citato). E poichè
sia i mezzi che i fini sono l'uomo stesso che, realizzandosi 'nel lavoro, ritrova
la sua
essenza,
Napoleoni è portato ad attribuire alla teoria del valore-lavoro,
e in generale alla teoria del valore, non il mero significato di una teoria volta
a « spiegare » i l saggio del profitto e/o i prezzi, ma un significato assai più
ampio: quello della dimostrazione che le merci hanno un valore in quanto
prodotte dal mezzo ( i l lavoro, o, come si vedrà, i l lavoro ridotto a capitale,
e quindi i l capitale) attraverso cui si attinge i l Valore.
Per comprendere i l significato e l'importanza 'attribuita da Napoleoni
allo sviluppo illimitato dei bisogni e alla riduzione di tutti, proletari e « fun-
zionari del capitale », alla condizione 'servile' (al consumo produttivo), credo
possa giovare la lettura del commento di A. Kojève al paragrafo della
Feno-
menologia dello Spirito
di Hegel intitolato « Signoria e servitù » (ristampato
in « Rivista Trimestrale » n. 2), di cui riporto qui tre brevi passi: « Affinchè
ci sia Autocoscienza, occorre pertanto che il Desiderio verta su un oggetto non-
naturale, su qualcosa che ecceda la realtà data. Ora la sola cosa che ecceda
la realtà data è lo stesso Desiderio... I l Desiderio — essendo la rivelazione
di un vuoto, essendo la presenza dell'assenza di una realtà — è essenzialmente
differente dalla cosa desiderata, non è affatto una cosa, un essere reale, statico
e dato, consumantesi eternamente nella identità con se stesso. I l Desiderio
28
















