
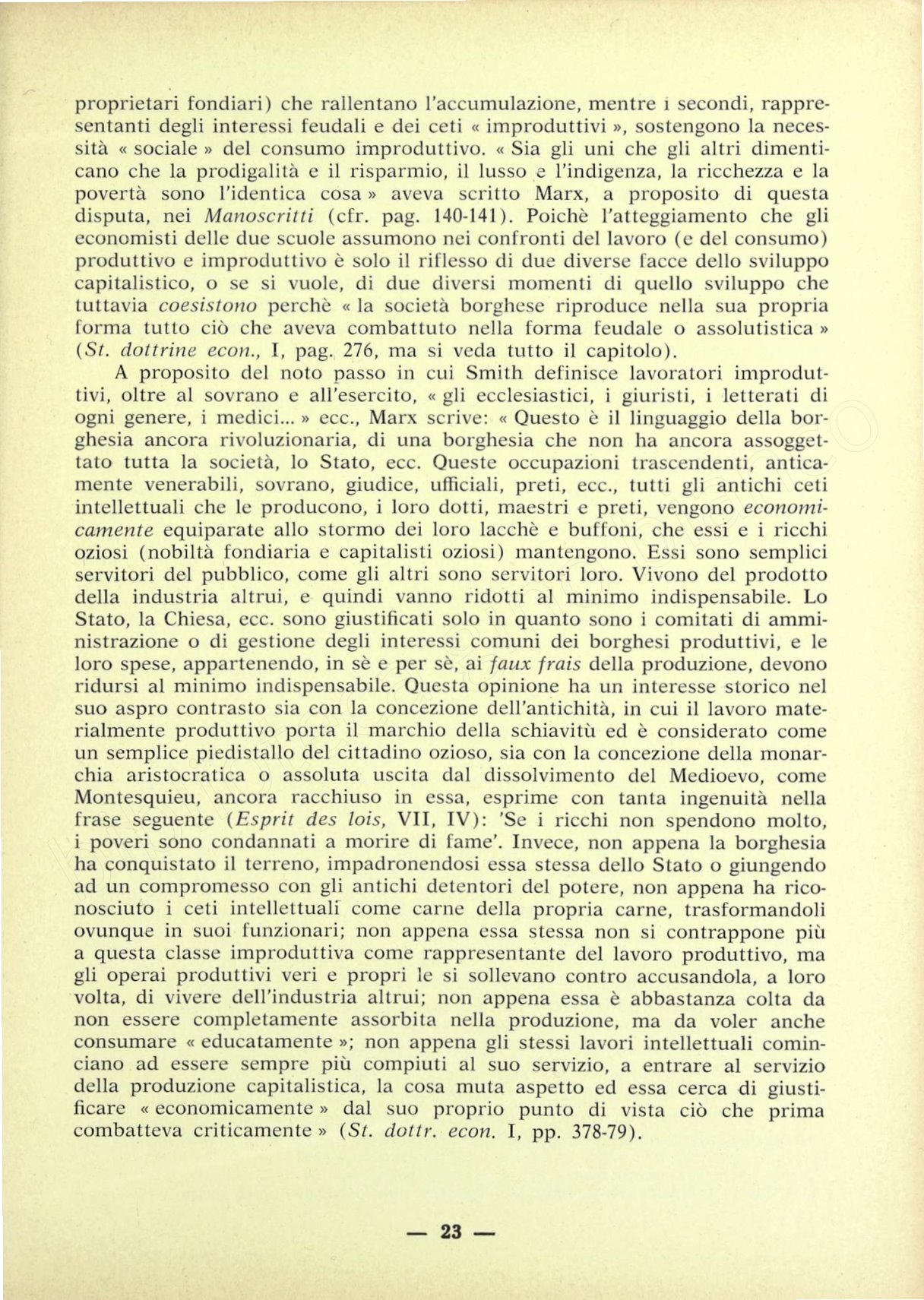
proprietari fondiari) che rallentano l'accumulazione, mentre i secondi, rappre-
sentanti degli interessi feudali e dei ceti « improduttivi », sostengono la neces-
sità « sociale » del consumo improduttivo. « Sia gli uni che gli altri dimenti-
cano che la prodigalità e i l risparmio, i l lusso e l'indigenza, la ricchezza e la
povertà sono l'identica cosa » aveva scritto Marx, a proposito d i questa
disputa, nei
Manoscritti
(cf r. pag. 140-141). Poichè l'atteggiamento che gl i
economisti delle due scuole assumono nei confronti del lavoro (e del consumo)
produttivo e improduttivo è solo il riflesso di due diverse facce dello sviluppo
capitalistico, o se si vuole, d i due diversi momenti di quello sviluppo che
tuttavia
coesistono
perchè « la società borghese riproduce nella sua propria
forma tutto ciò che aveva combattuto nella forma feudale o assolutistica »
(St. dottrine econ.,
I , pag. 276, ma si veda tutto i l capitolo).
A proposito del noto passo in cui Smith definisce lavoratori improdut-
tivi, oltre al sovrano e all'esercito, « gli ecclesiastici, i giuristi, i letterati di
ogni genere, i medici... » ecc., Ma n scrive: « Questo è i l linguaggio della bor-
ghesia ancora rivoluzionaria, di una borghesia che non ha ancora assogget-
tato tutta la società, lo Stato, ecc. Queste occupazioni trascendenti, antica-
mente venerabili, sovrano, giudice, ufficiali, preti, ecc., tutti gli antichi ceti
intellettuali che le producono, i loro dotti, maestri e preti, vengono
economi-
camente
equiparate allo stormo dei loro lacchè e buffoni, che essi e i ricchi
oziosi (nobiltà fondiaria e capitalisti oziosi) mantengono. Essi sono semplici
servitori del pubblico, come gli altri sono servitori loro. Vivono del prodotto
della industria altrui, e quindi vanno ridotti a l minimo indispensabile. Lo
Stato, la Chiesa, ecc. sono giustificati solo in quanto sono i comitati di ammi-
nistrazione o di gestione degli interessi comuni dei borghesi produttivi, e le
loro spese, appartenendo, in sè e per sè, ai
faux frais
della produzione, devono
ridursi al minimo indispensabile. Questa opinione ha un interesse storico nel
suo aspro contrasto sia con la concezione dell'antichità, in cui il lavoro mate-
rialmente produttivo porta i l marchio della schiavitù ed è considerato come
un semplice piedistallo del cittadino ozioso, sia con la concezione della monar-
chia aristocratica o assoluta uscita dal dissolvimento del Medioevo, come
Montesquieu, ancora racchiuso i n essa, esprime con tanta ingenuità nella
frase seguente
(Esprit des bis,
V I I , I V) : 'Se i ricchi non spendono molto,
i poveri sono condannati a morire di fame'. Invece, non appena la borghesia
ha conquistato il terreno, impadronendosi essa stessa dello Stato o giungendo
ad un compromesso con gli antichi detentori del potere, non appena ha rico-
nosciuto i ceti intellettuali come carne della propria carne, trasformandoli
ovunque in suoi funzionari; non appena essa stessa non si contrappone più
a questa classe improduttiva come rappresentante del lavoro produttivo, ma
gli operai produttivi veri e propri le si sollevano contro accusandola, a loro
volta, di vivere dell'industria altrui; non appena essa è abbastanza colta da
non essere completamente assorbita nella produzione, ma da voler anche
consumare « educatamente »; non appena gli stessi lavori intellettuali comin-
ciano ad essere sempre più compiuti al suo servizio, a entrare a l servizio
della produzione capitalistica, la cosa muta aspetto ed essa cerca di giusti-
ficare «economicamente » da l suo proprio punto d i vista ciò che prima
combatteva criticamente »
(St. dottr. econ.
I , pp. 378-79).
















