
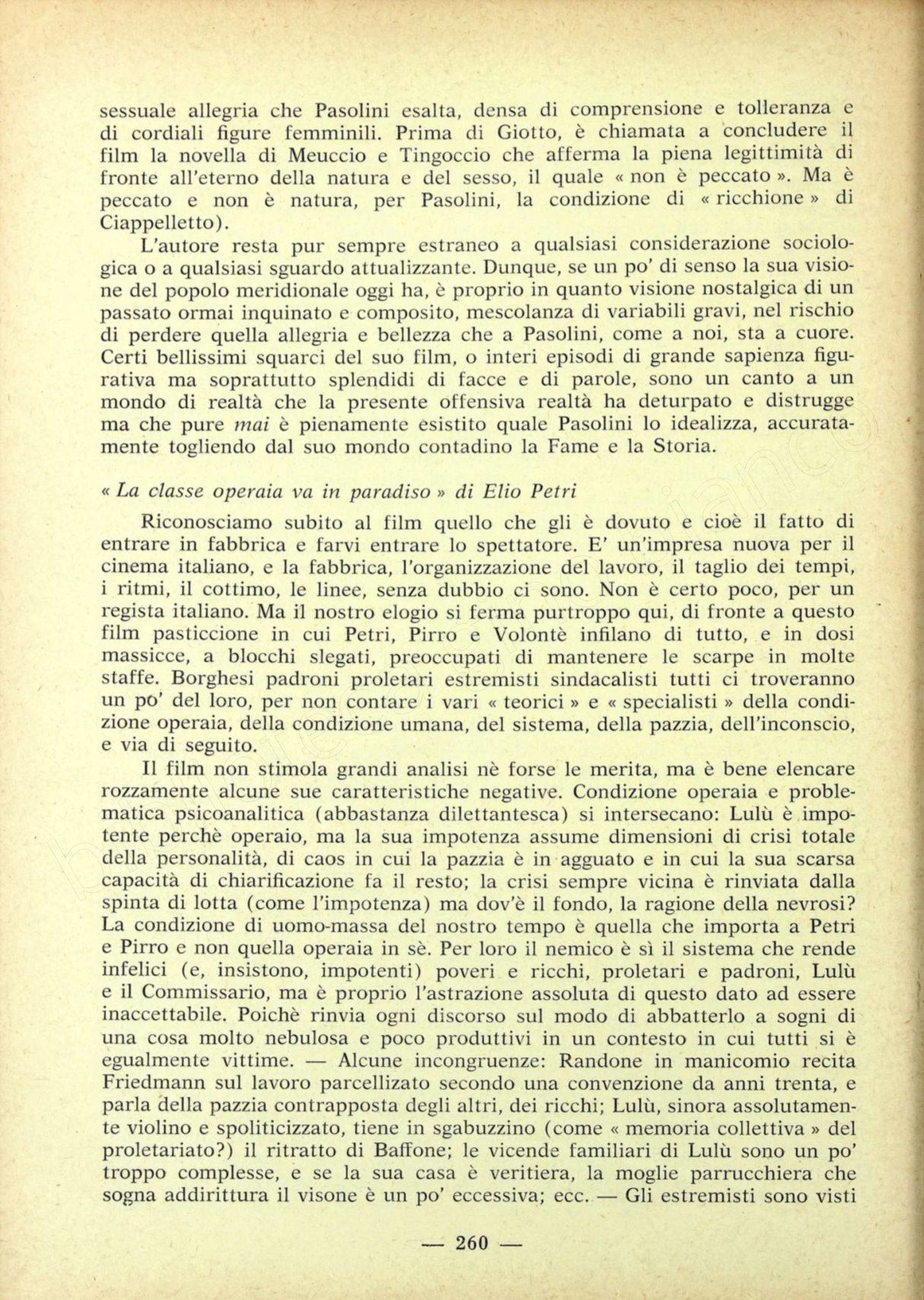
sessuale al legria che Pasol ini esalta, densa d i comprensione e tol leranza e
di cordial i f igure femmini l i . Pr ima d i Giot to, è chiamata a 'concludere i l
f i lm l a novella d i Meuccio e Tingoccio che afferma l a piena legi t t imi tà d i
fronte al l 'eterno del la natura e del sesso, i l quale « non è peccato ». Ma è
peccato e n o n è natura, p e r Pasol ini , l a condizione d i « ricchione » d i
Ciappelletto).
L'autore resta p u r sempre estraneo a qualsiasi considerazione sociolo-
gica o a qualsiasi sguardo attualizzante. Dunque, se un po' di senso la sua visio-
ne del popolo meridionale oggi ha, è proprio in quanto visione nostalgica di un
passato ormai inquinato e composito, mescolanza di variabi l i gravi, nel rischio
di perdere quel la allegria e bellezza che a Pasolini, come a noi, sta a cuore.
Certi bellissimi squarci del suo f i lm, o inter i episodi di grande sapienza figu-
rativa ma soprat tut to splendidi d i facce e d i parole, sono u n canto a u n
mondo d i real tà che l a presente offensiva real tà ha deturpato e distrugge
ma che pure
mai
è pienamente esistito quale Pasolini l o idealizza, accurata-
mente togliendo dal suo mondo contadino la Fame e la Storia.
«La classe operaia va in paradiso'> d i El io Petr i
Riconosciamo subi to a l f i l m quel lo che g l i è dovuto e cioè i l fat to d i
entrare i n fabbrica e farvi entrare l o spettatore. E ' un' impresa nuova per i l
cinema italiano, e la fabbrica, l'organizzazione del lavoro, i l tagl io dei tempi,
i r i tmi , i l cottimo, le linee, senza dubbio c i sono. Non è certo poco, per un
regista italiano. Ma i l nostro elogio si ferma purtroppo qui, di fronte a questo
f i lm pasticcione i n cu i Pet r i , Pi r ro e Volontè inf i lano d i tut to, e i n dos i
massicce, a blocchi slegati, preoccupati d i mantenere l e scarpe i n mo l t e
staffe. Borghesi padroni proletar i estremisti sindacalisti t u t t i c i troveranno
un po' del loro, per non contare i var i « teorici » e « specialisti » del la condi-
zione operaia, della condizione umana, del sistema, della pazzia, dell'inconscio,
e via d i seguito.
I l f i lm non stimola grandi analisi nè forse le merita, ma è bene elencare
rozzamente alcune sue caratteristiche negative. Condizione operaia e proble-
matica psicoanalitica (abbastanza dilettantesca) s i intersecano: Lu l ù è impo-
tente perchè operaio, ma la sua impotenza assume dimensioni d i cr isi totale
della personalità, d i caos i n cui la pazzia è i n -agguato e i n cui la sua scarsa
capacità d i chiarificazione f a i l resto; l a cr isi sempre vicina è r inviata dal la
spinta di lotta (come l'impotenza) ma dov'è i l fondo, la ragione della nevrosi?
La condizione d i uomo-massa del nostro tempo è quel la che impor ta a Petr i
e Pirro e non quella operaia in sè. Per loro i l nemico è sì i l sistema che rende
infelici (e, insistono, impotent i ) pover i e r icchi , proletar i e padroni , Lu l ù
e i l Commissario, ma è propr io l'astrazione assoluta di questo dato ad essere
inaccettabile. Poichè r invia ogni discorso sul modo d i abbatterlo a sogni d i
una cosa mol to nebulosa e poco produt t ivi i n un contesto i n cu i t u t t i s i è
egualmente vi t t ime. — Alcune incongruenze: Randone i n manicomio reci ta
Friedmann sul lavoro parcellizato secondo una convenzione da anni trenta, e
parla della pazzia contrapposta degli altri, dei ricchi; Lulù, sinora assolutamen-
te violino e spoliticizzato, tiene in sgabuzzino (come « memoria collettiva » del
proletariato?) i l r i t rat to d i Barone; le vicende fami l iar i d i Lulù sono un po'
troppo complesse, e se l a sua casa è veritiera, l a mogl ie parrucchiera che
sogna addi r i t tura i l visone è un po' eccessiva; ecc. G l i estremisti sono vist i
— 260
















